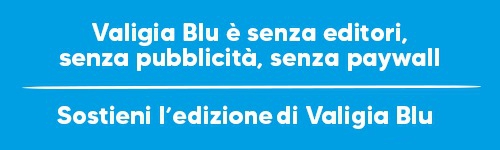I dazi di Trump: l’ultimo capitolo di una guerra commerciale che mette a rischio l’economia globale
16 min letturaIl 2 aprile il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato nel Giardino delle Rose la proposta sui dazi nei confronti degli altri paesi. Nell’annuncio, Trump ha parlato di "giorno della liberazione" che avrebbe reso l’America di nuovo grande. Il piano prevede un 10 per cento di dazi sui prodotti importati da tutto il mondo, con percentuali più elevate per i paesi che Trump definisce “worst offenders" ("i trasgressori più gravi"). In un primo momento c’è stato un calo netto delle borse, accompagnato da preoccupazioni diffuse per l’andamento dell’economia mondiale.
Gli altri paesi hanno risposto alle misure imposte dall’amministrazione Trump in maniera eterogenea. La Cina, che aveva già annunciato un’alleanza strategica con Giappone e Corea del Sud per limitare i danni, a sua volta ha risposto con dazi contro i prodotti statunitensi e ha vietato le esportazioni di diversi materiali fondamentali per l’industria. Il Giappone, invece, ha sollevato l’incompatibilità tra le mosse di Trump e le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Anche l’Europa si è mossa, anche se in maniera meno aggressiva e in ritardo, varando un pacchetto contro i dazi su Alluminio e Acciaio di metà marzo. La speranza che circola a Bruxelles è che si possa scendere a un compromesso con l’amministrazione Trump per evitare una guerra commerciale.
Il 9 aprile, però, Trump ha dichiarato una pausa di 90 giorni sui dazi specifici, mantenendo quindi i dazi al 10 per cento per tutti. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, oltre 70 paesi avrebbero cercato di mettersi in contatto per trattare ed evitare una guerra commerciale, anche se la Casa Bianca si è rifiutata di fornire la lista.
Un discorso differente vale per la Cina. Trump ha infatti dichiarato che i dazi imposti sui prodotti provenienti dalla Cina saranno aumentati raggiungendo il 145 per cento, mentre Pechino ha risposto aumentandoli all’84 per cento.
Di cosa parliamo in questo articolo:
La tragicomica storia dei dazi di Trump
Partiamo dall’evento principale, l’annuncio da parte di Trump dell’imposizione di dazi sui prodotti provenienti da ogni parte del globo. Mentre parlava, il Presidente degli Stati Uniti ha esposto un cartellone che rappresentava, oltre ai dazi imposti dalla sua amministrazione, dei fantomatici dazi reciproci che gli altri paesi imporrebbero sulle merci americane. In un primo momento, si era supposto che questi dazi reciproci fossero calcolati in base a costi, come la regolamentazione, che avrebbero pesato sull’export americano. Quello che invece è emerso da una nota della Casa Bianca offre un quadro ben meno edificante, nonostante ciò sia celato da fantomatici marchingegni matematici. La formula usata per stimare i dazi reciproci è riportata nella figura qui sotto.
Nella formula, il termine a sinistra rappresenta, appunto, i dazi reciproci che i vari paesi impongono agli Stati Uniti. Sul lato destro, invece, compaiono due variabili fondamentali: x, che indica la quantità di esportazioni degli USA verso uno specifico paese i-esimo, e m, che rappresenta invece le importazioni dagli Stati Uniti verso quello stesso paese. Al denominatore — cioè nella parte inferiore del termine a destra — ritroviamo ancora m, moltiplicato per due parametri chiave, indicati con le lettere greche ε e φ. Il primo rappresenta l’elasticità della domanda, ovvero quanto la quantità domandata reagisce a variazioni di prezzo; il secondo, invece, è il cosiddetto passthrough, cioè la misura di quanto l’aumento dei dazi si trasmette effettivamente ai prezzi finali pagati negli Stati Uniti.
Ora, ciò che ha fatto l’amministrazione Trump — e senza entrare qui nel merito delle modalità di stima di questi parametri — è stato fissare ε=4 e φ=0,25 (cioè un quarto). Il risultato è che il loro prodotto è pari a 1, e quindi di fatto non incide sulla formula, annullando l’effetto del denominatore. In questo modo, la stima dei dazi reciproci proposta da Trump si riduce semplicemente al rapporto tra il disavanzo commerciale bilaterale e il volume delle importazioni dagli Stati Uniti.
In altre parole, dietro il formalismo matematico e l’apparente rigore della formula, si nasconde un approccio molto semplice e diretto: utilizzare lo squilibrio commerciale come giustificazione automatica per l’introduzione di dazi, senza considerare le dinamiche più complesse del commercio internazionale. Un metodo che riflette perfettamente l’obiettivo politico dichiarato da Trump fin dall’inizio: riequilibrare la bilancia commerciale americana, almeno per quanto riguarda il commercio di beni. La situazione è rappresentata nella figura sotto che ha fatto il giro dei social.
Venendo invece alla scelta dei parametri: questa ha attirato l’attenzione proprio di Alberto Cavallo, uno degli autori dello studio citato, che ha risposto con un tweet. Secondo Cavallo, il valore utilizzato da Trump e dalla sua amministrazione non è concorde con quanto trovato dagli studiosi. Utilizzando le stime del paper, i dazi imposti da Trump sarebbero stati sensibilmente più bassi, nonostante ammetta che sarebbe meglio non imporne alcuni.
While the USTR tariff calculator cites the findings from Cavallo, Gopinath, Neiman & Tang (2021) it is not entirely clear how they use our findings. Based on our research, the elasticity of import prices with respect to tariffs is closer to 1. If that figure were used instead of… https://t.co/8xs9ojm9Ex
— Alberto Cavallo (@albertocavallo) April 4, 2025
Nonostante avesse dichiarato che non avrebbe fatto marcia indietro, come detto ciò è invece avvenuto. Trump ha dichiarato una pausa di 90 giorni sulla falsariga di quanto fatto con Canada e Messico. Questa pausa non cancella però il livello minimo dei dazi, fissato al 10 per cento. Non solo: anche i dazi su alluminio e acciaio al 25 per cento restano in essere. La mossa dell’amministrazione Trump appare ancora una volta poco chiara: bisognerà attendere i 90 giorni per capire se Trump ha intenzione di perseguire comunque una strategia più aggressiva oppure no. Restano, come detto, i dazi nei confronti della Cina. A oggi, parliamo di dazi al 124 per cento per i prodotti cinesi esportati negli Stati Uniti, mentre al contrario si parla dell’84 per cento.
Le reazioni dei mercati e dell’opinione pubblica
Le mosse di Trump hanno provocato un netto calo delle borse, come già successo a seguito degli altri annunci. Nei giorni successivi all’annuncio i cali sono stati equivalenti a quelli subito durante la pandemia di SarsCoV2. Il mercato si è poi caratterizzato per un’elevata volalitilità, dovuta in parte anche a dichiarazioni poi rivelatesi false rilanciate sul social X (ex Twitter). Questa settimana il mercato sembrava aver in parte recuperato. Tuttavia, il futuro è tutt’altro che roseo.
“La situazione è estremamente caotica sui mercati”, spiega a Valigia Blu Giancluca Codagnone, ex gestore di fondi presso Fidentiis e membro di Crossword. “È come se avessero creato un mostro fuori controllo. I movimenti sul dollaro, in particolare, sono quelli più preoccupanti assieme ai Titoli di Stato, che hanno visto addirittura un aumento del rendimento del trentennale. Una guerra commerciale e un deterioramento dei rapporti con la Cina avrà effetti potenzialmente devastanti”.
La flessione non ha interessato solo i titoli statunitensi: anche le borse europee e asiatiche hanno chiuso con il segno rosso. Il nostro paese ha avuto una delle peggiori chiusure tra le borse europee. A soffrire maggiormente sono stati i titoli bancari e quelli legati all’industria.
C’è anche un secondo aspetto rilevante per i mercati, che riguarda le accuse mosse a Trump di manipolazione del mercato. Sul suo social Truth, il Presidente ha scritto che era un ottimo momento per comprare sul mercato e allo stesso tempo ha messo in pausa i dazi. Ciò ha portato a un aumento dell’indice S&P 500, che monitora le 500 aziende quotate con maggior capitalizzazione, di una magnitudo simile a quanto successo dopo la crisi del 2008.
Secondo vari critici ed esponenti Democratici, si tratta di una pratica volta a favorire i sostenitori di Trump. Con il collasso del prezzo delle azioni nei giorni prima, un tale evento permette di acquistare azioni a un prezzo al ribasso e allo stesso tempo una ripresa del mercato che garantisce guadagni a chi ha deciso di acquistare mosso dalle parole di Trump. Di particolare importanza, come fa notare la deputata democratica Alexandria Ocasio Cortez è se membri del congresso abbiano o meno sfruttato questa informazione- di cui probabilmente erano a conoscenza precedentemente- per acquistare.
Any member of Congress who purchased stocks in the last 48 hours should probably disclose that now.
— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 10, 2025
I’ve been hearing some interesting chatter on the floor.
Disclosure deadline is May 15th. We’re about to learn a few things.
It’s time to ban insider trading in Congress. https://t.co/YBKMGbraAu
I conflitti di interesse non finiscono qui. Una delle accuse mosse da Bill Ackman, CEO di Pershing Square Capital Management, riguarda il segretario del commercio Howard Lutnick. Secondo Ackman, a Lutnick non importerebbe del calo del prezzo delle azioni in quanto avrebbe una posizione lunga sulle obbligazioni. Se da un lato le azioni rappresentano quote di proprietà di un’azienda e garantiscono, in alcuni casi, il pagamento di dividendi, le obbligazioni rappresentano invece un credito nei confronti dell’emittente, che si impegna a restituire il capitale e a pagare degli interessi, salvo situazioni di insolvenza. In presenza di cali del mercato azionario come quelli a cuiabbiamo assistito nei giorni scorsi, gli investitori tendono a rifugiarsi in strumenti più sicuri come le obbligazioni, facendo salire i loro prezzi. Questo meccanismo, in pratica, garantirebbe un guadagno a investitori come Lutnick, esposti su questo tipo di asset.
Anche i cittadini americani hanno manifestato, anche se in senso più ampio, contro le proposte dell’amministrazione Trump. Nel weekend in varie città del paese, i cittadini si sono radunati per manifestare contro vari aspetti dell’amministrazione Trump, dalla gestione dell’economia ai diritti civili passando per la degenerazione della democrazia americana in un’oligarchia. Come ha fatto notare Moira Donegan del Guardian, al di là delle differenti istanze rappresentate dai manifestati queste proteste possono essere viste come un tentativo di fornire un’alternativa a sinistra contro le azioni intraprese dall’amministrazione Trump.
A testimoniare una parziale disaffezione dell’elettorato ci sono poi i sondaggi che segnalano un calo del consenso di Donald Trump, legato in particolare alla sua gestione dell’economia. Secondo i risultati di un’analisi dell’agenzia Yougov, il 52 per cento degli americani si dichiara contrario alla strategia di dazi messa in campo da Donald Trump. Tuttavia si assiste a una netta polarizzazione: laddove le percentuali di disaccordo con le politiche del presidente raggiungono l’87 per cento tra i democratici e il 56 per cento tra chi si dichiara indipendente, i repubblicani sono nettamente a favore. In particolare, tra chi si identifica come MAGA, i favorevoli arrivano all’81 per cento, mentre per i Repubblicani Non-MAGA i favorevoli sono il 65 per cento. A livello aggregato, la popolarità di Donald Trump ha subito una netta flessione nel corso delle ultime settimane, passando dal 50 al 54 per cento da metà marzo. Inoltre il 53 per cento ritiene che la situazione economica si stia deteriorando.
Il resto del mondo risponde a Trump
L’annuncio di Trump ha scatenato le reazioni dei vari capi di governo coinvolti dai dazi. Tra questi, il più importante rimane la Cina, contro cui già la prima amministrazione Trump aveva intentato una guerra commerciale-l’amministrazione Biden aveva solo parzialmente tolto le misure messe in atto da Trump, sintomo di un cambiamento.
A questi, Pechino ha risposto con ulteriori dazi, dichiarando inoltre di essere pronta alla guerra commerciale con gli Stati Uniti.
Già prima però la Cina aveva cominciato la sua strategia di diversificazione e di cooperazione contro la guerra intentata dagli Stati Uniti. Il 30 di marzo infatti i ministri del commercio di Cina, Giappone e Corea del Sud avevano dichiarato che i colloqui per un accordo di libero scambio tra i loro paesi avrebbero subito un'accelerazione.
Non solo: recentemente la presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen ha avuto un colloquio telefonico con il premier cinese Li Quiang. Nel corso della telefonata, i due avrebbero ribadito l’impegno per sostenere un sistema commerciale riformato, libero, equo.
Anche l’Europa si è mossa per contrattaccare contro le misure doganali. È interessante, ancora una volta, cercare di comprendere perché si tratta di una mossa comprensibile. Nonostante queste settimane siano state la sagra delle analogie con la teoria dei giochi, un articolo sul blog economico La Voce a firma Domenico Marino, professore di Politica Economica ha illustrato la logica dietro un approccio più muscolare dell’Europa.
Per comprenderlo, Marino cita uno degli esempi più noti di gioco, quello di falco e colomba. In questo gioco, due attori decidono se adottare una strategia conciliante (colomba) o aggressiva (falco). I benefici dipendono da che tipo di comportamento assumono: se uno dei due decide di comportarsi da falco e l’altro da colomba, il primo otterrà dei guadagni maggiori perché la colomba non è disposta a scontrarsi; se entrambi decidono di comportarsi da falco, si innesca un conflitto che danneggia entrambi ma che permette di mantenere la credibilità a entrambi. La situazione più ottimista è invece quando entrambi si comportano da colomba, garantendo una situazione di benefici comuni.
L’amministrazione Trump, al netto delle sue retromarce, ha deciso di giocare una strategia aggressiva- quindi da falco- e sarebbe quindi estremamente sconveniente per l’Europa comportarsi in maniera conciliante.
Per questo motivo, l’Europa aveva già varato un pacchetto di contromisure per contrastare i dazi imposti da Donald Trump, nonostante il pacchetto fosse mirato a contrastare i dazi imposti su Acciaio e Alluminio, come riporta il Post. Nel primo pacchetto, che è stato poi messo in pausa viste le decisioni dell’amministrazione statunitense, si parlava di dazi al 25 per cento su 22 miliardi di euro di prodotti statunitensi.
Tuttavia, l’Europa sta già lavorando al proprio interno per sfidare gli Stati Uniti. Durante una riunione con i rappresentanti dell’industria europea, il Commissario all’Industria Stéphane Séjourné ha sottolineato la volontà da parte della commissione di ridurre gli oneri per rendere più competitive le industrie europee.
Anche i vari paesi europei si stanno mobilitando. In primis c’è sicuramente la Spagna di Pedro Sanchez, che a seguito dell’annuncio di Trump ha dichiarato che avrebbe mobilitato 14 miliardi di euro per sostenere l’economia che cresce più velocemente in Europa. Non solo: il governo di Pedro Sanchez rappresenta un ponte tra l’Europa e l’Asia, in particolare la Cina. Proprio in questi giorni Sanchez è impegnato in un tour nel sud est asiatico che ha toccato il Vietnam e la Cina.
La Germania, nel mentre, ha finalizzato gli accordi riguardo alla Grande Coalizione tra CDU/CSU e SPD che governerà il paese nei prossimi anni. Anche in questo caso, l’aggressività dell’amministrazione Trump ha giocato un ruolo. Come spiega Valigia Blu Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica per la Germania:
Il discorso di JD Vance alla Conferenza di Monaco ha mostrato una netta ostilità della nuova amministrazione Trump nei confronti di Europa e in particolare Germania. Questo nuovo atteggiamento nei rapporti transatlantici ha avuto vari effetti sulla politica tedesca appena uscita dalle urne. Il primo è sicuramente un netto cambio di strategia per quel che riguarda la spesa pubblica. Merz ha fin da subito annunciato un piano di sviluppo e riarmo, in un paese che soffre di un enorme gap di investimenti, dal valore iniziale di 500 miliardi. Si tratta di una rivoluzione copernicana per un paese come la Germania, viste le tensioni in seno al precedente governo sul freno al debito. E questa non può che essere una reazione a un maggior isolamento nei confronti degli Stati uniti. Anche l’accelerazione sul contratto di governo e sull’accordo con la SPD possono essere viste in quest’ottica.
Al contrario il nostro paese viene visto come parte delle colombe all’interno dell’Europa, tanto che Giorgia Meloni volerà da Trump nei prossimi giorni per cercare un negoziato. Tuttavia l’obiettivo di zero dazi è improbabile.
Ma c’è una strategia?
La strategia di Trump ha destato non poche preoccupazioni anche in seno alla sua stessa amministrazione. Di rilievo, sono le ricostruzioni riguardanti l’umore del suo Segretario al Tesoro Scott Bessent. All’interno del cerchio ristretto, infatti, Bessent è sempre meno rilevante e le mosse di questi ultimi giorni potrebbero seriamente danneggiare la sua reputazione. Secondo indiscrezioni riportate dal The New Republic, ciò starebbe spingendo Bessent a una riflessione sul suo ruolo nell’amministrazione, cercando un via di fuga come un posto alla FED.
D’altronde le idee di Trump sul commercio sono state influenzate da un personaggio ben più controverso rispetto a Bessent, ben inserito all’interno del mondo della finanza: Peter Navarro, ex Professore di Economia all’Università della California. Navarro è conosciuto perlopiù per le sue posizioni fortemente contrarie alla Cina, esposte in un volume dal titolo eloquente Death to China. Proprio questo volume ha portato Jared Kushner, marito di Ivanka Trump, a contattare Navarro durante la prima campagna elettorale di Trump, come riporta Vanity Fair. L’approccio muscolare di Navarro era in piena sintonia con le idee sul commercio espresse da Trump nel corso dei decenni. Dopo aver fatto parte della prima amministrazione Trump, Navarro ha contribuito a scrivere uno dei capitoli del Project 25, tornando poi di nuovo alla Casa Bianca.
Navarro è considerato un personaggio singolare all’interno del panorama economico: le sue idee vengono ritenute estremiste dal resto dell’accademia, tanto che per giustificarle Navarro si è avvalso di un fantomatico esperto di nome Ron Vara. Il New York Times , dopo le accuse mosse da un’economista, ha però chiarito che non esiste alcun Ron Vara: si tratterebbe semplicemente di un anagramma di Navarro utilizzato proprio per sostenere le sue idee in maniera più “formale”. In questi giorni proprio Navarro è stato tra i più agguerriti sostenitori della strategia di Trump, tanto da entrare in rotta di collisione con Elon Musk, dando il via a una serie di tweet in cui Musk si scaglia contro di lui in maniera piuttosto violenta.
Questo fa pensare che dietro alla strategia di Trump non ci sia un piano lucido per riportare la produzione negli Stati Uniti senza particolari contraccolpi economici, quanto più una serie di idee folli raffazzonate sulle idiosincrasie del presidente e di parte della sua amministrazione. Anche il Premio Nobel per l’Economia Paul Krugman, sul suo Substack, condivide l’idea che si tratta di una decisione mossa dall’ignoranza e dall’arroganza.
Che la strategia di Trump sia quantomeno discutibile lo dimostrano le stesse dichiarazioni del Presidente. In un altro post sul suo social Truth, Trump ha celebrato l’abbassamento dei prezzi dei carburanti. Uno dei suoi ex consiglieri economici, tuttavia, ha sottolineato che questo non è da recepire come un buon segnale, anzi: illustra semmai le preoccupazioni degli agenti economici che davanti a un potenziale calo della domanda calano, appunto, i prezzi.
Le dichiarazioni di questi giorni su come far ripartire l’industria manifatturiera in USA, rilasciate da vari membri dell’amministrazione, lasciano ancora più perplessi.
In un’intervista concessa Tucker Carlson, ex volto storico dell’emittente conservatrice Fox News, sempre il Segretario al Tesoro Bessent ribadisce che la forza lavoro per il rilancio della produzione americana sarà prevalentemente automatizzata grazie ai progressi nella robotica e nell’AI.
In his interview with Tucker Carlson, Treasury Secretary Scott Bessent argued that tariffs will eventually lead to increased income tax collections “from all the new jobs,” then admits much of the new manufacturing will be done by AI/robotics. pic.twitter.com/4G9ZuDTwYF
— Phil Williams (@PhilNvestigates) April 7, 2025
La stessa posizione è stata ribadita dal segretario al commercio Lutnick proprio in un’intervista a Fox News.
Da una parte viene a mancare la motivazione politica che poteva esserci dietro ai dazi, ovvero riportare non solo la produzione, ma anche posti di lavoro sul suolo americano. Dall’altra è anche necessario chiedersi se queste dichiarazioni corrispondano a un piano verosimile o meno, cioè se effettivamente le aziende, grazie all’aumento della produzione, aumenteranno la loro adozione di tecnologie automatizzanti. Si tratta di una questione estremamente complessa che riguarda i vari incentivi nel mercato del lavoro.
Gli effetti economici della guerra commerciale
Per comprendere quali saranno gli effetti economici della situazione che si è creata è necessario distinguere tra l’impatto che hanno i dazi e quello che inveve ha la non-strategia errante di Trump. Concentrandosi sul fronte dazi, l’evidenza storica suggerisce che il loro impatto è profondamente negativo.
Un caso paradigmatico viene proprio dagli Stati Uniti: nel 1930, sotto la pressione degli industriali ma criticato dagli economisti, venne approvato lo Smoot–Hawley Tariff Act. Dopo un periodo di abbassamento e apertura al libero mercato iniziato con le politiche del presidente Wilson, il provvedimento riportava l’aliquota media sulle importazioni quasi al 20 per cento. Fatto per proteggere la produzione domestica, lo Smoot-Hawley Tariff Act finì per danneggiare ancora di più il paese durante la Grande Depressione.
I dazi di Trump avrebbero un effetto analogo secondo uno studio recente. In assenza di contro-dazi imposti dagli altri paesi, gli Stati Uniti potrebbero avere qualche beneficio, ma una volta che si tengono in considerazione le risposte degli altri paesi il guadagno finisce per scomparire.
È tuttavia interessante chiedersi come reagiranno le imprese straniere che hanno un export elevato negli Stati Uniti. Qualche giorno fa, il CEO di Lavazza ha sottolineato come il mercato americano rappresenti una fetta importante dei guadagni della sua azienda. Proprio per questo una parte ancora più corposa della produzione verrà portata negli Stati Uniti. Anche altri settori, come quello della ceramica che ha visto un netto aumento del commercio con gli USA, hanno nel mercato statunistente un importante fonte di guadagno. Sarà necessario comprendere quindi le scelte di composizione della forza lavoro: un’azienda che ha stabilimenti sia stabilimenti all’estero sia stabilimenti negli Stati Uniti, a fronte della strategia dei dazi di Trump, potrebbe scegliere di aumentare la forza lavoro nelle fabbriche degli Stati Uniti per ridurre i suoi costi.
Questo fa anche capire quanto sia esposto il nostro paese, tra i più legati con gli Stati Uniti, sia per quel che riguarda il commercio diretto sia per quel che riguarda le catene di approvvigionamento: ad esempio molta componentistica necessaria per la fabbricazione delle auto tedesche passa appunto dall’Italia. Anche per questo motivo Banca d’Italia ha abbassato le stime di crescita per il nostro paese allo 0.6 per cento nel 2025, con effetti ancora più pesanti nel biennio successivo.
Il governo italiano di Giorgia Meloni ha nel mentre formato una task force formata da vari ministri e ha poi annunciato l’intenzione di stanziare 32 miliardi per aiutare le categorie colpite. Tuttavia le dichiarazioni dei vari ministri, tra cui Tajani, mostrano un atteggiamento più aperto al compromesso, nella speranza che i dazi di Trump si riveleranno un nulla di fatto.
“La guerra commerciale non è certo finita con la moratoria di 90 giorni” spiega a Valigia Blu Francesco Saraceno, professore di macroeconomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla LUISS. “e, quali che siano gli sviluppi futuri, ci sarà un impatto negativo su crescita, consumi e prezzi. Avremo, nei prossimi mesi, una tendenza alla stagflazione, la coesistenza di crescita ridotta e pressioni inflazionistiche. Ma la vera vittima del comportamento erratico dell’amministrazione Trump è l’investimento. L’incertezza è il peggior nemico dell’economia, e un’impresa inserita nelle catene globali del valore oggi non è in grado di decidere quanto, dove e se investire. Questo ha un effetto negativo a breve sulla domanda aggregata ma soprattutto sull’accumulazione di capitale di lungo periodo”.
L’amministrazione Trump quindi, sia con le sue politiche sia con l’incertezza che la contraddistingue, sta lentamente trascinando non solo gli Stati Uniti ma il resto del mondo verso un rallentamento economico.
(Immagine in anteprima via FTM)