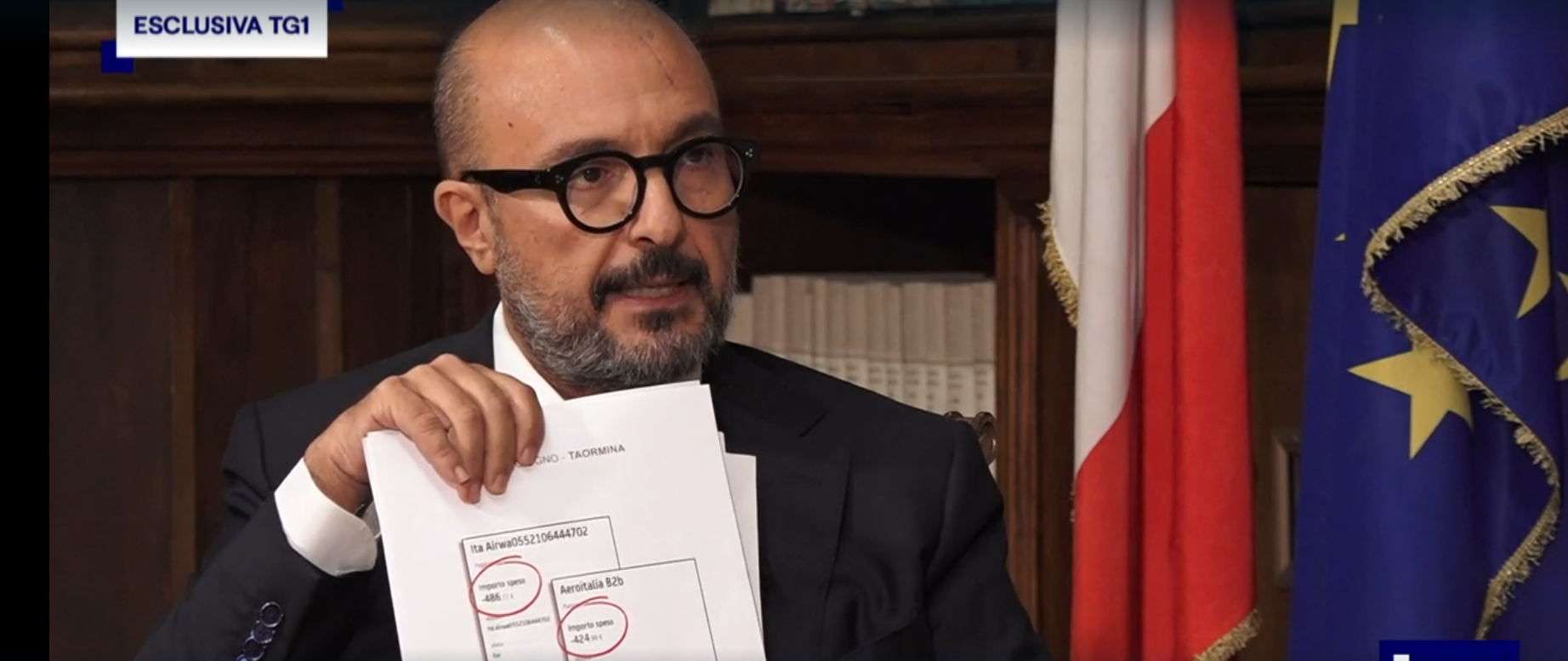La strumentalizzazione dei corpi e del dolore in politica
9 min letturaA Pontida, per l’annuale raduno della Lega, uno dei momenti che ha ottenuto maggiore copertura è stato quando sul palco è salita una bambina, accompagnata dalla madre che reggeva uno striscione con scritto «#bambinistrappati». La presenza di entrambe è così stata annunciata da Matteo Salvini:
Mai più bambini rubati alle loro famiglie! Mai più bimbi rubati alle mamme e ai papà! Mai più ai bimbi come merce!
Nel coprire l’episodio, si è generata la notizia che sul palco fosse salita una «bambina di Bibbiano». Equivoco frutto di una faciloneria cronica della stampa nell’attribuire virgolettati (Salvini non pronuncia la parola «Bibbiano»), di un clima pre-esistente che ha imposto il frame «a Bibbiano rubano i bambini alle famiglie», e di alcuni tweet prima diffusi furbescamente da account ufficiali della Lega, e poi rimossi, che parlavano di «BAMBINA DI BIBBIANO». Ne ha parlato esplicitamente così lo stesso Salvini, ospite dell’emittente 7Gold, dove ha persino annunciato che «ne verranno fuori altre, non solo in Emilia», rifacendosi a segnalazioni che avrebbe ricevuto, parlando di «bambini che fruttano anche 200 euro al giorno»; il tutto senza fornire riscontri.
Questo ha creato un corto-circuito dove ci si è concentrati sul fatto che la bambina non fosse nell’inchiesta - tra i primi a tirare fuori la questione è stata su Twitter Selvaggia Lucarelli. Si è poi scoperto in seguito che la bambina era stata tolta alla madre per richiesta del padre, separato dalla donna, al Tribunale. Tra l’altro la famiglia proviene da un comune nel comasco amministrato negli ultimi anni dalla Lega.
Tutte queste analisi e fact-checking sul dettaglio Bibbiano sì/no, oltre a rafforzare un immaginario di paese degli Orchi cattivi travestiti da assistenti sociali e psicologi (ma potrebbe essere potenzialmente tutta l’Italia, ci avverte Salvini), ha messo in secondo piano un aspetto dello show di Pontida. Ossia che chi diceva questa estate «mi vergogno a nome di chi coinvolge i figli o i bambini nella polemica politica, a me chi usa i bambini per la lotta politica fa schifo», magari alludendo spregevolmente alla possibile pedofilia di giornalisti freelance che incalzavano nelle domande, non ha problemi a usarli a sua volta. Anzi.
Luca Sofri faceva notare sul suo blog come la contraddittorietà dei politici, esibita e impunita, configuri ormai una sorta di bispensiero orwelliano, tanto da parlare di «era della post-logica». Ma il problema, nel caso specifico, è più legato al corpo in politica, a quando può diventare simbolico e quando invece diventa un oggetto scomodo, da riporre via. È legato a una precisa concezione di potere, che se ascoltato con attenzione manda un messaggio ripugnante, ma coerente: decidiamo noi quali corpi si possono usare.
E nel loro utilizzo politico quei corpi, così come la storia, il contesto, la complessità delle reti di relazioni che si muovono attorno, gli intrecci giudiziari, eventuali omissioni, il dolore che hanno provocato, diventano oggetti. Da esibire come un feticcio di appartenenza, o scagliare contro gli avversari. Più di mille analisi vale una foto, scattata durante il dibattito per la fiducia del Governo Conte-Bis.
Lo scatto in Senato di Pillon con la Borgonzoni e la maglietta su Bibbiano.
Mi scuso anticipatamente per la foto che può provocare reazioni intestinali serie, ma non si può tacere.
Ridono, soddisfatti. Come se lo show fosse riuscito.
Di quei bambini a loro non frega un cazzo. pic.twitter.com/ahmpr4h4kK— Fabio
(@Iperbole_) September 11, 2019
I «bambini di Bibbiano» sono compressi a slogan - «Parliamo di Bibbiano» - su una maglietta, le facce sorridono compiaciute nel selfie di gruppo. Sembra una comitiva allo stadio che indossa una maglia per irridere gli avversari (le lettere "P" e "D" sono in rosso), non una delegazione di senatori che chiede verità per un caso ritenuto di pubblico interesse. Spalti della curva, non banchi del Parlamento. Nessuno in quella foto è sfiorato dall’idea che magari uno di quei bambini, oggi, oppure un domani, potrebbe guardare l’immagine e pensare «perché ridono?».
Di solito la simbolizzazione dei corpi serve a far irrompere il peso politico di una vicenda in un orizzonte dove altrimenti sarebbe rimossa. Lo vediamo in modo lampante con i defunti, quando la loro morte segue una grave ingiustizia. Oppure con chi è in una condizione liminale, di morte relativa rispetto alla normale quotidianità: come per un rapimento o un’incarcerazione ingiusta; o per soggetti politici che non sono riconosciuti perché discriminati. Qualcosa non funziona nel sistema, per dolo od omissione, e crea un precedente pericoloso. Allora va prima di tutto creato uno spazio perché il problema sia visto nella sua rilevanza politica, e i simboli sono un modo molto efficace per farlo.
Lo si è visto in questi anni nei casi dei morti di Stato - come Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi o Aldo Bianzino. Quel morto è come un fantasma per chi è rimasto, e come ogni fantasma parla nell’assenza, chiede verità. Di fronte a depistaggi od omissioni, evocare il nome delle vittime, o l’immagine, apre uno squarcio nelle menzogne, nell’ignavia. Le foto del cadavere sono state un modo per opporsi alla morsa asfissiante di una verità di comodo - è stato un attacco cardiaco, è caduto dalle scale, ha avuto un aneurisma. E da lì si è creata la premessa agli occhi dell’opinione pubblica per chiedere giustizia. Oppure lo si è visto con la campagna "Verità per Giulio Regeni", lo striscione appeso dai balconi dei palazzi comunali, o nelle foto profilo degli account di chi si è unito a distanza alla richiesta della famiglia. Nominare chi non ha più voce diventa un modo per rammentare ai vivi che c’è una domanda di giustizia inevasa, e quella domanda riguarda una comunità ben più estesa della famiglia che può far propria quella richiesta. Così attraverso il simbolo chi non può parlare torna da dove non può più essere raggiunto.
Ma, come detto, si sta affermando una cultura del potere che vuole decidere quali corpi possono tornare, e come, e quali non hanno alcuna dignità politica: una cultura talmente interessata a questa dinamica da tralasciare il contesto di partenza di quei corpi, che quando sono esibiti o nominati diventano feticci, e non simboli. Non è un caso, a proposito di Giulio Regeni, che di recente si sia iniziato a rimuovere gli striscioni dai palazzi della Regione Friuli, dal Comune di Cagliari, di Sassuolo e Pisa, o a coprirli per festeggiare una vittoria elettorale, come a Ferrara; la Regione Torino, per mezzo dell'assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca, ha invece esposto lo striscione «Verità per Bibbiano» contrapponendolo allo striscione «Verità per Giulio Regeni», come se la verità fosse una questione di rivalsa, un derby. Lo stesso Salvini, da Ministro dell’Interno, aveva dichiarato che i rapporti con l’Egitto erano più importanti del far luce sulla morte del giovane ricercatore. Quest'opera di rimozione o negazione è qualcosa di molto più profondo e abietto delle semplici reticenze dei governi che si sono succeduti, e che hanno fallito nel chiedere conto al governo egiziano sulla morte di Regeni. È evidente che per una certa politica non si tratta di un cittadino italiano torturato e ucciso in un paese straniero, in circostanze di cui andrebbero chiarite le responsabilità delle autorità egiziane. Regeni è visto come un morto del nemico. Prima gli italiani, sì, ma non tutti: solo i nostri.
È evidente, per citare un altro caso, che Silvia Romano deve aver fatto qualcosa di terribile, perché altrimenti non si spiega come mai abbia compiuto il 24esimo compleanno da rapita, dopo più di un anno dal rapimento. Non si è avvertito il particolare bisogno di lanciare slogan come «riportiamo a casa la nostra volontaria» o «#parlatecidisilviaromano», con un’evidente sproporzione in difetto nella copertura mediatica, rispetto a casi analoghi. Ci sono corpi che sono arruolabili come martiri della propria causa, e corpi che devono semplicemente sparire perché da loro non si potranno mungere consensi, share o interazioni su Facebook. Così come ci sono corpi che non vanno liberati, e se ciò avviene, come per Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, sorgono polemiche su eventuali riscatti (soldi buttati via, ovviamente), si diffondono anche a livello parlamentare bufale su rapporti sessuali avuti con i rapitori.
Questa cultura contamina anche le conversazioni online, lontano dai palazzi. Ad esempio quando si pubblica una notizia e puntualmente il corpo viene evocato come forma aggressiva di benaltrismo, per zittire. «E i marò?», «e i terremotati?», «E la povera Pamela?», «E la povera Desirèe?», e così via. Oppure si instaurano deliranti ping-pong tra notizie di cronaca nera, e se si condivide la notizia di uno stupro o di un femminicidio arriva chi risponde con un altro caso, di solito per affermare che le «nostre donne» sono minacciate dagli stranieri, o per negarlo. Ma è come litigare davanti a un corpo a terra, ucciso o sopravvissuto a uno stupro.
Il caso di Pamela Mastropietro è emblematico di questa strategia aggressiva e spregiudicata, dove la rilevanza politica sconfina abbondantemente nella strumentalizzazione. Il pusher accusato dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere, Innocent Oseghale, è stato condannato in primo grado all’ergastolo. Non c’è una verità negata su cui far luce, un bisogno disperato di giustizia che le istituzioni vogliono cacciare giù in gola, ridurre al silenzio. C’è sicuramente molto dolore, e su quello ovviamente è giusto tacere, porsi nel modo più rispettoso possibile verso chi conosceva e amava la ragazza e deve elaborarne la morte. Ma nessun giornalista o politico sano di mente ha mai cercato di negare l’accaduto, come per altre morti diventate simboliche o di interesse pubblico. A quella famiglia non è mai toccato, fortunatamente, ciò che ancora oggi accade ai familiari di Stefano Cucchi, il sentirsi dire «alla fine era un drogato, se l’è cercata», parole che suonano come un oltraggio alla tomba. Né la madre di Aldrovandi si sognerebbe mai, contrapponendosi alle forze dell'ordine, di stigmatizzare un carabiniere ucciso, dicendo «invece di piangere lui pensate a mio figlio».
Invece come oggetto politico il corpo di Pamela è prima di tutto trasfigurato in «povera Pamela», come a esaltarne una mitica innocenza. Ma chiunque fosse stata da viva, non meritava quella fine a prescindere - penserete mai seriamente che qualcuno possa meritarla? Abbiamo poi assistito a una sovraesposizione di quel corpo, come se quel fantasma fosse trattenuto per meglio infestare i vivi. Ciò è avvenuto naturalmente da parte di politici e giornalisti, ma anche dello stesso avvocato di famiglia, Marco Valerio Verni, zio della ragazza. Che senso ha infatti, come da lui dichiarato, minacciare di «portare fin sotto al Parlamento e al Quirinale le gigantografie del corpo martoriato» della nipote, qualora venisse rivisto o smantellato il decreto sicurezza bis? Non sarebbe in caso più sensato ragionare in termini di contrasto al narcotraffico, di cui la manodopera al dettaglio - i pusher - è solo l’ultimo anello di una catena che di solito passa per il crimine organizzato nostrano? Ma a parte ciò, dire:
Ogni giorno siamo bombardati da immagini strappalacrime di barconi carichi di migranti che la sinistra vorrebbe accogliere senza preoccuparsi delle conseguenze. La stessa sinistra che è rimasta in silenzio quando Pamela è stata violentata ed uccisa con ferocia inaudita.
Non ha in sé qualcosa di sinistro, l’idea che il legittimo dolore abbia un valore utilizzabile per annullare quello altrui? L’idea che la memoria di un morto non si accompagni a una ricerca di verità e giustizia, ma al desiderio di zittire e non riconoscere altre forme di dolore? È come se il dolore diventasse misurabile, e la politica, nonché lo Stato di diritto, avessero la funzione di valutare chi vale di più da morto. Ma non è la prima volta che Verni attua questa contrapposizione. L’anno scorso realizzò più di 2mila condivisioni con un video postato sul proprio profilo Facebook, dove indossava una maglietta nera in polemica con le magliette rosse che allora molti misero per una campagna di sensibilizzazione sui morti in mare.
Ma quei morti non hanno alcuna responsabilità per quanto accaduto a Pamela Mastropietro: ce l’ha Innocent Oseghale, e questo un avvocato dovrebbe saperlo. Quei morti sono responsabili solo pensando «se lasciamo entrare persone nel paese, altre ragazze saranno stuprate, uccise e i loro corpi fatti a pezzi per essere occultati». E quindi, senza differenza alcuna, donne, uomini e bambini che traversano il Mediterrano diventano un esercito di pusher nigeriani diretti verso il nostro paese, a corrompere una sorta di Eden dove le donne non sono mai uccise o violentate dai connazionali. Non è un caso se, contestualmente alle circostanze che hanno portato all'uccisione della ragazza, in questa visione scompare l'uomo che le offrì soldi in cambio di sesso, approfittando della sua condizione di fragilità: non è una verità spendibile politicamente.
In questo clima, è difficile trarre una conclusione su una simile cultura politica. Quando c’è di mezzo la morte, o le esperienze traumatiche in generale, la prima lingua che si impone su di noi è il silenzio. Perché ogni parola ci sembra inefficace, ogni suono che abbiamo pronunciato fino a quel momento perde di significato rispetto alla vastità che dobbiamo elaborare. Il dolore può essere un deserto, e attraversarlo significa imparare a camminare diversamente. A pensare e parlare diversamente, mentre si sperimenta la solitudine di chi non potrà mai essere capito fino in fondo, in ciò che prova. Per alcuni questo deserto è così vasto che non sarà mai attraversato per intero, e ciò nonostante si è costretti a vivere lo stesso. Perciò ogni parola o atto politico, in casi del genere, dovrebbero procedere dalla consapevolezza di un'innaturalità di fondo: tacere e restare immobili è impossibile, parlare e agire non restituirà qualcosa che è andato perso per sempre. Invece ci tocca assistere, tirati da più parti, a grida, tifo, slogan lanciati pensando alle metriche che misureranno il successo dell’operazione, insulti e oltraggi, persino l'odiosa negazione. Se proviamo a guardare con distacco tutto ciò, si inizia a vedere una strada lungo la quale è impossibile ogni pacificazione, e l’assenza di conflitto aggressivo è vista come un crimine, una debolezza imperdonabile.
Immagine in anteprima via Repubblica