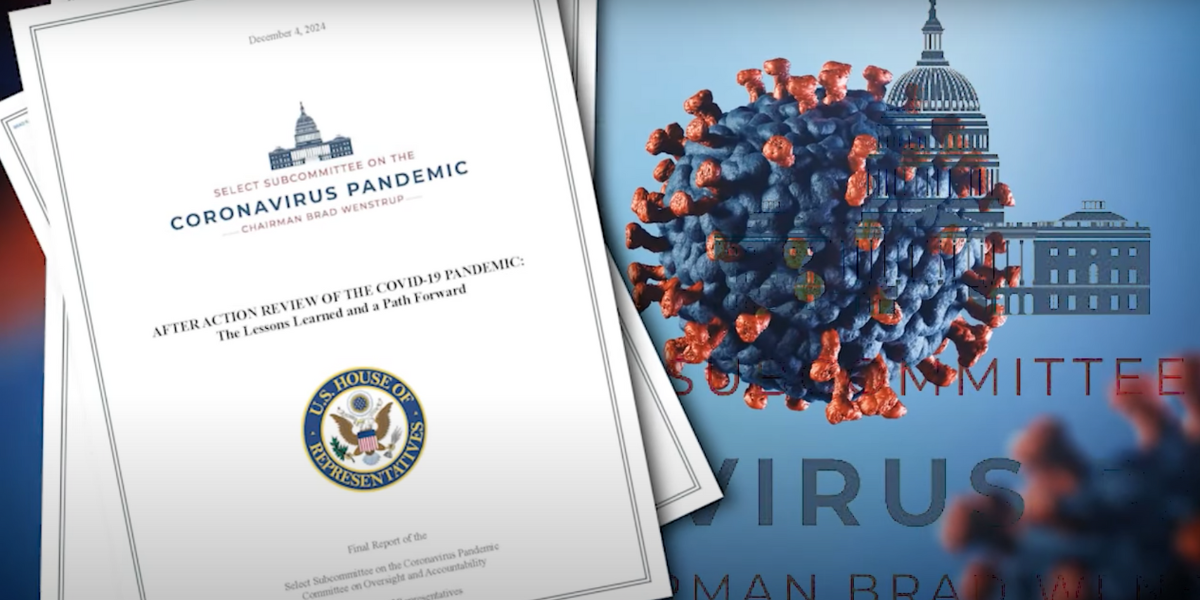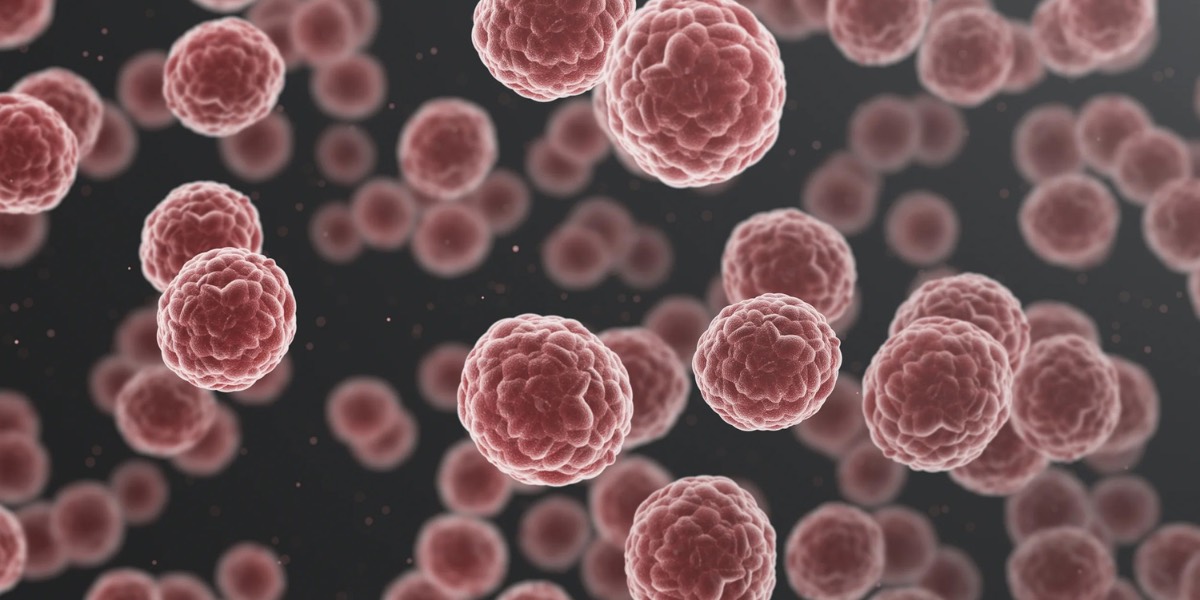L’idea di combattere la pandemia con l’immunità di gruppo è scientificamente ed eticamente insostenibile
11 min lettura«Ridicola» e «senza senso». Così l’immunologo Antony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha liquidato l'idea di gestire la pandemia di COVID-19 con un approccio basato sull’immunità di gruppo. La proposta è al centro della petizione nota come Great Barrington Declaration, promossa dall'American Institute for Economic Research (AIER), un think-tank di area libertarian. Su Valigia Blu abbiamo descritto il contenuto della Declaration spiegando come i suoi promotori abbiano sfruttato l'autorità di alcuni esperti per sostenere un'iniziativa che aveva presupposti e intenti politici: denunciare «l'uso senza precedenti delle costrizioni statali nella gestione della pandemia da COVID-19».
Leggi anche >> Pillole di Ottimismo, la dichiarazione contro il lockdown, e l’immunità
Negli Stati Uniti l'immunità di gruppo è diventata una sorta di bandiera per l'area politica che sostiene Donald Trump. Si è espresso a favore anche Scott Atlas, neuroradiologo membro della task force della Casa Bianca sulla pandemia nominato da Trump ad agosto. Nei giorni scorsi Atlas ha condiviso su Twitter un intervento contro l’uso delle mascherine per contenere la diffusione del virus nella popolazione pubblicato proprio sul sito dell'AIER.
Alla Great Barrington Declaration ha replicato un gruppo di esperti e ricercatori sulla rivista medico-scientifica The Lancet. Hanno definito la proposta «una fallacia pericolosa non supportata dall'evidenza scientifica».
Cos'è l'immunità di gruppo e come si calcola
Il problema dell'immunità e i costi umani e sociali
Cos'è l'immunità di gruppo e come si calcola
Il fenomeno dell'immunità di gruppo si manifesta quando una certa percentuale di individui nella popolazione diventa immune a un patogeno. Oltre questa soglia, il contagio si interrompe perché l’agente patogeno non trova un numero sufficiente di persone suscettibili all’infezione per potersi diffondere in modo sostenuto. È lo stesso effetto che si ottiene grazie alle vaccinazioni. Con una copertura vaccinale sufficiente, infatti, anche la porzione di individui non ancora immuni beneficerà di una protezione indiretta, conferita dall'immunità acquisita dal resto della popolazione. La soglia dell'immunità di gruppo per ogni patogeno dipende dall'indice R0, un parametro che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, cioè il numero medio di persone contagiate da una persona infettata, in una popolazione completamente suscettibile.
Sappiamo che la trasmissione della malattia nella popolazione inizia a interrompersi se R0 scende al di sotto di 1, cioè se un individuo infetto trasmette il contagio a meno di un’altra persona in media. Calcolare R0 non è un’operazione banale. La sua stima è condizionata da diversi fattori, che dipendono dalla specifica malattia (ad esempio: la durata del periodo di contagiosità dopo l’infezione). Tuttavia non dipende solo dalla biologia del patogeno, ma anche da fattori locali come la densità di popolazione e le dinamiche che caratterizzano il comportamento e le interazioni tra le persone in un certo contesto geografico e sociale. Il parametro R0, come suggerisce il nome, si riferisce alla trasmissione del virus nella fase iniziale dell’epidemia. Possiamo interpretarlo come un parametro che esprime il potenziale di diffusione di una malattia infettiva contagiosa senza misure di contenimento.
R0 non è perciò una caratteristica costante di un patogeno. Il suo valore cambia durante un’epidemia. Quando l’epidemia è in corso si preferisce infatti parlare di Rt, cioè di un indice di trasmissione calcolato nel corso del tempo e che fotografa la situazione del contagio in un dato istante, quando sono in atto misure di contenimento e di distanziamento sociale. In Lombardia il valore di R0 ha raggiunto il massimo di 3 tra il 17 e il 23 febbraio, per poi iniziare a scendere quando sono state adottate le misure di contenimento.
Nel caso di un patogeno altamente trasmissibile come il virus del morbillo, che ha un R0 compreso tra 12 e 18, l’immunità di gruppo viene raggiunta quando la percentuale di popolazione immunizzata è del 95%. Questa soglia, molto elevata, rappresenta l’obiettivo che devono raggiungere le campagne di vaccinazione contro il morbillo. Con una copertura vaccinale insufficiente continuerebbero infatti ad esserci condizioni favorevoli per una diffusione della malattia.
Secondo la maggior parte degli studi realizzati finora, l’indice R0 del SARS-CoV-2 si colloca tra il 2 e il 3. Se conosciamo R0 possiamo calcolare l’immunità di gruppo attraverso la formula 1 − 1/R0. Con un R0 tra 2 e 3, l’immunità di gruppo per la COVID-19 dovrebbe instaurarsi con una percentuale di popolazione immune compresa tra il 50 e il 67%.
Il calcolo fornisce però un valore nominale di questo parametro, che presuppone che il contagio si diffonda nella popolazione in modo omogeneo. Nella realtà, esistono diversi fattori che influenzano la trasmissione di un patogeno nella popolazione che potrebbero anche condizionare la soglia a cui si raggiunge l’immunità di gruppo. Uno studio pubblicato su Science ha diviso la popolazione in sei gruppi di età, ognuno dei quali suddiviso in tre livelli crescenti di attività sociale. Scomponendo la popolazione in questo modo, il modello calcola i valori di immunità di gruppo (assumendo un R0 di 2,5) nei diversi insiemi. Secondo questo modello, la soglia di immunità nella popolazione si abbasserebbe complessivamente a circa il 43%. Ma, avvertono gli autori, i livelli di attività e la struttura sociale della popolazione dovrebbero essere considerati specifici di un paese o di una particolare regione.
Studi come questo (e altri, che ipotizzano soglie di immunità più basse) prendono in esame quella che viene definita eterogeneità, cioè quell’insieme di fattori che incidono sulle dinamiche di un’epidemia e la trasmissione di un patogeno nel mondo reale. Esistono eterogeneità spaziali: nelle aree rurali si verificano meno contatti che in quelle urbane. Ci sono poi eterogeneità che riguardano il comportamento delle persone. In una popolazione reale le persone non interagiscono in modo casuale. Le interazioni avvengono attraverso le reti sociali, che coinvolgono amici, parenti, colleghi di lavoro. Alcune persone possono essere più esposte al contagio, a seconda del contesto in cui vivono. I modelli indicano che le persone che hanno un maggior numero di interazioni si infettano prima durante un’epidemia.
Tutto ciò può risultare intuitivo, se immaginiamo cosa accade nella vita di tutti i giorni. Ma capire come queste dinamiche influenzano l’evoluzione di un’epidemia significa avere a che fare con sistemi molto complessi. È stato osservato che nel caso del SARS-CoV-2 gli eventi di superdiffusione rivestono un ruolo importante nella sua circolazione. Una superdiffusione avviene quando una singola persona ne riesce a contagiare decine di altre (cioè un numero molto superiore a R0). Gli studi indicano che nella pandemia di COVID-19 l’80% dei contagi è causato da circa il 10% dei casi positivi.
Due ricercatori dell’Istituto Pasteur di Parigi, in un commento su Nature Reviews Immunology, scrivono che se questi superdiffusori verranno infettati per primi usciranno rapidamente dall’insieme delle persone suscettibili all’infezione all’interno della popolazione. Questo rallenterebbe la velocità di trasmissione del contagio ma l’impatto, nel caso della COVID-19, sarebbe difficile da quantificare. Ci si attenderebbe una soglia di immunità di gruppo inferiore se fosse lo stesso insieme di individui ad essere potenziali superdiffusori.
Se ciò non accadesse, se fossero gli eventi più che le persone a generare fenomeni di superdiffusione o se le misure di contenimento modificassero l’insieme di questi individui, potrebbe esserci un impatto limitato sull’immunità di gruppo nella popolazione. Samuel Scarpino, docente di scienza delle reti alla Northeastern University, afferma che se nella COVID-19 questi eventi di superdiffusione svolgono un ruolo rilevante «allora il contagio non si diffonderà in modo uniforme nella popolazione, il che significa che non ci sarà una fetta abbastanza ampia di popolazione infettata perché l'immunità di gruppo funzioni». Per questa ragione, osserva, «l'immunità di gruppo non è la risposta».
Anche ammettendo di poter raggiungere un’immunità diffusa, abbastanza alta da impedire una circolazione sostenuta del virus, l’epidemia non si esaurirebbe di colpo. Il biologo Carl Bergstrom e la biostatistica Natalie Dean scrivono sul New York Times:
il virus non scompare magicamente quando viene raggiunta la soglia dell’immunità di gruppo. Non è quello il momento in cui le cose si fermano, è solo quando iniziano a rallentare. Una volta che si è creata un'immunità sufficiente nella popolazione, ogni persona infetterà meno di un'altra persona, quindi una nuova epidemia non può ricominciare da capo. Ma un'epidemia già in atto continuerà a diffondersi. Se al culmine dell'epidemia ci sono 100mila persone contagiose e ognuna infetta 0,9 persone, ci saranno ancora 90mila nuove infezioni, e altre ancora. Un treno in corsa non si ferma nell'istante in cui il binario incontra una pendenza in salita e un virus in rapida diffusione non si ferma proprio quando viene raggiunta l'immunità di gruppo.
Come sta andando in Svezia
Secondo alcuni osservatori la Svezia ha adottato una gestione del contagio ispirata al principio dell'immunità di gruppo. Durante la prima ondata della pandemia in Europa, la Svezia ha applicato misure anticontagio meno draconiane di quelle applicate in altri paesi. Anche se in effetti non era l’obiettivo dichiarato delle autorità svedesi, il modello adottato nel paese scandinavo non sembra comunque essere sulla strada per il raggiungimento dell’immunità di gruppo (peraltro già alla fine di marzo la Svezia ha iniziato ad applicare misure più restrittive: chiusura di scuole e università, limitazioni degli spostamenti). Secondo i dati diffusi il 3 settembre dall’Agenzia per la salute pubblica svedese, l’11,4% degli abitanti di Stoccolma ha incontrato il nuovo coronavirus. Il 7,1% in tutta la Svezia. Percentuali lontane dalla stima del 40% che aveva ipotizzato Anders Tegnell, epidemiologo di Stato svedese.
Leggi anche >> Nuovo coronavirus: l’esperienza svedese è un esempio da seguire?
Queste indagini, dette di sieroprevalenza, permettono di individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi anche senza manifestare sintomi. In questo modo si può stimare la diffusione dell'epidemia nella popolazione. La percentuale registrata a Stoccolma è simile a quelle misurate in altri paesi europei, come la Spagna e l’Italia. Ma i valori che si riscontrano sono molto variabili anche all’interno dello stesso paese. In Lombardia la percentuale complessiva nella regione è del 7,5%, ma schizza al 24,5% in provincia di Bergamo, uno dei territori italiani più pesantemente colpiti dal virus.
Un’indagine svolta nella cittadina di Gangelt in Germania, dove è scoppiato uno dei più gravi focolai di COVID-19 del paese, ha riscontrato una sieroprevalenza del 15,5%. Anche in aree già molto colpite dalla pandemia, la sieroprevalenza sembra essere molto lontana da quella che dovrebbe essere la soglia minima dell’immunità di gruppo.
La Svezia è uno dei paesi che conta il maggior numero di vittime di COVID-19 ogni 100mila abitanti. Un'analisi pubblicata sul Journal of American Medical Association evidenzia che, tra i paesi con alta mortalità, la Svezia (insieme agli Stati Uniti) è stato quello che è riuscito ad abbatterla in modo meno drastico a partire da maggio e poi giugno, rispetto ad altri stati come l'Italia.
Leggi anche >> La Svezia, il lockdown e la seconda ondata
A Manaus, in Brasile, l'epidemia ha avuto un impatto devastante. Le indagini svolte un mese dopo il picco epidemico hanno misurato un livello di sieroprevalenza del 44% con una stima finale del 66%. Questi dati avevano fatto ipotizzare che in quell’area potesse essersi prodotta una certa immunità di gruppo. Ma a settembre, riporta l’agenzia Reuters, i casi nella città hanno ripreso ad aumentare e si è reso necessario chiudere alcune attività.
Il problema dell'immunità e i costi umani e sociali
Le considerazioni fatte finora sull’immunità di gruppo (e anche lo studio su Science, che ne stima un valore minimo un po’ più basso) si basano sull’assunzione che il nuovo coronavirus lasci un’immunità duratura nelle persone che infetta. Ma le conoscenze di cui finora disponiamo non ci danno certezze a riguardo. La maggior parte degli studi suggerisce che l’infezione da SARS-CoV-2 induce una protezione anticorpale che dura alcuni mesi. Sappiamo che i quattro coronavirus umani stagionali, che causano raffreddori, lasciano una protezione per circa un anno. L’immunità da coronavirus della SARS sembra durare circa 2-3 anni. Non siamo ancora certi di quanto persista l’immunità da SARS-CoV-2, ma le evidenze finora indicano che non sia molto persistente.
Gli scienziati si stanno interrogando sui casi di reinfezione che si registrano in diversi paesi e su quanto siano comuni e gravi rispetto alla prima infezione. Anche su questo non disponiamo di dati inequivocabili. Di certo, senza un vaccino efficace un’immunità non duratura non proteggerebbe a lungo nemmeno una popolazione già contagiata una prima volta. E senza altre misure di prevenzione continuerebbero a sussistere le condizioni per lo scoppio di nuovi focolai.
Come ricordano alcuni esperti dell’Università di Yale, finora non ci sono esempi di successo di strategie di contenimento di una malattia infettiva basate su una diffusione del contagio intenzionale e su larga scala allo scopo di raggiungere l'immunità di gruppo. In rari casi è stato osservato il raggiungimento della soglia di immunità di gruppo durante un’epidemia (il caso più recente e documentato è quello rappresentato dalla città di Salvador, in Brasile, durante l’epidemia causata dal virus Zika).
Una strategia basata sull'immunità di gruppo è un approccio impraticabile, che richiede un controllo prolungato nel tempo del contagio attraverso un improbabile bilanciamento di molteplici fattori epidemiologici scarsamente definiti, come afferma uno studio su PNAS. Uno scenario in cui sarebbe difficile evitare il collasso delle strutture ospedaliere. Anche non considerando tutte le difficoltà che abbiamo incontrato finora, dobbiamo infatti chiederci a quale prezzo verrebbe raggiunta un’immunità nella popolazione ottenuta con una sorta di epidemia controllata, senza cioè applicare misure drastiche che appiattiscano in breve tempo la curva del contagio. Anche con una letalità relativamente bassa, un nuovo patogeno come il SARS-CoV-2 potrebbe causare una mortalità notevole perché si diffonde in una popolazione che lo incontra per la prima volta.
Se assumiamo un tasso di letalità calcolato su tutte le persone infettate (compresi gli asintomatici) dello 0,5%, in un paese come gli Stati Uniti, che ha 330 milioni di abitanti, il SARS-CoV-2 dovrebbe contagiare circa 198 milioni di persone per raggiungere un’immunità di gruppo di circa il 60%. Questo comporterebbe un numero di morti aggiuntive pari a diverse centinaia di migliaia. Si possono azzardare stime più precise, anche ipotizzando una soglia di immunità di gruppo ottimistica (il 50% della popolazione): in Francia e negli Stati Uniti i morti potrebbero essere, rispettivamente, 100 - 400mila e 500mila - 2,1 milioni.
Questo è ciò che potrebbe accadere se lasciassimo circolare un virus come il SARS-CoV-2, che ha una letalità relativamente bassa ma un R0 mediamente più elevato di quello stimato per il virus della pandemia di influenza del 1918 (R0: circa 2) e per il virus della pandemia di influenza “suina” del 2009 (R0: 1,7).
La Great Barrington Declaration, dietro il paravento di una motivazione umanitaria («proteggiamo le persone vulnerabili»), ignora che le conseguenze peggiori ricadrebbero proprio sulle categorie più a rischio. Non solo gli anziani, ma anche tutti coloro che hanno almeno una condizione medica preesistente che aumenta il rischio di sviluppare una forma grave di COVID-19, come il diabete e l’obesità. Tom Frieden, ex direttore dei Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, scrive sul Washington Post che «la pura verità è che non possiamo proteggere i vulnerabili senza proteggere tutti noi».
Inoltre, come scrivono i firmatari dell'intervento su The Lancet, «un tale approccio rischia di esacerbare ulteriormente le disuguaglianze socioeconomiche e le discriminazioni strutturali già messe a nudo dalla pandemia». A pagare il prezzo più alto (come è già successo durante la prima ondata) sarebbero i più poveri ed emarginati, chi vive in abitazioni in cui sarebbe difficile isolarsi dal resto dei famigliari, i lavoratori di alcuni settori essenziali, più esposti al contagio.
C'è poi un'importante incognita riguardo all'impatto sanitario della pandemia: la COVID-19 è una malattia nuova e non sappiamo quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine della sua diffusione nella popolazione. Si è visto che il SARS-CoV-2 può lasciare sequele in chi ha contratto l'infezione soprattutto nelle forme più serie, un fenomeno chiamato "long COVID". Su 143 pazienti dimessi da un ospedale di Roma, l'87% riportava almeno un sintomo persistente a due mesi dalla prima manifestazione della malattia e il 55% segnalava tre o più sintomi. Il 53% riportava fatica, il 43,4% dispnea (respirazione difficoltosa), il 21,7% dolore al petto, il 44,1% una qualità della vita peggiorata.
Leggi anche >> Perché è importante capire gli effetti persistenti e a lungo termine della COVID-19
Gli studi spesso hanno preso in esame gruppi limitati di pazienti e saranno necessari altri dati e approfondimenti per chiarire il fenomeno del Long COVID. Ma ciò che è stato osservato finora indica che gli effetti a lungo termine della COVID-19 potrebbero costituire un problema di salute pubblica. SARS-CoV-2, come detto, è un virus nuovo. Lo stiamo studiando da meno di un anno. Si è capito, ad esempio, che sebbene la polmonite interstiziale sia la manifestazione più caratteristica delle forme più serie di COVID-19, il SARS-CoV-2 non è un virus capace di attaccare solo i polmoni. Può danneggiare anche altri sistemi e organi, come il cuore e il cervello.
Le evidenze scientifiche, l'incertezza che permane su diversi aspetti di questa nuova malattia, i costi sanitari e sociali: tutto questo dovrebbe spingerci ad accogliere con grande scetticismo le tesi della Great Barrington Declaration.
In conclusione: l'idea di combattere la pandemia con l'immunità di gruppo è scientificamente ed eticamente insostenibile.
Immagine in anteprima via Pixabay.com