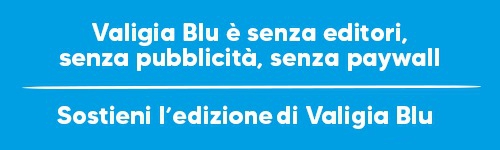Le politiche economiche di Trump potrebbero essere un’opportunità per l’Europa
10 min letturaGli Stati Uniti non sono più l’alleato prediletto dell’Europa. Non c’è da leggere tra le righe: il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha più volte dichiarato che “l’Europa ci ha trattato davvero male” e che l’idea stessa di un’unione degli Stati europei è nata per minacciare il primato degli Stati Uniti. Oltre alle parole, non mancano i provvedimenti presi dall’amministrazione Trump. Basti pensare ai rapporti privilegiati con il Presidente della Russia Vladimir Putin per quel che riguarda una fantomatica pace in Ucraina, lasciando l’Ucraina da sola e l’Europa in un angolo, ma anche ai dazi sull’acciaio e sull’alluminio al 25 per cento varati dall’amministrazione Trump il 12 di marzo. Questi dazi peseranno su un 5 per cento delle esportazioni dell’Europa negli Stati Uniti, per un valore di 26 miliardi di euro.
Ovviamente i dazi avranno ripercussioni sull’economia europea. Secondo le stime, i dazi che Trump ha e intende imporre sui prodotti europei per compensare lo squilibrio della bilancia commerciale potrebbero portare a una contrazione del PIL dell’Eurozonastimato tra l’1 e l’1,6 per cento.
Ma proprio questo mutamento nei rapporti tra i due paesi, assieme alle politiche economiche dell’amministrazione Trump, aprono varie opzioni per l’Europa, che a loro volta però non sono esenti da problematiche e rischi.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Dalle esportazioni in USA al mercato interno
Per comprendere perché i dazi potrebbero, in parte, rivelarsi un’opportunità per l’Europa è utile tracciare un parallelismo con quanto successo con il riarmo. Per garantire la propria autonomia strategica nel campo della difesa a fronte di un’amministrazione sempre più ostile, la Commissione europea e gli Stati membri hanno compreso la necessità di una maggior unità nel settore delle difesa, abbandonando dogmi come il debito che attanagliano certi paesi europei.
In modo tempestivo, al mutare degli eventi, l’Europa è stata in grado di virare la sua strategia per far fronte al mutato contesto geopolitico e allo stesso modo può fare nel caso dei dazi.
Per farlo, però, è necessario riprendere le indicazioni e le analisi fornite da Mario Draghi. Durante un simposio del Centre for Economic Policy Research (CEPR) nel dicembre del 2024, Draghi ha illustrato i problemi strutturali di un approccio basato sull’export come quello seguito dall’Europa. Gli eventi cardine di questa problematica risiederebbero in due crisi gemelle (twin crises).
La prima è lo shock di produttività avvenuto negli anni ‘90 con lo sviluppo di Internet che ha dato linfa vitale all’economia americana, mentre l’Europa è rimasta indietro su questo fronte. La seconda, invece, risiede nel differente approccio alla crisi del 2008 seguito dagli Stati Uniti e dall’Europa. Per contrastare la crisi finanziaria, gli USA sono ricorsi a politiche anticicliche che hanno iniettato risorse all’interno del sistema economico facendo leva sul debito. Ciò ha portato a una ripresa più rapida degli Stati Uniti che hanno visto, allo stesso tempo, un maggior afflusso di capitali.
L'Europa ha seguito una strada diversa, quella appunto di un’economia basata sull’export e sulla contrazione della domanda interna. L'esempio cardine è proprio il modello tedesco, assunto a paradigma dagli Stati europei per migliorare la propria competitività durante gli anni della crisi economica, come spiegato in un documento della Fondazione Robert Schuman. I paesi europei, in parte, hanno supportato questo modello perché la combinazione di bassi salari ed esportazioni avrebbe reso più competitivo il sistema economico e, soprattutto, garantito guadagni alle imprese.
La politica fiscale restrittiva ha giocato un ruolo fondamentale in questo processo. Come riferisce Draghi, tra il 2009 e il 2019 il governo statunitense ha iniettato nell’economia fondi quattordici volte superiori rispetto a quelli immessi in Europa.
Per invertire la rotta serve però una maggior integrazione tra gli Stati membri, soprattutto per quel che riguarda la piena attuazione del Mercato Unico Europeo e una rimozione delle barriere interne. Secondo le stime dell’International Monetary Fund (IMF), le barriere interne al mercato unico sono equivalenti a un dazio del 45 per cento per il settore manifatturiero e del 110 per cento per quello dei servizi. Sempre secondo l’IMF, se il mercato europeo funzionasse come quello americano la produttività del lavoro sarebbe del 7 per cento più elevata dopo 7 anni. Queste stesse barriere possono poi ridurre l’efficacia della politica fiscale, il secondo strumento che Draghi reputa centrale per il rilancio dell’economia europea.
Questi strumenti funzioneranno solo se saranno implementate delle riforme strutturali. Su questo aspetto il discorso di Draghi segna un punto di rottura che è necessario approfondire. Per anni, le riforme strutturali erano intese proprio come politiche per la flessibilizzazione del mercato del lavoro e la compressione salariale. Nel 2011 lo stesso Draghi aveva sposato questa direzione nella lettera scritta insieme a Jean-Claude Trichet (all’epoca Presidente della BCE). La situazione odierna richiede invece che queste politiche vadano a sostenere i lavoratori tramite la formazione, per aumentare la produttività. Draghi ha citato come paese di riferimento la Svezia e il suo modello di socialdemocrazia nordica. Agendo con la formazione dei lavoratori e stipendi elevati, il paese ha creato un sistema economico nel quale le imprese, per restare competitive sul mercato, non possono agire sulla compressione salariale o sulle tutele. Questo incentiva gli investimenti in capitale umano e innovazione, creando un’economia dinamica e innovativa che premia le aziende più efficienti.
Tuttavia, la strada per implementare quanto sostenuto da Draghi è in salita. Per quanto la Commissione europea abbia cercato di adottare i consigli del suo report, le divisioni interne rischiano di far cadere nel vuoto le proposte. A oggi quindi l’opportunità per l’Europa di sfruttare il proprio mercato interno, appare più come wishful thinking.
Rilanciare gli accordi commerciali: tra opportunità e limiti
L’export continuerà comunque a essere un componente importante dell’economia europea. Davanti ai dazi dell’amministrazione Trump sarà quindi necessario cercare altri partner commerciali per sostituire una parte delle esportazioni americane. Tra i due mercati più importanti con cui l’Europa è interessata a stringere rapporti ci sono il Mercosur, cioè il mercato composto da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, e l’India.
L’accordo, secondo le stime della commissione, avrebbe portato a una riduzione dei dazi del valore di 4 miliardi di euro, in un mercato che vale complessivamente 84 miliardi di export da parte dell’Europa. Prima dell’accordo, infatti, l’area del Mercosur presentava dazi a livello proibitivo per molte aziende, soprattutto nel settore manifatturiero: per il settore dell’automotive, si parlava di dazi del 35 per cento, mentre altri settori cruciali come farmaceutico e chimico arrivavano al 18 e 14 per cento rispettivamente. Inoltre l’accordo prevede la partecipazione da parte delle aziende europee ad appalti pubblici nei paesi. Di particolare importanza è il tema delle materie prime critiche, che sono al centro della strategia per la transizione dell’Europa. Gli Stati del Mercosur garantirebbero un maggior approvvigionamento per l’Europa a questo tipo di materiali, secondo l’accordo.
Se la commissione europea è favorevole, per la retifica servirà poi l’approvazione degli Stati membri. Tra questi, sia l’Italia sia la Francia hanno manifestato più di qualche perplessità. Gli agricoltori francesi, infatti, ritengono che una maggiore integrazione con il Mercosur rischierebbe di inondare l’Europa di beni come la carne bovina a basso prezzo, con possibili danni per il settore. Questo perché le regole sui quei prodotti dei paesi come Argentina e Brasile sono meno stringenti rispetto a quelle europee, permettendo quindi agli agricoltori di rivenderle a un prezzo più competitivo rispetto a quelli domestici qualora fossero azzerati i dazi. I parlamentari francesi hanno raccolto queste preoccupazioni in una lettera aperta su Le Monde, firmata da oltre 600 di loro. L’appello, lanciato da Yannick Jadot degli Ecologisti, ha inoltre puntualizzato che vi sono tre aspetti che è necessario tenere presente per la firma di questi accordi: in primo luogo non aumentare la cosiddetta “deforestazione importata” per i paesi dell'UE, il rispetto degli accordi di Parigi sul clima e infine, appunto, misure più stringenti sui prodotti.
Secondo i firmatari, questo tipo di accordi ha spinto i paesi dell’America Latina a destinare determinati campi alla coltivazione di soia e mangimi, andando ad aumentare la deforestazione e quindi aumentando l’emissione di gas serra. Non solo: anche le modalità di allevamento in questi paesi, che permettono mega fattorie e un utilizzo di antibiotici per favorire la crescita della massa del bovino, andrebbe a svantaggio degli allevatori europei. Proprio per far fronte a queste critiche il governo francese, nell'autunno dello scorso anno, ha ribadito alla commissione la contrarietà della Francia a questo tipo di accordo.
Anche il nostro paese ha cambiato idea sull’accordo. Durante il G20 a Rio de Janeiro infatti il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida aveva dichiarato che il governo Meloni si sarebbe opposto al trattato. A giocare un ruolo fondamentale sarebbe stata la Coldiretti, che rappresenta gli interessi di categoria degli agricoltori.
Dall’altra parte però ci sono paesi altrettanto importanti in Europa come la Germania. Per i tedeschi il mercato dell’automobile sudamericano è particolarmente interessante e per questo sono tra i più favorevoli all’accordo.
Tra le opzioni che la Commissione sta considerando per ratificare l’accordo c’è da una parte la creazione di sussidi per le categorie colpite, dall’altra la possibilità di spacchettare il voto sull’accordo. In questo caso, dal punto di vista giuridico, la Francia non potrebbe più mettere il veto in quanto il voto si svolgerebbe a maggioranza qualificata.
Per quel che riguarda invece l’India, a inizio anno la presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen ha annunciato alla platea del World Economic Forum a Davos che si sarebbe recata nel paese per riavviare il dialogo su un potenziale accordo commerciale. Il paese asiatico è una delle novità economiche più importanti degli ultimi decenni. In particolare dopo gli anni ‘90, il Prodotto Interno Lordo indiano ha avuto una crescita estremamente rapida, con un tempo di raddoppio di circa cinque anni. Nonostante oggi le prospettive di crescita siano leggermente meno rosee, l’economia indiana è in una fase di forte consolidamento con una classe media più ricca e un mercato dei capitali più stabile.
Per questo può rappresentare un mercato importante per l’Europa. Già nel 2021 vi erano stati dei primi passi verso un accordo, dopo che in passato i tentativi erano stati fallimentari. Il tema più importante riguarda, appunto, le barriere doganali e non che l’India impone sugli esportatori europei per salvaguardare la sua economia. Il fine dell’accordo, da parte europea, sarebbe proprio la riduzione di queste barriere al commercio che renderebbero più conveniente esportare verso l’India.
Ma, se i problemi dell’accordo con il Mercosur sono di natura economica, il rischio con l’India è di natura politica. Da anni il paese è governato da Narendra Modi, che secondo gli osservatori ha portato a una regressione della democrazia nella penisola. Non solo sul fronte interno Modi rappresenta un alleato discutibile, ma anche per quel che riguarda il suo atteggiamento sullo scacchiere internazionale.
L’India fa infatti parte dei BRICS, un raggruppamento di paesi che un tempo potevano essere classificati come economie emergenti e che punta a un mondo multipolare. All’interno dei BRICS, ci sono anche Russia e Cina, due paesi piuttosto ostili all’Europa. Ma mentre Modi continua a partecipare agli incontri dei BRICS e a spingere per un mondo multipolare, sa muoversi benissimo anche tra le cancellerie dei paesi occidentali. Questo atteggiamento ondivago non sembra preoccupare la commissione, che è intenzionata a finalizzare un primo accordo nella seconda metà dell’anno. Tutto dipenderà dalla situazione geopolitica internazionale e da quali saranno gli interessi di Modi al momento.
Un equilibrio tra pragmatismo e idealismo
Per quanto l’impatto dei dazi voluti da Trump, così come la nuova direzione seguita dall’amministrazione americana a livello economico, sarà probabilmente negativo almeno nel breve periodo, l’Europa si trova di fronte a nuove opportunità di crescita. La prima è un cambiamento radicale nell’organizzazione stessa del mercato e della visione dell’Europa a livello economico. Non si può pensare di competere con Stati come Cina e Stati Uniti se si è soltanto un raggruppamento di paesi spesso non allineati tra di loro: è necessario un mercato unico più efficace, con una strategia che punta a rilanciare l’innovazione attraverso la domanda e salari più alti, abbandonando quindi strategie di compressione salariale ed economia basata sull’export.
L’ostacolo tra quello che l’Europa di oggi e quella di domani, però, sta tutta nella volontà degli Stati membri. Davanti a una minaccia esistenziale come quella di un mondo dominato da super potenze come Cina e Stati Uniti, l’Europa deve scegliere se abbandonarsi a un destino di decadenza, come avviene oggi, o reagire.
La seconda opportunità riguarda la diversificazione dei partner commerciali, con gli accordi di libero scambio con Mercosur e India. Come abbiamo visto, entrambe le aree economiche presentano problematiche di non poco conto. Quello che si trova ad affrontare l’Europa, in questo caso, è cercare un equilibrio tra il pragmatismo- che vede in questi accordi nuove potenzialità di crescita- e l’idealismo- che sottolinea invece le problematicità. Non si tratta di una scelta facile, anzi. Ma è fondamentale comprendere quanto, in un mondo come quello di oggi, le decisioni siano lontane dall’essere semplici: meglio accettare le condizioni di Trump o pensare a una diversificazione dei partner commerciali, consapevoli che in entrambi ci sarà un prezzo da pagare. Soprattutto per quanto riguarda l’accordo con il Mercosur, tutto dipenderà anche da come l’Europa deciderà di compensare gli eventuali settori colpiti, senza cadere in un mito da globalizzazione anni ‘90 che ha portato le fasce più colpite a spostarsi verso movimenti reazionari e nazionalisti.
(Immagine anteprima via Flickr)