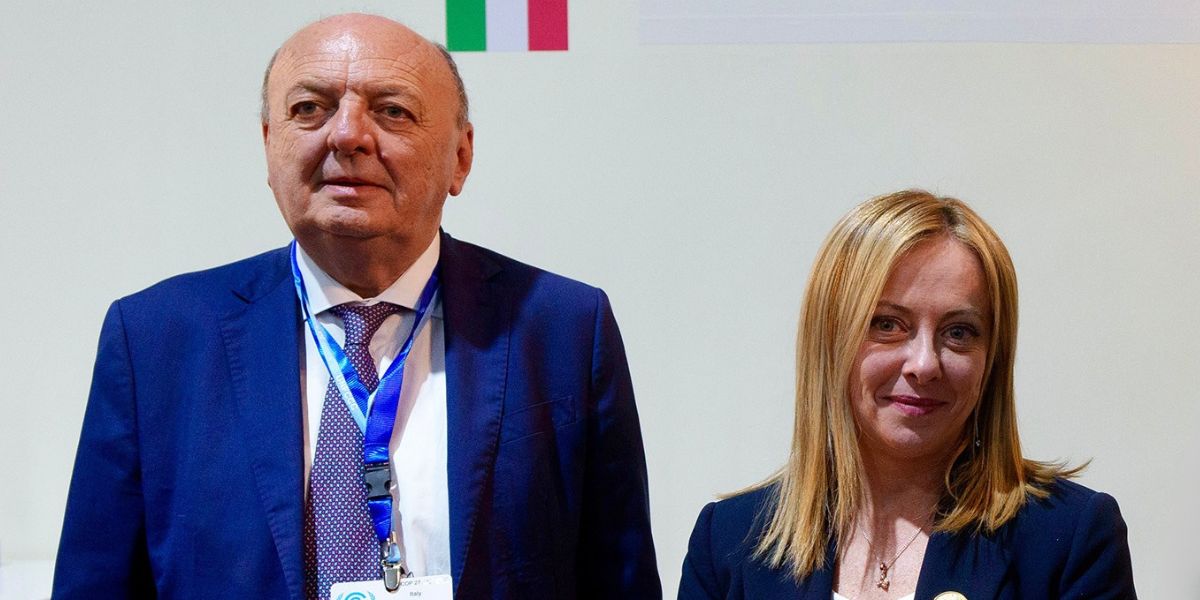Il Ministero della transizione ecologica: un problema (iper)politico per il governo Draghi
11 min letturaQuando, durante le consultazioni per la formazione del Governo, ho sentito parlare di un Ministero della transizione ecologica ho pensato che fosse un'innovazione positiva, che riprende esempi di ministeri simili istituiti in altri paesi. Una nota terminologica: preferirei il termine ambientale perché ormai ecologia è sinonimo di green e nel linguaggio corrente è una parola ormai logora che rimanda a cose come la raccolta differenziata, invece che alla branca delle scienze biologiche di cui spesso si ignora perfino l'esistenza come scienza. L'annuncio non si è tradotto esattamente nel super-ministero che si vagheggiava, ma il nuovo dicastero assorbirà comunque le competenze in materia energetica che oggi sono del Ministero dello sviluppo economico. Come giudicare perciò la decisione di istituire un Ministero della transizione ecologica, allargando quello che è l'attuale Ministero dell'ambiente?
Quella che chiamiamo "transizione ecologica" è una questione che ci pone di fronte alla necessità di ripensare le politiche in settori che vanno ben oltre il perimetro dei temi ambientali: politiche industriali, politiche economiche e fiscali (chi paga la transizione? Come attuare una transizione che sia anche socialmente equa?), l’energia, la salute pubblica, la gestione delle città, l’agricoltura, i trasporti, la gestione e la tutela del territorio, la ricerca scientifica, perfino la politica estera.
Per portare a termine una simile transizione, non basta certo un super-Ministero o un Ministero dell'ambiente "plus". Ciò che davvero è indispensabile è comprendere che la transizione ecologica riguarda ormai praticamente tutto ciò di cui si occupano i governi. Il fatto che il nuovo ministro «presiederà l’istituendo Comitato Interministeriale per il coordinamento delle attività concernenti la transizione ecologica» può essere interpretato come un'acquisizione di consapevolezza che quella transizione, al di là del perimetro delle competenze del nuovo dicastero, riguarda diversi altri ministeri, ambiti di competenze, settori di intervento del Governo. Rimane tuttavia da vedere come tutto questo si trasformerà in decisioni e in politiche.
Un approccio whole-government alla crisi climatica, dopo i quattro anni di negazionismo e politiche contro l'ambiente dell'era Trump, è quello che ha avviato l'Amministrazione Biden-Harris negli Stati Uniti: un'azione che richiede il coinvolgimento di ogni livello e agenzia del governo federale.
Tackling climate change will take every lever and agency of the federal government. That's why I've launched a whole-of-government approach to deal with the crisis.
— President Biden (@POTUS) January 27, 2021
Se questo è, in linea di principio, l'approccio più corretto ed efficace alla crisi climatica e ambientale, il punto diventa allora l'orientamento complessivo del governo. Il suo orientamento politico. A capo del Ministero dello sviluppo economico - che anche privato delle competenze in ambito energetico continua ad avere qualche rilevanza nella transizione ecologica - ci sarà un politico, Giancarlo Giorgetti, che è esponente di un partito dove prevalgono idee trumpiane e negazioniste sul cambiamento climatico. Giorgetti, in passato, ha tentato perfino di destinare fondi per ricerche sul raffreddamento globale causato dall'attività solare. Vecchie tesi negazioniste che la disinformazione ogni tanto fa riemergere.
Lo scorso ottobre il Parlamento europeo aveva votato a favore di un innalzamento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 60% entro il 2030, rispetto all'obiettivo precedente del 40%. I gruppi di destra hanno votato contro, compresi i parlamentari italiani di Fratelli d'Italia e Lega. Ma anche quelli di Forza Italia. Il Partito Popolare Europeo - parte della maggioranza che sostiene l'attuale Commissione - si era infatti diviso su questo voto. In seguito, a dicembre, il Consiglio europeo ha deciso a favore di un obiettivo del 55%.
Chiunque conosca un po' la storia del centrodestra italiano guidato da Silvio Berlusconi (per inciso: colui che quelli che oggi chiamiamo sovranisti li ha portati al governo per la prima volta nel 1994) sa quali tesi e posizioni sono da sempre circolate sui temi ambientali in quell'area politico-culturale. C'è poca differenza, in questo, tra destra sovranista e centrodestra europeista-liberale.
Il punto quindi, come detto, è l'orientamento politico di un governo come questo. Un governo in cui tutti i partiti, almeno dal PD alla Lega, sono, per dirne una, a favore della costruzione di nuove autostrade, cioè di una politica sulle infrastrutture che va contro la necessità di fermare il consumo di suolo (che sarebbe peraltro un altro obiettivo europeo). Una questione, il consumo di suolo, su cui al Senato c'è una discussione che si trascina da anni su diverse proposte di legge. È altamente probabile che questa legislatura non ne approverà nessuna.
Chi guiderà il nuovo ministero si dovrà inserire in questo contesto. Un contesto che, data la natura del governo presieduto da Mario Draghi, è (iper)politico più che tecnico. Il ministro sarà Roberto Cingolani, fisico, già direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e dal 2019 chief technology e innovation officer di Leonardo (ex Finmeccanica).
È la figura giusta per questo ruolo? Nessun giudizio sul valore e il curriculum della persona, si tratta di una domanda aperta. Scegliere una persona esperta in ecologia, climatologia, scienze ambientali per guidare un Ministero della transizione ecologica in effetti sarebbe stata un'inaudita provocazione perfino per un profilo tecnico. Ironia a parte, va ricordato che qualsiasi ministro dell'Ambiente potrebbe e dovrebbe trovare le competenze necessarie, per svolgere il suo compito, nel Ministero che dirige e negli enti scientifico-tecnici (ISPRA, CNR), nelle Università e nella comunità scientifica. Perché, a dispetto delle narrazioni superficiali e mitiche sulla competenza (che secondo la visione di qualcuno basterebbe per occuparsi di politica), in realtà servono più competenze, multidisciplinari, distribuite e collaborative. Un ministro non deve occuparsi da solo di tutto, di ogni aspetto scientifico e tecnico delle politiche che deve dirigere. E anche la competenza (vera o presunta) dei singoli non prescinde dalle loro visioni ideologiche.
La questione, perciò, non riguarda solo la preparazione scientifica, ma anche la visione d'insieme che anche un tecnico a capo di un ministero ha della materia di cui deve occuparsi. Una visione che deve trasformarsi in indirizzo politico. Perché qualsiasi scelta di governo, transizione ecologica compresa, è anche (spesso soprattutto) politica.
A febbraio del 2020, in un'intervista apparsa sul sito dell'ENI, Cingolani dichiarava:
«In questo momento il gas è uno dei mali minori: nel medio e lungo termine la risorsa più sostenibile, ma crea problemi per le infrastrutture e anche le tecnologie di trivellazione sono oggetto di molte discussioni».
L'affermazione (che, va detto, non sorprende leggere sul sito di una compagnia del settore oil&gas che investe ancora nelle energie fossili) si inserisce in una riflessione più ampia e articolata, per alcuni aspetti anche condivisibile, sulla complessità della questione energetica, i pro e contro di ogni singola soluzione, la necessità di ridurre gli ancora diffusi ed eccessivi sprechi di energia. Tuttavia da questo intervento, che dovrebbe evidenziare la complessità dei problemi che affronta, finisce per balzare all'occhio un'affermazione che suona un po' troppo tagliata con l'accetta anche al netto del ma che la segue: «il gas è uno dei mali minori: nel medio e lungo termine la risorsa più sostenibile».
Anche se emette il 50% in meno di CO2 rispetto al carbone e rimane in atmosfera per molto meno tempo (poco più di una decina d'anni), il metano, il principale componente del gas naturale, ha di per sé un potenziale di riscaldamento globale (una misura del calore assorbito da un gas emesso in atmosfera nell'unità di tempo calcolato rispetto alla CO2) 28 volte più grande della CO2 in un arco di tempo di 100 anni e 84 in 20 anni. Tradotto: è un gas serra molto potente, soprattutto nel breve termine in seguito alla sua immissione in atmosfera.
Sebbene relativamente più "pulito" delle altri fonti fossili, uno dei principali e irrisolti problemi del gas naturale è costituito dalle perdite che avvengono nella filiera di estrazione, stoccaggio, trasporto e utilizzo. Non è semplice quantificarle, ma stime riferite all'intero settore oil&gas degli Stati Uniti vanno dall'1,4 al 2,3% di tutto il gas prodotto. Oltre a essere di complessa quantificazione, l'ammontare di queste perdite è molto probabilmente sottovalutata. Un articolo su Scientific American pubblicato nel 2020 afferma che «gli scienziati hanno prodotto dozzine di studi nell'ultimo decennio che suggeriscono che i metodi e la tecnologia attuali utilizzati dall'industria per rilevare le perdite [di metano] - e dai regolatori per stimare la quantità di metano emesso - non sono sufficienti per cogliere la portata effettiva del problema». Secondo uno studio pubblicato su Science nel 2018, di nuovo riferito al contesto americano, le perdite di metano dal sistema oil&gas sono maggiori di circa il 60% rispetto a quanto stimato dall'Environmental Protection Agency (l'agenzia federale americana di protezione dell'ambiente).
Consideriamo che le attività umane contribuiscono per il 60% alle emissioni globali di metano e, secondo uno studio, nel 2017 erano aumentate del 9% rispetto alla media del periodo 2000-2006, in particolare a causa del settore agricolo-zootecnico e della gestione dei rifiuti. Gli autori di una ricerca pubblicata nel 2020 su Nature hanno calcolato che le emissioni antropiche di metano, dall'era preindustriale ad oggi, sono maggiori del 25-40% di quanto precedentemente stimato. Il metano che finisce in atmosfera era quasi tutto di origine non antropica fino alla seconda metà dell''800.
Ora, riconosciamo che la CO2 nel lungo termine (ovvero: secoli) è un gas-serra di cui preoccuparsi di più rispetto al metano. Ma anche la combustione del metano emette C02, sebbene meno rispetto ad altre fonti fossili. E, anche tralasciando il problema delle perdite lungo la filiera industriale e di consumo, è evidente, come nota il climatologo Michael Mann, che «la soluzione di un problema causato dall'uso dei combustili fossili non può essere l'uso dei combustibili fossili».
“The greatest fault in his proposal is the suggestion that natural gas can be part of the solution,” Michael Mann, a climate scientist at Penn State University, said by email. “The solution to a problem created by burning fossil fuels cannot be the burning of fossil fuels.”
— Michael E. Mann (@MichaelEMann) May 10, 2019
Il gas naturale, al punto in cui siamo, non può essere più una fonte di transizione. Lo è stato in passato e ha contribuito a ridurre le emissioni di CO2 quando ha sostituito il carbone. Ma proseguire nel suo sfruttamento è una scelta non compatibile con l'obiettivo, fissato dall'Accordo di Parigi, di contenere il riscaldamento globale a 1,5-2 gradi centigradi (siamo ormai già oltre l'1). Scegliere il male minore non è più sufficiente per evitare gli scenari peggiori.
Nell'intervista a Cingolani lascia perplessi anche il giudizio sulle fonti energetiche rinnovabili:
«Le rinnovabili sono le energie meno impattanti ma bisogna fare investimenti e non risolvono tutti i problemi, soprattutto non sono utilizzabili in maniera continua come vogliamo e dove vogliamo».
Che si debbano fare investimenti, non c'è dubbio. Che non risolvano tutti i problemi, anche. Intanto, l'energia solare e quella eolica ne risolvono almeno due: abbattono le emissioni di gas serra, che nel loro intero ciclo di vita sono estremamente più basse di quelle prodotte dai combustibili fossili; il loro impiego non emette inquinanti atmosferici come il particolato (effetto serra e inquinamento atmosferico sono due problemi collegati ma di natura diversa). Secondo uno studio pubblicato su Environmental Research, al particolato PM2,5 prodotto dall'uso dei combustibili fossili vanno attribuiti più di 8 milioni di decessi in tutto il mondo, una cifra più alta di quanto stimato in precedenza.
Le fonti rinnovabili sono protagoniste di una transizione energetica che è in corso da anni nei paesi che sono i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra: Stati Uniti, Europa, Cina. La transizione infatti sta già avvenendo. Si tratta però di accelerarla verso l'unico esito compatibile con gli obiettivi di Parigi ed europei. Lo scorso ottobre, tra l'altro, l'Agenzia Internazionale dell'Energia riportava, nel World Energy Outlook 2020, che quella solare è diventata la fonte energetica più economica della storia. Nel 2020 le energie rinnovabili per la prima volta sono diventate la principale fonte di elettricità dell'Unione europea, superando il contributo dei combustibili fossili.
Non c'è da dubitare che il nuovo ministro della Transizione ecologica sia consapevole di tutti questi aspetti e che il suo giudizio sul futuro delle energie rinnovabili sia più in linea con le tendenze che si sono delineate a livello globale di quanto possa apparire in quell'intervista. Ma, in ogni caso, la questione della transizione ambientale deve essere affrontata da una prospettiva, anche scientifica, ampia e non si può ridurre nemmeno a una mera questione tecnologica. Riguarda, come detto, un vasto e profondo ripensamento delle scelte e delle azioni in molti settori. A partire dalla tutela della biodiversità, del suolo, dell'aria e dei mari. Un ripensamento che deve essere informato da una visione di insieme e di lungo termine, scientifica e politica.
Il riscaldamento globale genera una vastità di conseguenze che spesso fatichiamo a realizzare. Questo fenomeno sta avendo un impatto perfino sul sistema di produzione di energia elettrica. Le centrali termoelettriche a gas, carbone e nucleari, che producono ancora la gran parte dell'elettricità a livello globale, risentono dell'aumento della temperatura terrestre e della frequenza delle siccità e delle ondate di calore. Questi impianti si trovano di solito vicino a fiumi e laghi dal momento che impiegano l'acqua per disperdere il calore generato. Nei giorni più caldi, quando si registrano picchi della domanda di elettricità per alimentare tra l'altro i sistemi di condizionamento dell'aria, l'aumento della temperatura atmosferica e dell'acqua può rendere necessario rallentare gli impianti, diminuendo così la produzione di elettricità. Lo ha evidenziato uno studio pubblicato su Environmental Research Letters, che stima un taglio della produzione di energia elettrica dello 0,8-1,2% per ogni grado centigrado di aumento della temperatura terrestre. Questo equivarrebbe a un buco di capacità di produzione di energia elettrica di 18-27 gigawatt, che dovrebbe essere compensato con la produzione di decine di nuove centrali di medie dimensioni.
Per mettere questo dato in prospettiva, come osservano gli autori dello studio in un commento su Carbon Brief, si può ricordare quanto accaduto in Francia nel 2019, quando durante un'ondata di calore la produzione nazionale di energia nucleare è stata ridotta di circa l'8%. In un mondo più caldo queste cifre potrebbero aumentare, soprattutto se dovessero realizzarsi gli scenari più gravi di aumento della temperatura. Ma, notano gli autori, questi scenari e la magnitudine degli impatti dipendono dalle decisioni che prenderemo oggi. Il sistema di produzione di energia elettrica globale è sia una causa che una vittima del cambiamento climatico. Per questo motivo, concludono gli esperti, un sistema sempre più basato su fonti rinnovabili, come il solare e l'eolico, meno esposte agli effetti del riscaldamento globale, rappresenterebbe un win-win: meno emissioni climalteranti (fino a raggiungere zero emissioni) e un sistema di produzione energetico meno vulnerabile.
Tutto ciò dimostra che minimizzare o ignorare la realtà della crisi climatica e ritardare le politiche necessarie per risolverla, oltre ad avere conseguenze devastanti su molti ecosistemi, non farà che aumentare i costi che dovremo sopportare, anche economici. Purtroppo, quando parliamo di crisi climatica e ambientale, le cose non vanno meglio di come pensiamo, come recitava il sottotitolo di un libro pubblicato qualche anno fa. Tendenzialmente, anzi, vanno peggio. La transizione ecologica perciò non può ridursi a una spruzzata di tecno-ottimismo sullo status quo.
Gli autori di uno studio pubblicato su The Cryosphere riportano che la Terra ha perso 28 trilioni di tonnellate di ghiaccio tra il 1994 e il 2017. Il tasso di perdita di ghiaccio è aumentato del 57%, rispetto agli anni '90, un dato che è in linea con gli scenari peggiori previsti dall'Intergovernmental Panel on Climate Change.
Questo è il mondo nuovo in cui ci troviamo a vivere oggi.
Non ci si può nascondere che, a dispetto dell'importanza e dell'urgenza della crisi climatica e ambientale, il rischio del greenwashing, cioè di un'operazione verde di facciata che preserva lo status quo (come quella che caratterizza l'azione e il marketing di alcune compagnie del settore oil&gas), rimane elevato anche nel caso delle politiche che dovranno essere decise nell'ambito del Recovery Plan. Per scongiurarlo, saranno necessarie anche l'attenzione, la consapevolezza e la partecipazione da parte dell'opinione pubblica. Anche la transizione ecologica è una questione che riguarda la democrazia.
Una nota conclusiva: ora che finalmente anche i più distratti, tra i commentatori, sembrano essersi accorti che la transizione ecologica è un tema centrale nel Recovery Plan, anche per le risorse che dovrebbero essere destinate a questo settore, facciamo in modo che a spiegarci come debba essere condotta non sia chi nell'ultimo decennio ha negato o minimizzato l'entità e l'impatto di quella crisi che oggi siamo chiamati ad affrontare.
Immagine anteprima Gerd Altmann via Pixabay