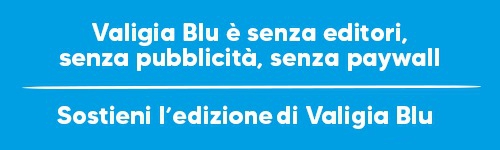Maschiocrazia: perché il potere ha un genere solo (e come cambiare)
6 min letturaPubblichiamo un estratto dal libro, pubblicato da Codice Edizioni, 'Maschiocrazia. Perché il potere ha un genere solo (e come cambiare)' di Emanuela Grigliè, giornalista esperta principalmente di cultura digitale e questioni di genere, e Guido Romeo, giornalista esperto di innovazione ed economia digitale, data journalism e trasparenza dell’informazione.
Come si cambia un mondo obsoleto, discriminatorio, inefficiente, disegnato per un maschio ideale e che, attraverso istituzioni, linguaggi e algoritmi - ma anche piani urbanistici, farmaci, auto e telefonini, etc etc -, non rappresenta la reale diversità del mondo?
Non si può parlare di cambiamento vero senza prima interrogare il potere, inteso come la capacità di influenzare e condizionare azioni e comportamenti altrui. E per capire cosa può innescare un’evoluzione è centrale indagare i meccanismi di costruzione della leadership. Occuparsi del “posto delle donne” fa emergere grandi temi che oggi siamo tutti chiamati ad affrontare. Da quello della rappresentanza politica, perché la democrazia esiste da oltre duemila anni, ma oltre la metà della popolazione dei Paesi più avanzati ha cominciato a votare solo negli ultimi cento (in Italia da ottant’anni); a quello delle sfide dell’intelligenza artificiale che hanno già mostrato un impatto su tutti i settori, dall’informazione alle relazioni umane. Per non dire poi che l’Italia, una delle prime otto potenze industriali del mondo e la seconda manifattura d’Europa, oggi alle prese con il calo demografico e di produttività, sembra ostinarsi ad avere più del 40% della popolazione attiva inoccupata per mancanza di politiche adeguate a sostegno del lavoro femminile. Ultima ed egualmente centrale questione in cui la lente di genere si mostra importante è la crisi climatica, la nostra capacità di reazione ai disastri ambientali, in crescita per l’estremizzazione del clima, alla polarizzazione informativa e alle pandemie.
Dati alla mano, vediamo che l’avanzata della parità di genere non appare come pura propaganda. L’Italia, che in meno di un anno ha espresso due leader donne under-50 alla guida dei primi due partiti, è un laboratorio al quale tutti guardano. Un laboratorio dove le donne che hanno potere vero sono ancora poche, come ricordato pure dal presidente Sergio Mattarella:
«Oggi tante donne sono parte della classe dirigente del Paese e, tuttavia, la minore inclusione femminile nel mondo del lavoro e nei ruoli di maggiore responsabilità costituisce ancora un grave deficit sociale e priva il Paese di qualità essenziali».
Oppure ci tocca festeggiare che, per la prima volta dal 2018, le donne CEO hanno superato come numero gli uomini che si chiamano John. Dal 2006 al 2023 la quota media di parlamentari donne nel mondo è passata dal 14,9% al 22,5%, secondo l’ultimo Global Gender Gap Report del World Economic Forum, e il numero medio di ministre è quasi raddoppiato. Tanto che, dal Quirinale all’Eliseo passando per la Casa Bianca, partiti, opinionisti, attivisti e influencer invocano una donna al comando supremo come segno di svolta verso una società più moderna, efficiente, giusta. In una parola: migliore.
Alla prova dei fatti, però, nella politica come nell’economia e nella società tutta, il potere femminile oggi è ancora ben lontano dall’essere consolidato e strutturato in una rete influente e capillare, tale da produrre un cambiamento effettivo. In media, dal 1995 a oggi la quota di donne come capi di Stato o di governo è rimasta ferma intorno al 10% e nel mercato del lavoro le donne occupano meno di un terzo delle posizioni dirigenziali. Inoltre, seppure in 59 Paesi le donne sono più qualificate e istruite, il divario medio di reddito tra i sessi rimane uno sbalorditivo 39% a favore degli uomini. Insomma, i casi eccellenti hanno un valore innegabile da un punto di vista simbolico, ma restano troppo sporadici per mutare alla radice fisionomia e modello di leadership di quella che abbiamo chiamato maschiocrazia.
Ci siamo perciò chiesti se, a dispetto della sbandierata aspirazione a una società più giusta e moderna, vogliamo davvero cambiare. Uno dei principali problemi è che siamo tutti (sì, anche le donne e i ragazzi più o meno fluidi della GenZ) molto più maschilisti e conservatori di quanto siamo disposti ad ammettere.
L’Indice di Reykjavík, che valuta gli atteggiamenti nei confronti della leadership femminile nei Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti), mostra che negli ultimi cinque anni la propensione dei cittadini delle democrazie più avanzate a vedere una donna al vertice non è aumentata di una virgola, nonostante gli shock del #MeToo e del Covid che si sperava producessero un cambio di rotta. Addirittura più di un quarto degli intervistati ha ammesso di essere arrabbiato o turbato al pensiero di un presidente donna, quando questa domanda era “nascosta” tra le altre e quindi non generava ansie di accettabilità sociale. Perfino nella Germania che Angela Merkel ha governato ininterrottamente per vent’anni, soltanto il 41% dei cittadini afferma di sentirsi a proprio agio con una donna capo del governo.
Tutto ciò contribuisce a spiegare perché non è affatto un paradosso che le donne che arrivano a governare una nazione vengano soprattutto da partiti conservatori o di destra. Da Margaret Thatcher alle presidenze femminili nei Paesi dell’America Latina, da Angela Merkel a Roberta Metsola, passando per Theresa May e Liz Truss, le donne conservatrici hanno statisticamente più chance di farcela. Sono donne che non intaccano la costruzione patriarcale e che sono quindi avvertite come meno pericolose perché portatrici di un cambiamento non troppo radicale.
La preferenza verso un certo tipo di leader è un problema sociologico e culturale a più dimensioni. La prima dimensione è che, indipendentemente dal nostro genere di appartenenza, tendiamo ad associare la capacità di comando alla forza. Sopravvive così un modello di potere che è quello della maschiocrazia: l’uomo solo che guida e che produce leader fotocopia di se stesso. Inoltre, il genere non sembra un fattore determinante quando si deve scegliere per chi votare: non è vero infatti che le donne votano preferibilmente per altre donne. Lo sa bene Hillary Clinton, prima candidata donna alla Casa Bianca, tradita nel suffragio popolare di novembre 2016 proprio dalle donne apparentemente a lei più vicine.
Analisi dettagliate hanno mostrato inoltre che il genere non è particolarmente determinante neanche per intercettare quale tipo di coalizione politica – progressista o conservatrice – le elettrici appoggeranno. Negli anni Cinquanta quasi tutte le democrazie occidentali avevano registrato un gap di genere elettorale per cui le donne votavano in modo differente rispetto agli uomini. Ma negli anni il trend si è assottigliato, e oggi in Italia non ci sono differenze sensibili tra il comportamento dell’elettorato maschile e quello femminile.
Siamo insomma destinati a non cambiare? Noi non abbiamo perso la speranza perché, come ci ha fatto notare Agnese Pini, una delle poche direttrici di quotidiani in Italia, storicamente le discontinuità arrivano dalla periferia del sistema, con numeri che inizialmente sembrano sempre esigui. E i segnali per avere speranza sono reali. La diversità di genere nei governi è stata associata a una diminuzione della corruzione. Un’analisi degli economisti Chandan Jha e Sudipta Sarangi su oltre 125 Paesi ha rilevato che i livelli di corruzione sono più bassi in quelli con una percentuale più alta di donne legislatrici {…}. Durante il Covid sono state proprio molte leader donne a guidare i Paesi che hanno elaborato le soluzioni migliori. Dal “contact-tracing” messo tempestivamente in campo dalla presidente taiwanese Tsai Ing-wen, al bloc- co anticipato del Paese della prima ministra danese Mette Frederiksen, ai test gratuiti a tutti della premier islandese Katrín Jakobsdóttir, fino all’aplomb rassicurante della cancelliera tedesca Angela Merkel.
Lungi però da noi riproporre il refrain che un mondo con più donne al comando sarebbe migliore, anche perché, come ha osservato la scrittrice Veronica Raimo, la presenza di donne leader non è un segno positivo “a prescindere”. A forza di essere declinato in “femonazionalismo”, “femminismo neocon” e altre varianti, le istanze femministe legate ad ambiente e diritti si sono sfilacciate trasformando il “girl power” in fenomeno mainstream, rivelando il rischio di essere un sottoprodotto di quella maschiocrazia in cui le donne, preso il potere, non agiscono diversamente dai loro colleghi maschi.
Ciò che speriamo di aver avvistato alla fine della nostra indagine, e tra le luci e le ombre che ha prodotto, è la possibilità di un’evoluzione del paradigma di potere che si allontani da quello incentrato sull’uomo forte, a favore di uno più distribuito, imperniato su inclusività e abilitazione delle competenze.
Il modello di leadership “maschiocentrico” non sembra infatti efficace per affrontare le sfide più complesse del nostro tempo, dalla transizione energetica alle nuove tecnologie dell’automazione che stravolgono il lavoro e i rapporti sociali. Così, se è irrealistico aspettarsi che una singola figura apicale (donna o altro) che agisce assecondando un modello unico e vetusto possa creare un cambiamento radicale, è invece la trasformazione delle infrastrutture e della definizione stessa del potere che può fare la differenza. L’obiettivo cui ambire è perciò un punto di riferimento meno rigido e non verticistico, ma diffuso, in grado di unire più forze e avere maggiore attenzione a tutte le diversità che attraversano la società, dal genere all’etnia e all’età. Insomma, è innanzitutto l’attuale stereotipo del potere che va contrastato. Per affrontare sfide complesse si deve evolvere. Vale per tutti, donne e uomini, e bisogna farlo attraverso un dialogo informato dai dati più che dalle ideologie e dalle mode del momento.
Immagine in anteprima via Codice