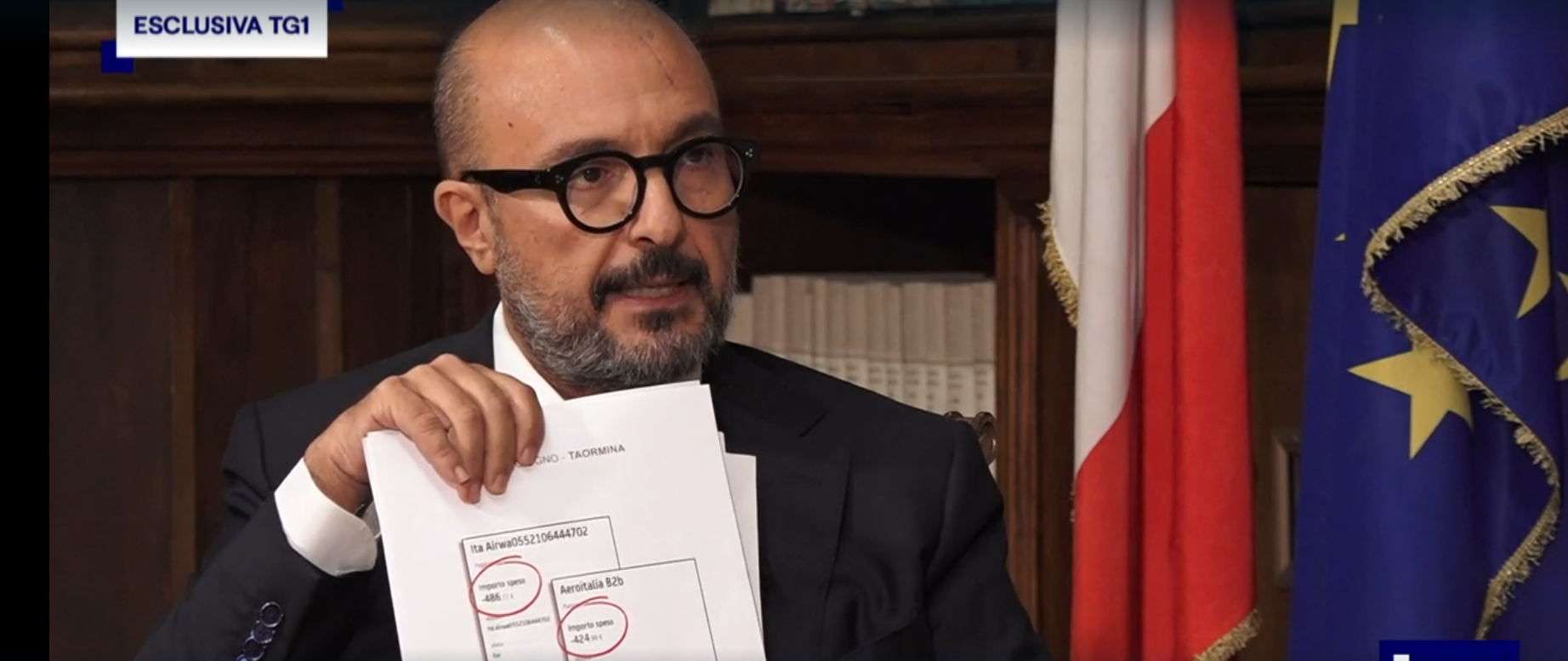Il Marocco sfiora la finale ai mondiali in Qatar. Segni, simboli e storie del football arabo, oltre gli stereotipi
5 min letturaNo, non è da oggi. Non è nemmeno da ieri che in Marocco si gioca a calcio. Neanche dall’altro ieri, a dire il vero, che in Marocco si ama il calcio. E non solo a Casablanca, ma in tutti gli “snodi” della regione araba.
Come sempre, anche nel caso del calcio la semplificazione che governa l’informazione italiana perde di vista non solo la dimensione storica, ma le stesse coordinate geografiche. Dipende – anche – dal punto di osservazione. Stavolta non è l’Italia. È il Qàtar. Cosicché, la cronaca che arriva da noi parla di un “mondo arabo” filtrato con gli occhi del Golfo, con gli occhi del Qàtar e di alcuni dei paesi della penisola arabica dove, nel corso degli ultimi decenni, i calciatori arabi sono semmai arrivati da altre latitudini, e si sono spesso naturalizzati per riuscire a raggiungere il proprio sogno. Fare il calciatore ed essere ben pagato.
Non tutta la regione araba può essere schiacciata su ciò che si vede nei panorami spesso artificiali di Doha o di Dubai. E il calcio è una delle tante cartine di tornasole che mostrano una striscia di mondo, dalle coste atlantiche al Golfo Persico fin nel nord del Levante, decisamente frastagliata, diversificata, anche frammentata.
Proviamo, allora, a fare un salto di oltre settemila chilometri, da Doha a Casablanca. Non a caso Casablanca, e cioè il cuore del calcio marocchino. Che il football sia uno sport popolare lo si capisce subito dalla spiaggia, enorme, oceanica, travolgente a partire da quel rumore incessante del mare che copre tutto. Le voci, le parole. Le centinaia, le migliaia di ragazzi che organizzano – in contemporanea – partite sulla spiaggia riempiono di significati infiniti quei gesti che appaiono automatici all’osservatrice: le porte improvvisate con qualche indumento, la perfetta divisione tra “campetti” in cui le due “quadre” si affrontano, la concentrazione che rende le singole squadre le protagoniste di una spiaggia enorme.
Dalla spiaggia, dallo sport per tutti alla professione di calciatori il passo può – non sempre e non spesso – essere breve. In ogni caso, è un sogno per molti di quei ragazzi, lo stesso sogno che ascoltiamo, soprattutto, nei diversi sud. E comunque, se pure non diventa realtà, la passione è la stessa che viene riversata sugli spalti, dove il tifo è diffuso, e può essere intriso di profondi significati politici.
In parte lo abbiamo visto in queste settimane dei mondiali del Qàtar. La bandiera palestinese esibita dai calciatori della nazionale marocchina, e sugli spalti degli stadi qatarini, è solo uno dei gli indicatori di un rapporto tra calcio e politica che segna, da oltre un decennio, almeno dal 2010, tutta la fascia dell’Africa settentrionale, da Casablanca al Cairo, passando per Algeri e Tunisi. Ancora una volta, nel caso del Marocco, è Casablanca il cuore della dimensione politica del calcio, come ben racconta la giornalista marocchina Aida Alami in un articolo molto interessante pubblicato nel 2018 sulla New York Review of Books. Un esempio fra tutti, forse quello che ha lasciato più traccia e ha segnato un anno preciso della storia recente araba, è un canto da stadio della squadra più famosa di Casablanca, il Raja. È Fbladi dalmouni, canto nato appunto tra i tifosi del Raja, poi irraggiatosi non solo in Marocco, ma anche nella confinante Algeria. E che un canto da stadio tracimi oltre un confine ormai chiuso, e tra due paesi che hanno persino rischiato pochi mesi fa una rottura plateale delle relazioni diplomatiche per la questione sahrawi, dice molto dello iato tra la politica dei governi e le relazioni tra i popoli. Le relazioni tra i tifosi.
"Nel mio paese soffro per l’ingiustizia", dice il canto da stadio marocchino. E qualcuno, per le strade algerine, l’ha preso a prestito in un anno determinante per l’Algeria: il 2019, l’anno dello hirak, del movimento di protesta di massa nelle città algerine che ha bloccato l’ennesima candidatura di Abdelaziz Bouteflika, ormai malato, alle presidenziali.
Non è, d’altro canto, un unicum nella storia recente delle sollevazioni e delle rivoluzioni arabe. Al Cairo, nella rivoluzione iniziata il 25 gennaio del 2011, sono stati gli ultras delle squadre di calcio della capitale egiziana a difendere piazza Tahrir. Perché gli ultras dello Ahly e dello Zamalek avevano già da tempo una – per così dire – consuetudine negli scontri con la polizia per le strade. Un anno prima della rivoluzione, era all’incirca il febbraio del 2010, gli ultras avevano fatto parlare di sé dopo una partita della nazionale egiziana, durante il periodo di fuoco della qualificazione ai campionati mondiali, persa dall’Egitto. La qualificazione era stata usata, malamente, dai figli di Hosni Mubarak per guadagnare consensi, e dalla famiglia del presidente per spianare la strada all’ascesa al potere di Gamal, il figlio scelto per trasformare il paese in una cosiddetta “repubblica ereditaria”. Allora, nel 2010, i tifosi diedero vita, per la prima volta, a una particolare guerriglia urbana al centro del Cairo. Compreso il quartiere bene di Zamalek, dove venne addirittura rovesciato un cellulare della polizia, un veicolo simbolo della repressione e della paura, utilizzato per contenere le persone arrestate da condurre poi nei centri interrogatori dove, in molte, sarebbero state anche torturate.
Una riflessione finale sulla questione della bandiera palestinese esibita da calciatori e tifosi marocchini (e non solo). Il 14 dicembre il Jerusalem Post, quotidiano conservatore israeliano in lingua inglese, aveva una prima pagina molto particolare. Un fotomontaggio a tutta pagina, sotto il titolo: “Siamo tutti marocchini”, in cui compaiono alcuni giocatori della nazionale marocchina, la Cupola della Roccia, e il grido-simbolo della galoppata del Marocco verso la semifinale: “Siiir, go”, anche in arabo. È una prima pagina che arriva dopo l’esibizione della bandiera palestinese che ha guadagnato spazio nell’informazione globale. Un dettaglio di non poco conto.

Quella del Jerusalem Post è, a mio parere, anzitutto un tentativo di riguadagnare uno spazio mediatico. Dal punto di vista politico, inoltre, il giornale tenta in questo modo di non far schiacciare la meravigliosa avventura marocchina ai mondiali in una narrazione filopalestinese. Il Marocco di Mohammed VI ha normalizzato i rapporti con Israele, paese con cui ha anche rafforzato intese sul piano militare, culminate a luglio con la visita del capo di stato maggiore israeliano Aviv Kochavi a Rabat. Israele, dunque, può tifare Marocco, cercando di annullare la dimensione filopalestinese dalla narrazione, per ora imperante. Persino la Cupola della Roccia viene in questo modo deprivata dal suo significato religioso, di terzo luogo santo dell’islam come tutta la Spianata delle Moschee: la Cupola della Roccia diventa solo logo, logo di Gerusalemme, come da anni Israele tenta di fare, trasformandolo in un simbolo in absentia del Monte del Tempio. Non bisogna peraltro dimenticare che in Israele vive una comunità ebraica di origine marocchina ancora oggi profondamente legata alle città di origine, soprattutto Fez e Casablanca: i mizrahim tifano con orgoglio Marocco, un paese mai dimenticato e in cui tornano non solo coloro che lo lasciarono all’inizio degli anni Cinquanta, ma i loro figli e nipoti.
*Articolo pubblicato anche su Lettera22 e su Invisible Arabs, il blog di Paola Caridi sugli arabi invisibili
Immagine in anteprima via orientxii.info