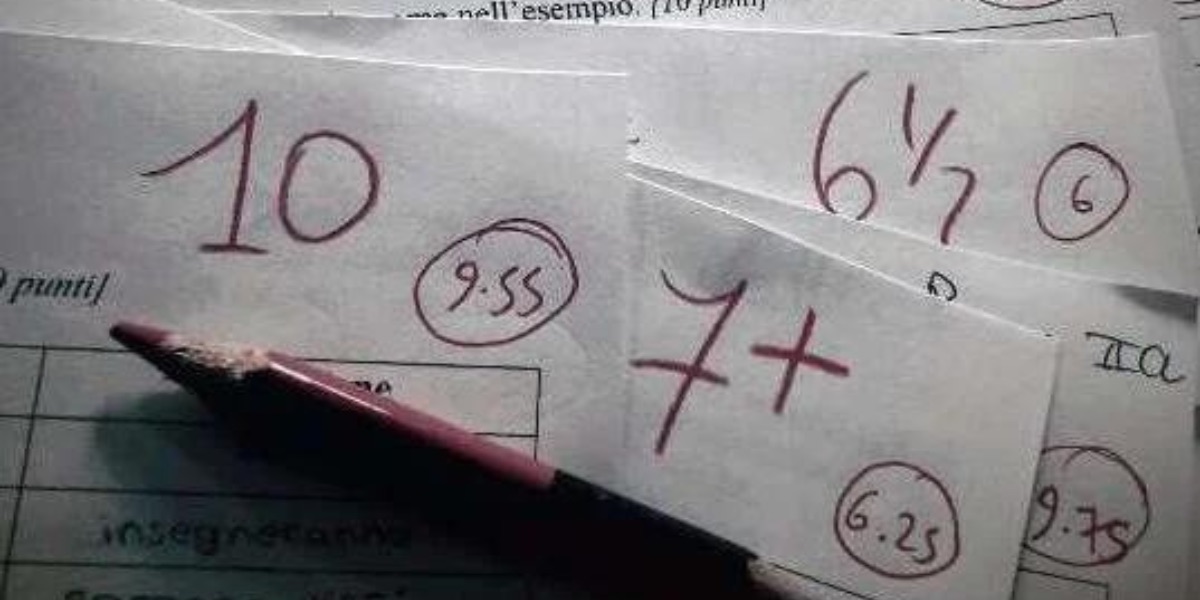Le manifestazioni contro il green pass, la direttiva del Viminale e la gestione dell’ordine pubblico
14 min letturaIn quest’epoca pandemica le proteste contro le misure sanitarie in atto sono ormai una costante, per modalità e, spesso, anche per aderenti. Si era iniziato a fine maggio 2020, con le manifestazioni dei gilet arancioni guidate dal generale Pappalardo (già animatore del movimento dei Forconi e degradato per motivi disciplinari) e con la manifestazione romana convocata dal centrodestra unito il 2 giugno 2020. All’epoca, le proteste oscillavano tra no mask e commercianti che pretendevano riaperture, poi convogliati nel movimento Io Apro. La richiesta di aprire s’accompagnava all’insofferenza verso le precauzioni richieste, le restrizioni ai diversi esercizi commerciali applicati secondo le zone e, infine, da ultimo, contro le norme sulla certificazione verde. Contro il green pass si sono concentrate le proteste degli ultimi mesi, acuite dalla scelta di imporre l’esibizione della certificazione anche per l’accesso ai luoghi di lavoro. La mobilitazione è variegata, ma sono giunti agli onori della cronaca principalmente l’evento del 9 ottobre 2021 a Roma, in piazza del Popolo, culminato nell’assalto alla sede della CGIL, l’annunciato blocco dei portuali di Trieste e le manifestazioni settimanali in diverse città. Proprio in riferimento a queste ultime, è stata annunciata una stretta del Viminale sui cortei e, dopo le anticipazioni del sottosegretario Sibilia, è stata emanata dalla ministra Lamorgese una direttiva per la gestione dell’ordine pubblico.
È il caso di chiarirlo subito: la circolare ministeriale in questione non minaccia la libertà di manifestare né cambia la disciplina sull’ordine pubblico. Peraltro non ne avrebbe nemmeno il potere, dal momento che si tratta di una direttiva: le direttive o circolari sono degli atti interni, che non costituiscono fonte di diritto ma che sono rivolti, normalmente con funzione interpretativa, agli organi di un particolare ufficio (in questo caso, ai prefetti e ai funzionari di pubblica sicurezza), senza essere vincolanti per i cittadini. Il testo emanato dal Viminale si limita infatti a far riferimento a norme e prassi già in atto. Nel merito, la direttiva ministeriale in questione fa riferimento a una circolare del 2009, emanata dall’allora ministro Maroni, che invitava prefetti e sindaci, tramite il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a individuare aree sensibili nel territorio urbano, così da poterne interdire l’accesso in caso di manifestazioni: ogni volta che, per un corteo studentesco o una mobilitazione di protesta, si è sentito parlare di “zona rossa” ci si riferiva proprio a questi invalicabili obiettivi sensibili individuati dall’autorità di pubblica sicurezza. Anche in questo caso le indicazioni ministeriali, date con riferimento alle “manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto”, ma che, “per la loro valenza generale, potranno trovare applicazione per manifestazioni pubbliche attinenti a ogni altra tematica”, non introducono nuove norme, ma si limitano a ribadire gli strumenti di gestione dell’ordine pubblico che prefetti e sindaci già hanno a loro disposizione per il contemperamento tra libertà di manifestazione e altri diritti e posizioni giuridiche tutelate dall’ordinamento.
La tensione tra cittadini e autorità: la libertà di manifestare e l'ordine pubblico
La libertà di manifestare è un diritto avente rango costituzionale, definito e assicurato da quattro diverse norme sotto differenti declinazioni: l’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.), il diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Ma se si è liberi di circolare e di riunirsi, come può una circolare ministeriale impedire di manifestare nel centro di Milano o di bloccare il porto di Trieste? Uno degli equivoci a cui si presta l’appello ai diritti costituzionali privo di un’adeguata lettura della Carta è l’idea che le libertà in essa sancite siano assolute, prive di qualsivoglia limite. La Costituzione, invece, nelle sue definizioni, specifica i confini dei diritti, per permettere il loro godimento in equilibrio con l’esercizio di altri diritti e di altre libertà (o dei medesimi diritti esercitati da altre persone): la sovranità appartiene al popolo, che però la esercita “nelle forme e nei limiti della Costituzione”; lo sciopero è un diritto, ma è regolato dalla legge, quindi, ad esempio per i servizi pubblici essenziali, sono previste forme di tutela per le libertà degli utenti, dalle fasce di garanzia nel trasporto all’obbligo di proclamazione con particolari procedure; esiste la libertà d’impresa, ma l’iniziativa economica privata non può svolgersi “in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Allo stesso modo, si prevede certamente la libertà di circolazione, ma la stessa norma specifica che il diritto si esprime sull’intero territorio nazionale “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. E il diritto di riunirsi è libero, ma solo qualora le persone si riuniscano “pacificamente e senz'armi” e fermo restando il dovere, se la riunione si svolge in luogo pubblico, di dare preavviso alle autorità, “che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Per comprendere appieno i limiti all’esercizio dei diritti, è necessario anche constatare che nel nostro ordinamento convivono diverse fonti. La fonte primaria è la Costituzione, citata fin qui, ma tra le leggi in vigore sopravvivono ancora norme emanate in epoca fascista: il nostro codice civile è del 1942, il codice penale è del 1930, il T.U.L.P.S. è del 1931. Il T.U.L.P.S. è il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed è tuttora la fonte a cui fanno riferimento i funzionari che gestiscono le piazze durante le mobilitazioni. Ovviamente tutte queste fonti devono essere ora lette secondo quella che si definisce una “interpretazione costituzionalmente orientata”, il che significa che, oltre ad abrogare le norme fasciste anche nel contenuto come ha più volte fatto la Consulta, l’applicazione della disciplina deve (o dovrebbe) basarsi sui principi del nuovo regime democratico. La concezione dell’ordine pubblico è quindi particolarmente problematica, dal momento che si tratta del terreno di confronto tra le libertà dell’individuo e quelle della collettività, nel rapporto spesso in tensione con l’autorità. Nel tentativo di risolvere la questione definitoria, la dottrina giuridica distingue tra l’ordine pubblico materiale e l’ordine pubblico immateriale. Il primo comprende la tutela della sicurezza, della salute e della tranquillità pubbliche, dunque la prevenzione dei pericoli di violenza, la tutela sanitaria e la percezione da parte dei cittadini dell’impegno fattivo ed efficace dell’autorità in tal senso. L’ordine pubblico immateriale è invece un concetto più ampio, che comprende altri fattori di tensione tra persone e autorità, allargando il potere repressivo statale anche oltre sicurezza, salute e tranquillità, occupandosi ad esempio di questioni morali ed estetiche, giungendo persino alla cosiddetta ragion di Stato, ai limiti quindi di un approccio totalitario.
Come ogni ordinamento, anche il nostro oscilla tra queste due opposte concezioni di ordine pubblico, a seconda del periodo storico, dei rapporti di forza, delle compagini governative. L’ultimo decennio pare essersi caratterizzato per una tendenza criminalizzante e per l’allargamento degli strumenti repressivi di ordine pubblico, verso una sua concezione ampia e immateriale.
L'allargamento della nozione di ordine pubblico: la sicurezza secondo Maroni, Minniti e Salvini
Un primo esempio risale all’ultimo governo Berlusconi, con il ministro Maroni al Viminale. Il foglio di via (cui è stato destinatario Puzzer, dei portuali triestini) e la sorveglianza speciale (cui era sottoposto, ben prima delle proteste no green pass, Giuliano Castellino di Forza Nuova, arrestato per l’assalto alla Cgil) sono ad esempio istituti previsti dal decreto legislativo 159 del 2011 (il cosiddetto codice antimafia che, come si può notare, non si occupa solo di criminalità organizzata), che ha operato un riordino in materia di misure di prevenzione. Questi istituti rientrano infatti tra le misure di prevenzione personali, cioè ordini dell’autorità contro soggetti ritenuti pericolosi. Alcune di queste misure possono essere disposte direttamente dal questore (cioè da un’autorità amministrativa), come nel caso dell’avviso orale, con cui si invitano i destinatari a tenere una condotta conforme alla legge, o del foglio di via obbligatorio, emesso qualora il soggetto destinatario si trovi fuori dal proprio luogo di residenza e con il quale il questore lo allontana dal Comune e gli vieta di tornare senza preventiva autorizzazione per un massimo di tre anni. Altre misure richiedono invece l’intervento dell’autorità giudiziaria, come l’obbligo o il divieto di dimora in un particolare comune e la sorveglianza speciale, cioè l’imposizione di particolari obblighi e divieti (come il divieto di partecipare a manifestazioni o di frequentare determinati luoghi, l’obbligo di rincasare entro una certa ora, eccetera). La Corte Costituzionale ha peraltro dichiarato incostituzionali parti di quel provvedimento eccessivamente generiche: con la sentenza 24/2019 ha dichiarato illegittima la possibilità di applicare misure di prevenzione come la sorveglianza speciale e la confisca anche in caso di semplici indiziati di “traffici delittuosi”, mentre la sentenza 25/2019 ha censurato la possibilità di imporre misure simili in caso di violazione degli obblighi, troppo vaghi, di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”.
Il ministro Maroni appose inoltre la sua firma ai cosiddetti pacchetti sicurezza, anch’essi in parte censurati dalla Consulta. Tralasciando le misure in materia di immigrazione (tema ormai stabilmente inserito nella concezione di ordine pubblico, anche se non necessariamente d’impatto su salute e sicurezza) come la previsione del reato di immigrazione clandestina e di una (incostituzionale) aggravante di clandestinità, il pacchetto sicurezza 2008 investiva i sindaci, in materia di incolumità pubblica, di un ampio potere di ordinanza, anch’esso bocciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 115/2011.
Un simile impianto si ritrova, con il governo Gentiloni, nei decreti Minniti, ossia i decreti legge 13 e 14 del 2017. Il secondo, in particolare, ha previsto nuovamente, all’articolo 8, il potere di ordinanza dei sindaci (sebbene solo “in relazione all’urgente necessità di interventi”, quindi correggendo di fatto le censure che la Consulta fece al progetto maroniano dei sindaci sceriffi) e ha introdotto, con l’articolo 9, il cosiddetto Daspo urbano (nozione giornalistica, mutuata dall’analoga misura di divieto di ingresso in stadi e palazzetti sportivi). La rubrica di questa norma, in particolare, è “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi” ed è proprio questa una caratteristica della concezione di Minniti di ordine pubblico, che si allarga a caratteristiche estetiche, quali decoro e degrado. La definizione di sicurezza pubblica è infatti, testualmente, “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”. Per quanto concerne la gestione della sicurezza pubblica, il decreto Minniti prevede la possibilità di allontanamento in caso di condotte che impediscano l’accessibilità o la fruizione “delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze”. Con il governo giallo-verde e Salvini al Viminale, questa possibilità è stata allargata anche, tramite regolamento di polizia urbana, alle “aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico”. Tradotto dal giuridichese: se nei parchi o nelle stazioni che frequentavate avete visto meno senzatetto di quelli che notavate nel 2016, può essere che abbiano nel frattempo ricevuto dei daspo urbani.
I successivi decreti Salvini si pongono sullo stesso solco, approfondendo la nozione di ordine pubblico e allargando, come si è visto, gli istituti introdotti da Minniti. A questi interventi si è aggiunta l’azione politica di aumento delle fattispecie penali e criminali: con il decreto legge 113 del 2018 è stato introdotto il reato di accattonaggio molesto (l’art. 699-bis c.p.), si è allargata la nozione di blocco stradale (che ora prevede da uno a sei anni di carcere per chi ostacoli in qualunque modo qualunque strada, mentre in precedenza il reato era riferito all’ostruzione con oggetti di strade ferrate) e si è inasprita la pena per l’invasione di terreni (con impatto, ad esempio, sulle occupazioni studentesche), mentre l’anno dopo, con il decreto legge 138 del 2019, si è proceduto a una generale riforma del codice penale in materia di pubbliche manifestazione. In particolare, il decreto prevede una circostanza aggravante per diversi reati, ossia interruzione di un ufficio o servizio pubblico o servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p., con il massimo della pena raddoppiato), devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.), danneggiamento (635 c.p.), oltre a un’aggravante generale aggiunta all’art. 339 c.p., che si riferisce ai reati di violenza e minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale: la pena viene aumentata semplicemente per il fatto che il reato viene commesso durante una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La direttiva del Viminale e lo stato di emergenza
Se le misure dell’ultimo decennio oscillano verso la tendenza securitaria e repressiva di ordine pubblico in senso immateriale, la direttiva del Viminale degli ultimi giorni pare invece arrivare dopo una stagione di gestione della piazza piuttosto permissiva e fa riferimento a principi limite contenuti nella stessa Costituzione, relativi a una concezione di ordine pubblico in senso materiale, cioè appunto riferita a sicurezza, salute e tranquillità. Una delle prassi che si è verificata in molti casi durante le manifestazioni di protesta degli ultimi mesi è stata infatti quella dei mancati preavvisi all’autorità sulle riunioni in luogo pubblico o di violazione delle prescrizioni previste nella fase di organizzazione delle mobilitazioni, attraverso deviazioni dai percorsi annunciati, oltre che spesso in violazione delle misure anticontagio comunque in vigore (l’obbligo di mascherina anche all’aperto qualora non sia possibile garantire il distanziamento è tuttora vigente, oltre che esercizio di buon senso).
Abituati negli anni a un abuso del concetto di emergenza e assuefatti alla comunicazione sulla sicurezza, sembra quasi non si riesca più a riconoscere quando, invece che una scusa, l’emergenza sia la ragione giustificatrice dei provvedimenti e quando i limiti a un diritto non sono imposizioni arbitrarie ma confini ontologici del diritto stesso. Un esempio evidente, sebbene non particolarmente approfondito, forse anche per l’avvicendamento governativo e il desiderio di superare la stagione delle restrizioni generali, è la dichiarazione di infondatezza, da parte della Consulta con la sentenza 198 del 2021, della questione di costituzionalità sollevata sull’uso dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (i DPCM) nel periodo del lockdown. Ma è forse il caso di partire dal principio, cioè dal gennaio 2020.
Il 30 gennaio 2020, dopo circa un mese dalla dichiarazione di un cluster di epidemia di polmonite da un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) a Wuhan e diversi casi in altre nazioni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara emergenza globale (“emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”). La dichiarazione dell'OMS permette all'organizzazione stessa di fare raccomandazioni e certifica un problema sanitario che non è circoscritto entro i confini di un unico paese. L’indomani, il 31 gennaio 2020, il governo italiano dichiara emergenza nazionale per sei mesi, a seguito della dichiarazione dell’OMS e del ricovero di due pazienti all'ospedale Spallanzani di Roma. Lo stato di emergenza è previsto dal decreto legislativo 1 del 2018, più noto come “Codice della Protezione Civile”, che ha operato un riordino della disciplina in materia (per capirci, lo stato di emergenza esisteva ben prima del 2018, ma era disciplinato dalla legge 225 del 1992). Come suggerisce il nome della legge che lo prevede, lo stato di emergenza riguarda solo i poteri della protezione civile nella gestione di emergenze locali o nazionali derivanti da eventi calamitosi. Quindi, ad esempio, durante l’emergenza al capo del dipartimento di protezione civile è conferito un potere di ordinanza, anche in deroga alla legge purché nel rispetto dei principi dell’ordinamento, nei limiti degli stanziamenti previsti contestualmente alla dichiarazione dell’emergenza. Ma non solo. Siccome la protezione civile non è composta soltanto del migliaio di impiegati assunti, ma si regge sul supporto dei volontari, la dichiarazione dello stato di emergenza permette l’aumento dei permessi retribuiti di cui possono godere i volontari. Questi permessi, la cui retribuzione è anticipata dal datore di lavoro ma poi rimborsata dal dipartimento di protezione civile, hanno un limite annuo di 90 giorni per attività di soccorso e assistenza (di cui massimo 30 continuativi) e di 30 giorni (di cui massimo 10 continuativi) per attività di pianificazione, simulazione e formazione. Se però è dichiarata emergenza nazionale, questi termini sono raddoppiati.
Va da sé che, essendo la dichiarazione di stato di emergenza deliberata sulla base della normativa dedicata alla protezione civile, non riguarda né il Parlamento né il Governo, non aumentava i poteri di Giuseppe Conte, né aumenta quelli di Mario Draghi. L’iter di formazione e approvazione delle leggi resta invariato, anche perché (e qui torniamo al discorso sul diverso rango delle regole) una deliberazione dell’esecutivo, com’è la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, non potrebbe modificare una procedura come quella legislativa, il cui funzionamento è disciplinato dalla Costituzione stessa. Lo stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020, e poi prorogato nei mesi successivi, è limitato alla gestione dell’emergenza stessa e non è minimamente paragonabile a meccanismi emergenziali come la dichiarazione dello stato di guerra (che, secondo l’articolo 78 della Costituzione, deve essere deliberato dalle Camere che conferiscono i poteri al Governo, che certo non può conferirsi tali poteri da solo), né rappresenta un colpo di stato o l’inizio di una dittatura sanitaria.
La Costituzione prevede comunque delle modalità di gestione del potere legislativo più snelle, anche in tempo di pace, di fronte a emergenze. L’articolo 77 della Costituzione prevede infatti che, sebbene la formazione delle leggi sia competenza del Parlamento, il Governo possa adottare atti aventi forza di legge “in casi straordinari di necessità e d'urgenza”, che comunque devono essere convertiti dalle Camere entro sessanta giorni. Si tratta dei decreti legge. Governi d’ogni colore hanno usato i decreti legge per varie materie, allargando la nozione di necessità e urgenza a piacere: dalla riforma Gelmini sulla scuola al decreto Dignità sui contratti a termine (e al precedente decreto Poletti sulla stessa materia), passando per i vari decreti Sicurezza, l’uso della decretazione governativa ha riguardato anche temi che si sarebbero potuti affrontare in sede parlamentare.
Quando, il 23 febbraio 2020, il governo Conte varò uno dei primi decreti legge relativi all’emergenza coronavirus, i requisiti di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione erano invece drammaticamente attuali. I decreti legge di quel periodo, poi convertiti dal Parlamento senza particolari obiezioni, discussioni o emendamenti, prevedevano l’utilizzo di dpcm, cioè atti amministrativi emessi dal Presidente del Consiglio. Questo accentramento del potere di imporre restrizioni ha attirato critiche, spingendo in particolare un giudice di pace onorario del tribunale di Frosinone a sollevare una questione di costituzionalità, attraverso cui supponeva che, con l’uso dei dpcm, il Presidente del Consiglio avesse ottenuto una incostituzionale delega legislativa in bianco. La Corte Costituzionale ha respinto tale ipotesi: i dpcm non erano infatti misure arbitrarie del capo del governo, ma si limitavano a graduare le restrizioni già definite, nel loro massimo, da un atto avente forza di legge, come il decreto governativo, poi comunque convertito in legge in sede parlamentare. Gli atti amministrativi del Presidente del Consiglio erano insomma (come sono sempre stati nell’ordinamento) un’applicazione in concreto di misure individuate in astratto dalla legge.
La stessa infondata agitazione si sta verificando ora nella gestione dell’ordine pubblico. Esiste una libertà costituzionale di manifestare, libertà che non è assoluta, né potrebbe esserlo, a prescindere dalla pandemia. Questa libertà si confronta con norme e prassi nella gestione della pubblica sicurezza, che prevedono tra l’altro il dovere dei cittadini di preavvisare le proprie riunioni in luogo pubblico e di attenersi a eventuali restrizioni, motivate e giustificate da ragioni di sicurezza o sanitarie, dell’autorità. La cosiddetta “stretta del Viminale” di cui si discute in questi giorni non è altro che il promemoria ministeriale a prefetti e funzionari di pubblica sicurezza sui propri poteri e sui propri doveri. Se vogliamo avanzare critiche alla gestione dell’ordine pubblico, dovremmo guardare piuttosto ai provvedimenti dell’ultimo decennio e all’approccio repressivo che è stato tollerato quando colpiva gli ultimi in nome di emergenze presunte e di un concetto di sicurezza talmente ampio da comprendere perfino le aiuole (col dovuto rispetto per le aiuole). O, per restare sulla situazione odierna, sarà necessario verificare che prefetti, sindaci e comitati per la sicurezza applichino con proporzionalità gli strumenti per la gestione dell’ordine pubblico suggeriti dal ministero: la valenza generale di un principio non implica infatti la sua applicazione uguale a situazioni differenti. Quindi, se è vero che si potranno individuare (come già si potevano individuare prima) aree sensibili del tessuto urbano, la loro interdizione in caso di manifestazioni pubbliche non dovrà necessariamente imporsi a ogni tipo di mobilitazione; o, ancora, la preferenza per presidi statici rispetto al loro svolgimento dinamico (sit-in al posto di cortei) non potrà essere una regola applicata automaticamente a ogni mobilitazione, ma un’eventualità di volta in volta valutata di fronte alle diverse riunioni pubbliche che saranno preavvisate alle autorità di pubblica sicurezza, anche per evitare situazioni, ben più pericolose, di assembramenti che potrebbero invece essere limitati lasciando fluire un corteo di persone. Il problema è casomai, insomma, l’arbitraria applicazione delle regole che spesso si è registrata nella gestione dell’ordine pubblico: sono decine gli esempi di cariche, manganellate, lacrimogeni e scioglimenti di riunioni ben più pacifiche delle manifestazioni no-mask, no-vax e no-green pass degli ultimi mesi. Sarebbe una beffa se, dopo un approccio ampiamente permissivo delle autorità nella gestione delle piazze convocate contro le misure sanitarie in atto, prefetti e sindaci limitassero del tutto, senza valutazioni in concreto, le manifestazioni in città.
Al di là di questa eventualità, su cui comunque sarà necessario vigilare, bisogna comunque ricordare che libertà e diritti sono equilibri delicati, in cui la posizione del singolo deve essere tutelata dalla collettività e in cui la collettività non deve essere danneggiata dalla posizione del singolo. La difesa della libertà di manifestare, per quanto paradossale possa sembrare, passa anche dalla definizione dei suoi limiti, saggiamente posti già nel testo costituzionale.