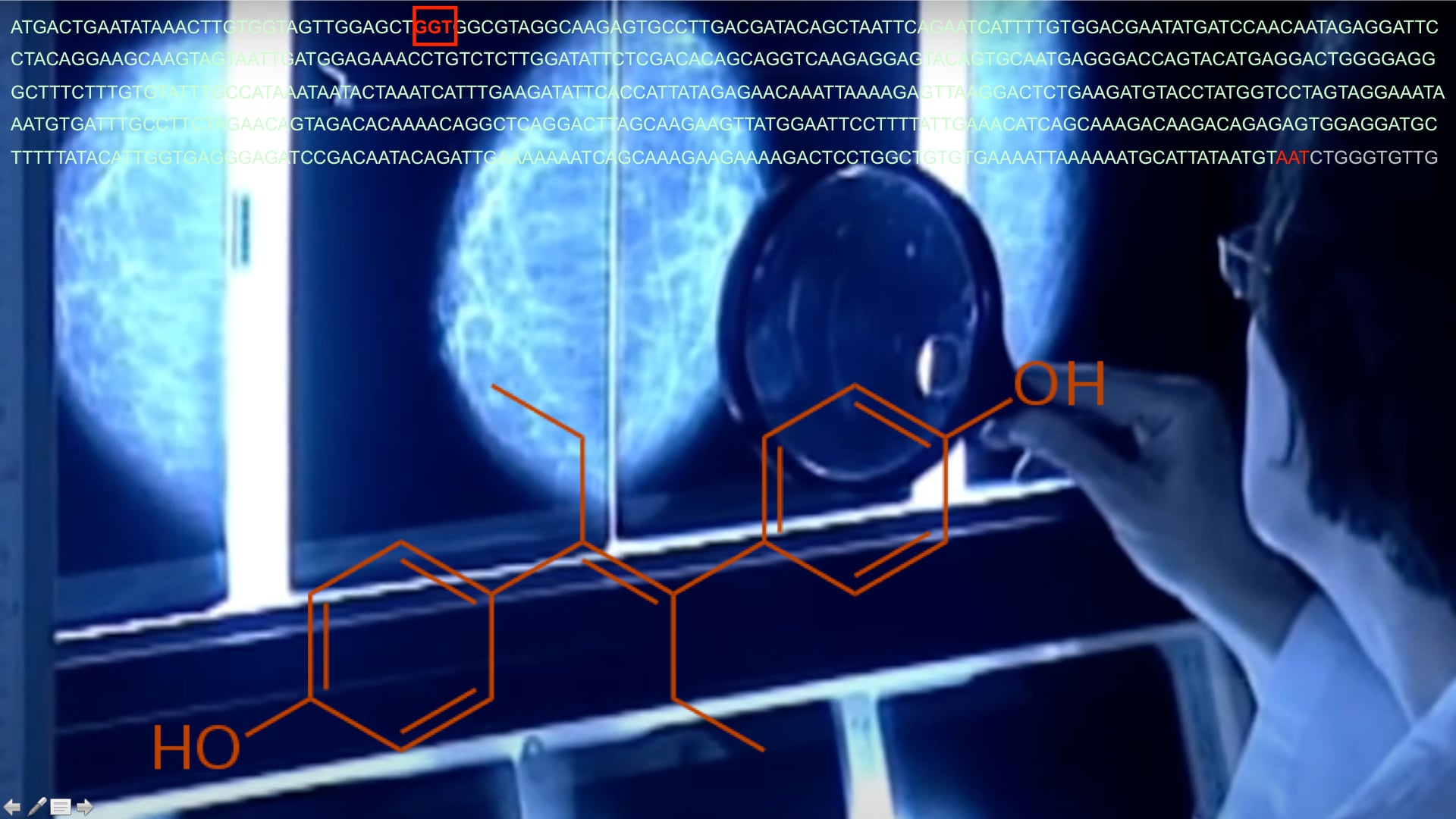I reati dei figli, le responsabilità degli adulti
5 min letturaSi dice che la mela non cada mai troppo lontano dall'albero ma forse è solo un altro stereotipo di cui dovremmo liberarci, una spiegazione troppo facile per fatti e comportamenti dai quali non ci è consentito distrarre lo sguardo e negare la nostra presenza.
La cronaca ci racconta due episodi avvenuti in due province molto distanti fra loro, Viterbo e Manduria. Alto Lazio e profonda Puglia, un'accusa di stupro e una serie di aggressioni a carico di un anziano con disabilità, crimini in apparenza distanti tra loro per geografia e tipologia di reato.
Eppure un filo conduttore esiste non solo nella particolare gravità dei reati commessi e nella giovane età dei protagonisti, ma soprattutto nella indulgente complicità che alcuni adulti hanno mostrato di fronte ai fatti.
Spaventa la fragilità di alcuni genitori che, sgomenti, non riescono a riconoscere nei loro figli gli individui capaci di agire così al di là dei loro precetti. Fa inorridire la lucida reazione di altri alle prove di sfrontatezza e violenza che gli eredi gli forniscono al fine di compiacerli. Raggela indubbiamente l’assenza di empatia per le vittime ma, soprattutto, il tentativo immediato di derubricare i reati e di sottrarre gli autori degli stessi al corso della giustizia.
Non è la prima volta che assistiamo a questo spettacolo. Sempre più spesso leggiamo di genitori vendicatori che aggrediscono le autorità costituite (di solito quelle scolastiche) ree di tarpare le ali o di comminare pene troppo severe ai giovani rampolli. O scopriamo, appunto, padri che cercano di suggerire ai figli il modo di distruggere le prove dei loro reati e madri che realizzano improvvisamente che quell’individuo che abita in casa loro, forse, non è solo l’adolescente svogliato che mette in disordine, non ubbidisce, passa troppo tempo tra smartphone e videogame, va benino a scuola, ha tanti amici e suona la chitarra.
L’epifania peggiore per un genitore è proprio questa: trovarsi di fronte alla plastica realizzazione che i figli non solo non sono esattamente come ci eravamo immaginati ma nemmeno ci appartengono.
Perché la verità, colpevolmente sottaciuta sin dal corso pre-parto, è che noi letteralmente li mettiamo al mondo ma da quel momento in poi è solo un accidentato percorso verso il distacco.
Sono persone, individui, con una loro indole, crescono nel nostro solco educativo ma non siamo gli unici ad influenzarne la sfera di valori, i sentimenti, le aspettative. Non sappiamo cosa ne sarà di loro, se saranno sani, civili, retti. Non possiamo davvero prevedere che strada prenderanno e annaspiamo quotidianamente nel cercare di capire quale insegnamento potrebbe essere più utile per il loro futuro.
Cerchiamo di proteggerli e controllarli mettendogli in mano, sempre più presto, strumenti meravigliosi e terribili, senza renderci conto che il rovescio della medaglia è un illimitato potere di scelta e un costante desiderio di abbattere i confini entro i quali, secondo i nostri parametri forse un po’ antiquati, dovrebbero muoversi.
Vediamo quello che vogliamo vedere, siamo portati a ignorare i segnali che a volte arrivano dalla scuola, dalla rete sociale, dalle ragazze e dai ragazzi stessi. Siamo impreparati, incoerenti, ci sentiamo soli e disperati di fronte all’ipotesi di un problema e delle sue reali dimensioni anche perché, intimamente, sappiamo che l’ambiente che abbiamo contribuito a creare intorno a loro non è certo un giardino incantato.
Questi ragazzi infatti, “normali” (con tutto il peso e l’insensatezza contemporanea del termine) fino a prova contraria, sono figli di tutti, della società che quotidianamente gli costruiamo (o decostruiamo, dipende dal punto di vista) sotto gli occhi, delle sue verità e contraddizioni, dello spessore o dell’inconsistenza delle relazioni che siamo capaci di creare e alimentare dentro e fuori casa, delle nostre inadeguatezze e dei nostri tentennamenti, dei conflitti aspri che inneschiamo con i nostri pari su valori e tematiche che dovrebbero essere patrimonio condiviso, del trattamento che noi stessi riserviamo agli altri in generale e a determinate categorie sociali in particolare.
E allora a un certo punto eccoci costretti a sviluppare una tragica consapevolezza, sgomberando il campo dalle ipocrisie e facendo i conti con la realtà: anche nelle migliori famiglie può crescere un figlio che delinque (e per fortuna anche il contrario, come accaduto a Napoli dopo l’ultimo sanguinoso agguato nato in contesto camorristico).
La mela può cadere lontanissima dall’albero.
Ed è qui che, fuor di stereotipo, fare il genitore diventa il mestiere più difficile del mondo. Sulla carta nessuno di noi può sapere come reagirebbe di fronte ad un fatto simile ma è in questo punto e momento preciso che si scoprono i nervi, si capisce se le connessioni sono sane, si comprende se i valori e l’amore che professiamo sono abbastanza solidi da sostenere il peso della responsabilità.
Perché è davvero doloroso vedere un educatore minimizzare o negare i fatti pur di non riconoscere la realtà di un figlio che sbaglia. Perché non possiamo volerli adulti e indipendenti quando ci fa comodo ma pretendere di parlare per loro conto e di sminuire le loro azioni e le loro scelte, anche quelle peggiori, quando queste si allontanano dalla nostra visione delle cose.
Questo modo di agire significa percepirsi non come organismo essenziale in un ecosistema che si mantiene in buona salute anche grazie alle nostre scelte, ma come grumo solitario, in guerra con tutti gli altri, teso soltanto a difendere la propria esistenza e quella dei suoi più stretti congiunti. Significa non aver compreso che il senso più alto dell’amore, anche di quello genitoriale, è dire la verità e offrire il proprio inesauribile sostegno per affrontarla.
Certo, anche i genitori, gli adulti, hanno il diritto di non essere abbastanza forti per sopportare un simile peso ed è per questo che dovremmo lavorare sempre parallelamente per costruire e mantenere comunità capaci di intercettare i problemi, reagire compatte, fermare le derive, espellere i veleni senza per questo trasformarsi in carnefici.
Punire, ottenere giustizia, non dovrebbe mai fare rima con vendetta così come il bene più profondo non dovrebbe mai significare la negazione del nostro essere sociale, del nostro dovere di cittadini verso la collettività, pena la distruzione della sua stessa struttura e anche del modello educativo sano di cui tanto ci riempiamo la bocca.
Dovremmo interrogarci di più e meglio sulla nostra crescente e documentata ritrosia a prendere decisioni nette, ad accettare e gestire un conflitto sano, a far pesare il nostro ruolo di educatori e membri adulti della comunità senza per questo schiacciare i desideri e le individualità di chi sta crescendo.
Dovremmo ricominciare ad accettare all’interno dei nostri nuclei lo sguardo degli altri che spesso può svelarci cose che noi non riusciamo o non vogliamo vedere.
Dovremmo ricordare che evitare l’emulazione e la normalizzazione di alcuni comportamenti è un lavoro che richiede la collaborazione di tutti, la famiglia da sola non basta, perciò l’educazione non potrà mai essere soltanto una questione privata ma è e deve rimanere un fattore essenziale di confronto e coesione sociale.
Immagine in anteprima via Corriere della Sera