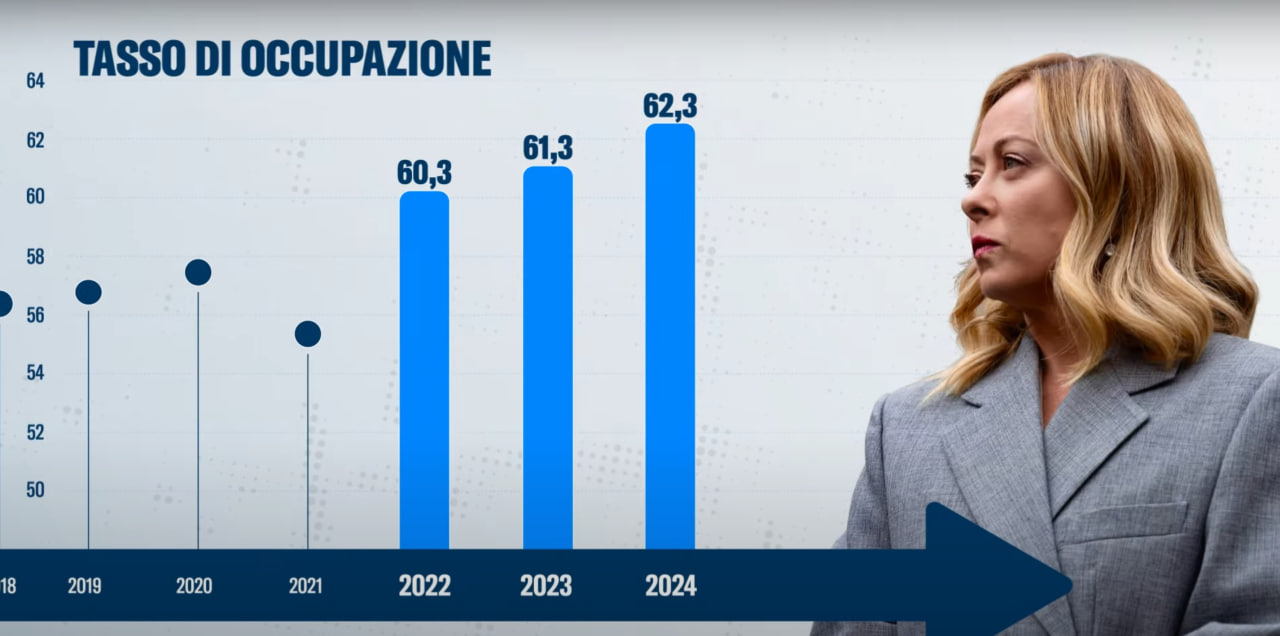Lauree “inutili”, dopo un anno Stefano Feltri continua a sbagliare
8 min letturaL'anno scorso Stefano Feltri, vicedirettore del Fatto Quotidiano, commentando i dati di una ricerca sul ritorno economico degli studi universitari pubblicata dal centro studi di Bruxelles CEPS, aveva esposto la propria personale visione sul rapporto tra Università e mondo del lavoro e sulla utilità, o meno, di intraprendere alcuni percorsi di studio.
Il vicedirettore metteva in guardia i futuri universitari dal rischio di studiare "ciò che piace", invece che ciò che è utile a trovare un lavoro (solo i ricchi possono permettersi di dedicarsi a ciò per cui si sentono portati, scriveva). Denunciava che «in Italia studiamo le cose sbagliate» e che il sistema universitario italiano «fa un po' schifo». Instillava, perciò, sensi di colpa in chi decide di iscriversi ad alcune lauree. E, saltando dalle scelte personali a quelle collettive, invitava la comunità a riflettere sull'opportunità di «sussidiare pesantemente» lauree che «producono disoccupati».
Valigia Blu aveva risposto a Feltri e aveva dimostrato che le sue considerazioni sull'Università, sulle scelte che motivano i percorsi di studio e sul carattere di chi si iscrive ad alcune lauree erano espressione di una visione superficiale. Ma non solo, aveva anche dimostrato che la sua lettura dello studio del centro CEPS era arbitraria e affrettata (come aveva rilevato anche una delle autrici della ricerca). E che era sbagliata anche la sua interpretazione di altri dati sul rapporto tra lauree e sbocchi occupazionali (questi i nostri post sul tema: Ma davvero le facoltà umanistiche sono un pessimo investimento? - ‘Non studiate quello che vi piace’: l’ideona dell’estate 2015 contro la disoccupazione - Università e lavoro: Stefano Feltri insiste e sbaglia ancora).
A più di un anno di distanza dal dibattito che i suoi articoli avevano innescato, il vice direttore del Fatto quotidiano torna ora sull'argomento. E lo fa in un articolo dal titolo Università, ora è ufficiale: alcune lauree sono inutili. Chi avrebbe stabilito, addirittura ufficialmente, che alcune lauree sono inutili? Nientemeno che l'Istat, nel rapporto I percorsi di studio e lavoro dei diplomati e dei laureati. Feltri cita questi due passaggi del rapporto:
L’inserimento nel mercato del lavoro è più difficile per i laureati, sia di I che di II livello, nei gruppi Letterario e Geo-biologico. Lavora infatti il 61,7% dei laureati di I livello e il 73,4% di quelli di II livello del gruppo Letterario, il 58,6% dei laureati di I livello e il 76,5% di quelli di II livello del gruppo Geo-biologico. Critica è anche la situazione dei laureati di I livello nel gruppo Psicologico (lavora il 54,4%) e dei laureati di II livello nel gruppo Giuridico (lavora il 67,6%).
E:
Il 64,2% dei laureati di I livello e il 74,9% dei laureati di II livello dichiarano che la laurea era espressamente richiesta per accedere all’attività lavorativa mentre è stata utile rispettivamente nel 23,8% e 17,8% dei casi. La laurea sembra non premiare chi l’ha conseguita nei gruppi Letterario e Politico-sociale, dal momento che per l’attività lavorativa svolta non era richiesta e non è stata nemmeno utile.
Esistono lauree utili e inutili, dunque? Utili o inutili, come scrive Feltri, «a trovare lavoro, ad avere uno stipendio che permetta di mantenersi e di avere una famiglia»? Sì, dovremmo dargli ragione. I dati Istat individuano reali differenze tra le lauree nei diversi ambiti disciplinari, sia per quanto riguarda la percentuale di occupazione che per la rilevanza del titolo di studio per l'accesso all'attività lavorativa.
Feltri parla di questa realtà come di una "ovvietà". E nessuno nega che mediamente, nel mondo in cui viviamo, per un laureato in Lettere ci siano meno opportunità lavorative che per un laureato in Ingegneria. Ma se dovessimo accontentarci delle ovvietà, sarebbero superflue sia le considerazioni di Feltri che i rapporti dell'Istat. Al solito, è la lettura di questa "ovvietà", come vedremo, a essere estremistica, perché non si limita a constatare una situazione di fatto, ma si spinge di nuovo oltre.
Quali sono, in concreto, le lauree "inutili"? Le solite Lettere e Filosofia? Feltri scrive che l'anno scorso si è scatenato l’assalto («molto italiano») di quelli che sostenevano che gli studi letterari o filosofici «aprono qualunque carriera». Nessuno ha mai scritto una tale sciocchezza, così come del resto nessuno sostiene che Medicina e Ingegneria (o Economia, la disciplina in cui si è laureato Feltri) possano permettere di intraprendere «qualunque carriera». Nessun percorso di studi lo consente.
Feltri continua a usare l'argomentazione polemica e retorica degli studi umanistici, facile bersaglio dei detrattori delle lauree "inutili", continuando a ignorare alcuni dati che riguardano lauree in altri ambiti disciplinari. Come riporta infatti la stessa citazione dell'Istat, tra le lauree che faticano più di altre a trovare sbocchi lavorativi figurano anche quelle del gruppo geo-biologico (come Scienze geologiche, Scienze biologiche e Scienze naturali).
È un dato non nuovo, purtroppo, che lo stesso Feltri riportava già l'anno scorso, e che gli avevamo già fatto notare dal momento che sembrava non trarne le dovute conseguenze per la sua polemica anti "umanistico-sociale". E, a quanto pare, continua a ignorarlo. Perché la lista delle lauree da sconsigliare, a fronte dei dati sull'occupazione, non si limiterebbe a Lettere, Filosofia e Scienze Politiche. Feltri dovrebbe accettare il fatto che a criticarlo non è soltanto chi sostiene l'importanza dei corsi di laurea umanistici, ma anche di quella di molti corsi scientifici. Tra l'altro, l'anno scorso il vicedirettore del Fatto faceva una certa confusione tra ambiti disciplinari umanistici, sociali e giuridici, tutti appiattiti nella categoria dell'inutilità (si rivolgeva polemicamente, tra l'altro, agli scrittori).
I diversi ambiti differiscono anche nella percentuale di laureati che dichiarano che il loro titolo è stato espressamente richiesto o utile per un particolare impiego. Su questo non c'è dubbio, ma anche in questo caso i dati dell'Istat confermano una situazione niente affatto nuova, di cui già avevamo discusso l'anno scorso. C'è peraltro una certa differenza nel misurare il grado di utilità di una laurea sulla base della esplicità richiesta di quel titolo da parte del datore del lavoro oppure del giudizio personale sulla sua rilevanza nello svolgimento quotidiano di una mansione.
È evidente infatti che ci siano professioni che più di altre, nella pratica quotidiana, necessitano di alcune competenze teniche acquisite durante gli studi (Medicina, Ingegneria), che trovano una applicazione più immediata. Mentre altri percorsi offrono una formazione che, al di là dei contenuti, può risultare utile in diversi settori, anche molto distanti. Come afferma Andrea Cammelli, fondatore del Consorzio AlmaLaurea (che citavamo l'anno scorso), «oggigiorno un laureato in filosofia può tranquillamente ricoprire un ruolo efficace ed efficiente nell'area del personale di un'azienda».
Una cosa, perciò, è dire banalmente che se si vuole fare i medici serve una laurea in Medicina. Altro, e più scorretto, è concludere, con Feltri, che «ci sono lauree che non interessano a chi deve pagarti lo stipendio».
Non è una novità nemmeno registrare il fatto che esistano posizioni lavorative più remunerative di altre e con prospettive di carriera migliori e più stabili. E che, come rileva l'Istat, determinano un grado di soddisfazione maggiore, rispetto ad altre. Un giovane medico ha di fronte a sé una prospettiva di carriera sicuramente più stimolante dal punto di vista economico, di un coetaneo che insegna lettere in un liceo. Del resto l'Istat afferma che «i lavoratori co.co.co o prestatori sono i meno soddisfatti per tutti gli aspetti considerati». Non c'è bisogno di stilare una lista di lauree utili o inutili, per segnalare il fatto che un precario non può che essere insoddisfatto, che sia laureato in Lettere o in Fisica.

Se molti laureati, come scrive Feltri, risultano scontenti e insoddisfatti, dovremmo forse chiederci anche il perché e non solo registrarlo. In questo contesto, infatti, limitarsi a constatare un dato significa ridurre il discorso pubblico sull'Università, e quindi sul futuro del paese, alle mutevoli dinamiche del mercato del lavoro. Ignorando la sua struttura e i suoi limiti, come se esso si trovasse in uno stato perennemente ottimale (e non, come è ancora, in una condizione di crisi). Come se le esigenze delle aziende coincidessero, perfettamente e in ogni istante, con quelle di un paese e di una società. Come se non esistesse un settore pubblico, che dovrebbe costituire lo sbocco di molti percorsi di studio.
In un paese come l'Italia, dove gli investimenti pubblici nella ricerca scientifica sono vergognosamente miserevoli rispetto ad altri paesi, ci sono anche molti laureati in fisica e biologia a essere scoraggiati e preoccupati per la propria situazione professionale. Dovremmo perciò consigliare ai ragazzi di lasciar perdere anche questi studi?
È evidente che le tesi di Feltri discendono da una sua personale concezione della società, dell'economia, del lavoro e, quindi, anche del ruolo dello Stato in questi ambiti (dovremmo smettere di "sussidiare" certe facoltà, scriveva l'anno scorso, ignorando la realtà della bassa spesa pubblica in Università e ricerca in Italia). Ma questa visione il giornalista la sistema all'interno di una presunta oggettività, ne fa una questione di evidenze, da cui far discendere alla fine una "morale". Ai diciottenni, scrive, bisogna porre di fronte «l’evidenza dei numeri e non qualche convinzione priva di basi fattuali».
Ma l'Istat non consiglia agli studenti di iscriversi a lauree nell'ambito "Difesa e sicurezza" solo perché gli occupati in questo ambito risultano i più soddisfatti. L'istituto scatta una fotografia dalla realtà sociale ed economica del paese, che non va giustificata come fa Feltri, che commette l'errore di passare dall' "è" al "dovrebbe essere". È quindi fallace, in questo caso, contrapporre evidenze a convinzioni, perché non stiamo osservando un fenomeno fisico o biologico, ma stiamo prendendo atto di una condizione sociale ed economica che, in quanto tale, non può essere normativa perché è il frutto anche di distorsioni, di ingiustizie, di limiti e inefficienze, costitutivi o momentanei, del mercato o dello Stato.
Secondo il vice direttore del Fatto quotidiano, invece, dovremmo soltanto porre i futuri universitari davanti all'evidenza della disoccupazione e del precariato allo scopo di frustrare le loro aspirazioni e propensioni. E non invece porre questa stessa evidenza di fronte ai governi affinché, per esempio, aumentino gli scarsi investimenti pubblici in alcuni settori.
Dovremmo farlo non presentando onestamente la realtà, nella sua complessità e nelle sue sfumature, ma banalizzando gli stessi dati e parlando, come fa Feltri, di «facoltà che sfornano disoccupati», quando, come evidenzia l'Istat, anche nel caso delle lauree magistrali in materie letterarie la percentuale di occupati a quattro anni dal titolo è il 73,4%. Ma Feltri scrive che alcune lauree non sono solo inutili, ma perfino «dannose» perché fanno perdere tempo (studiare alcune discipline, come Lingue, sarebbe una perdita di tempo, il messaggio è questo).
Dovremmo farlo sulla base di rappresentazioni immaginarie e puerili di alcuni percorsi di studio e professioni. L'anno scorso Feltri parlava di esistenze da "intellettuali bohemien", riferendosi ai laureati in discipline come filologia romanza. E, sbagliandosi, persiste tuttora nella convinzione che le lauree umanistiche servano solo per arricchire la propria cultura, non anche per acquisire competenze utili alla società. Chi dovrebbe insegnare lettere nei licei, secondo Feltri, o lavorare nelle settore pubblico dei beni culturali?
Dovremmo farlo, inoltre, anche sulla base di una descrizione della realtà dell'Università in Italia scorretta e fondata su miti (troppe facoltà da "sussidiare", troppi iscritti a facoltà "inutili", etc.).
In ultima analisi, dovremmo abbracciare una concezione miope e utilitaristica del sapere, che è la stessa che nutre chi si illude che nella ricerca basti investire solo in ciò che può dare un ritorno economico immediato, e non sulla conoscenza scientifica. E che è perdente anche dal punto di vista economico. Promuovere una minore diversificazione di saperi e competenze è una ricetta per la crescita o per il declino?