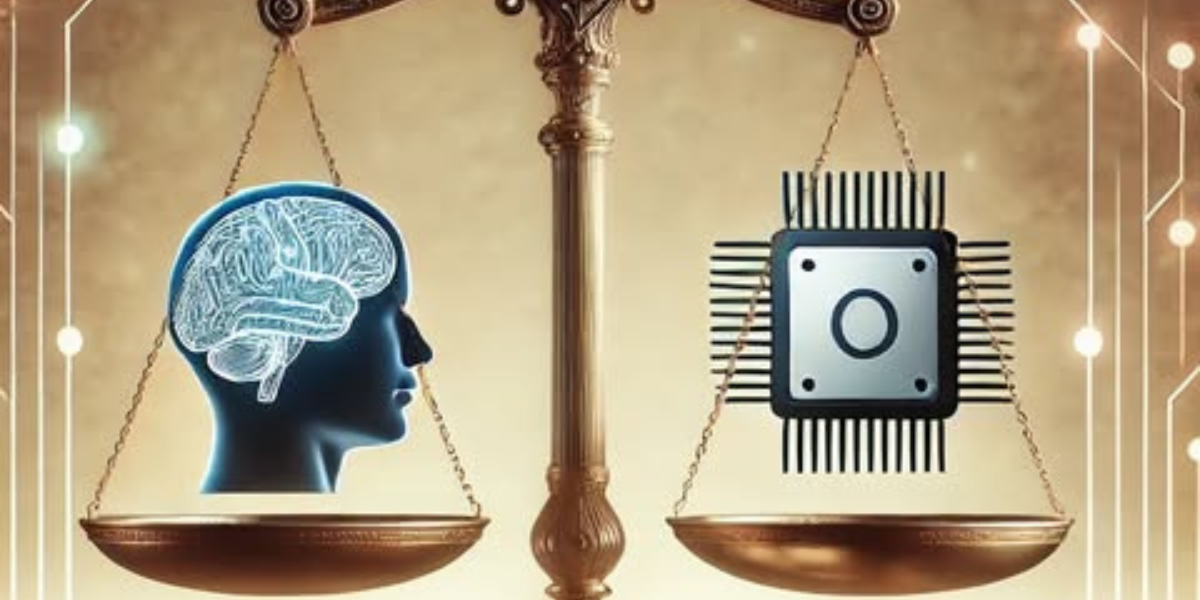Intelligenza artificiale e automazione: che fine faranno lavoratori e lavoratrici?
15 min letturaIl lancio di Chat GPT nel 2023 ha suscitato un forte dibattito intorno all’intelligenza artificiale e le sue implicazioni sulla società. Da una parte c’è chi sottolinea i vantaggi, sia per la ricerca sia per l’esperienza dei cittadini nell’approcciarsi a un mondo sempre di più fatto su misura; dall’altra sono evidenziati i problemi che l’intelligenza artificiale sta già facendo emergere. Pensiamo ad esempio ai deepfake, il cui contributo positivo non è chiaro, mentre abbiamo già assistito al loro utilizzo per la creazione di materiale pornografico o disinformazione politica.
Che cosa si può dire però dell’impatto dell’intelligenza artificiale e dell’automazione per l’economia e in particolare per il mondo del lavoro?
Il tema più cocente è proprio la perdita di posti di lavoro. Un panoramica è offerta da un recente studio del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Se le precedenti ondate di automazione sono andate perlopiù a colpire i lavori meno qualificati (quelli che in inglese vengono chiamati blue collar), la rivoluzione dell’intelligenza artificiale vede un rischio crescente per tasso di istruzione e per tipo di economia. Lo scenario delineato dai ricercatori dell’FMI stima un 40 per cento di posti di lavoro esposti al rischio di automazione e AI, con una maggior incidenza nei paesi occidentali.
Questo scenario è confermato dal Brooking Institute, con i due rapporti del 2019 e del 2020. Il primo non scindeva automazione e intelligenza artificiale: così facendo, i ricercatori giungevano alla conclusione che a essere più colpiti sarebbero stati i lavoratori meno qualificati. Il secondo invece considerava l’impatto dell’intelligenza artificiale, mostrando come esponesse maggiormente i lavori più specializzati.
Una distinzione importante, però, va fatta tra quelle tecnologie che sono complementari e quelle che invece sono sostitutive. Un campo interessante da questo punto di vista, anche se di nicchia, è quello del calcolo numerico. Nei modelli matematici applicati, spesso è richiesta una soluzione del problema e non solo stabilire delle proprietà, come invece succede nella matematica più pura. Il campo del calcolo numerico consisteva anche nel trovare soluzioni approssimate per problemi di natura pratica. Prima dell’avvento dei calcolatori, i metodi venivano implementati con carta, penna e tavole. Con l’avvento dei computer e dei moderni linguaggi di programmazione, la branca non è scomparsa, ma ha invece cambiato in qualche modo il suo scopo, lasciando fare ai computer il lavoro sporco. In questo caso, quindi, la tecnologia non ha svolto un ruolo di sostituzione dell’essere umano: ecco perché si parla di tecnologia complementare.
Quanti lavori saranno complementari alla nuova tecnologia e quanti invece saranno esposti? Sempre secondo le stime sempre dell’FMI, un terzo dei lavori, pur rimanendo esposti ad AI e automazione, saranno fortemente complementari e andranno a cambiare il modo di lavorare, più che sostituire i lavoratori.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Antitrust, robot tax e il ruolo degli Stati
Se questo è lo scenario che si prospetta, è necessario intervenire dal punto di vista politico-istituzionale per contenere i danni della nuova ondata di innovazione, aumentare la produttività e il benessere dei lavoratori, non solo i profitti delle aziende. Prima di addentrarci nella questione, va fatto però un appunto: è una visione ottimista e un po’ naif pensare che il progresso non regga al confronto con la realtà. Gli Stati, attraverso la regolamentazione e gli investimenti, possono influenzare il corso dell’innovazione, andato a ridefinire gli incentivi e le regole che governano il sistema economico.
Ma quali sono i principali problemi evidenziati dalla ricerca scientifica riguardo l’impatto della tecnologia sul mercato del lavoro e sulla nostra economia? Possiamo distinguere due aree: la prima riguardo il lato imprese, la seconda la forza lavoro presente e futura.
Partiamo dalle imprese. Uno dei problemi più cocenti che sono stati affrontati in letteratura è quello, già citato, dell’automazione che sottrae posti di lavoro. Se questo, di per sé, è un problema, il docente del MIT, Daron Acemoglu, ha osservato come queste tecnologie, che spesso vengono vendute come un modo per aumentare l’efficienza e la produttività dell’azienda, in realtà non lo fanno: sono le cosiddette so so technology. Un esempio su tutti sono le casse automatiche: il vantaggio che si trae dall’installazione di casse automatiche in un supermercato è in realtà concentrato sui tagli al personale.
Secondo Acemoglu, uno dei motivi che spinge le imprese ad adottare ciecamente queste tecnologie, anche se non è garantito un vantaggio, è un comportamento gregge. Più automazione c’è, meglio è, sembra essere il motto di queste imprese. Questa tendenza ha delle ricadute ingenti sull’economia, ma anche sulla politica. In primo luogo, un dipendente, sullo stipendio che riceve, paga un’imposta; questo non succede per i robot, o comunque per macchinari che permettono l’automazione. Se il processo di automazione non ha ricadute sulla produttività dell’azienda, abbiamo anche una riduzione del gettito che riceve lo Stato: lo stesso gettito che serve per finanziare il welfare state e la ricerca per supportare questa innovazione.
Per contrastare questa tendenza, una delle proposte più discusse è la robot tax, già proposta a livello politico dal Partito Socialista francese alle elezioni del 2017. Un’imposta di questo tipo da una parte vuole scoraggiare l’automazione in casi in cui questa non abbia elevati benefici per l’azienda, andando così a cambiare gli incentivi interni all’azienda, mentre dall’altra garantisce allo Stato le entrate che verrebbero a mancare dal licenziamento dei lavoratori.
Sul tema hanno dibattuto nel 2019 Ryan Abbott, professore all’Università del Surrey, e il giornalista dell’Economist Ryan Avent. Abbott si è detto favorevole a una tassa sui robot, mentre secondo Avent le nostre paure sulla perdita di posti di lavoro causata dall’automazione potrebbero essere esagerate. A sostegno della sua tesi, Avent ha citato vari casi internazionali, come Germania e Corea del Sud, dove il livello di automazione è estremamente elevato, ma non si è vista una riduzione dell’occupazione. Ha inoltre sostenuto come l’automazione interessi maggiormente un settore ormai meno importante dell’economia come la manifattura.
La tesi di Avent, tuttavia, rischia di essere superata dai fatti. Se, come abbiamo detto prima, estendiamo il nostro sguardo non solo all’automazione, ma anche all’utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dell’AI la perdita di posti di lavoro si estende anche al settore dei servizi. Sia Abbott che Avent, in ogni caso, hanno sottolineato come in un’epoca di elevata automazione come questa è necessario ridurre le imposte sul lavoro, spostandolo sul capitale. In particolare Avent ha proposto, come alternativa alla robot tax, un aumento dell’imposta sui profitti delle imprese che fanno più affidamento sull’automazione.
Non si tratta però di una soluzione indolore. Di recente, una simulazione di ricercatori dell’FMI ha osservato come la robot tax sia sì uno strumento efficace nel contrastare la perdita di posti di lavoro e nel ridurre le disuguaglianze, ma sul lungo periodo porta a un calo del 2% del PIL/per capita. Anche il reddito disponibile dei lavoratori a bassa/media specializzazione avrebbe dei miglioramenti soltanto sul breve periodo. È quindi necessario tenere in considerazione il compromesso tra crescita economica e protezione di posti di lavoro, almeno nel caso dell’automazione.
Un secondo aspetto è quello riguardante la tendenza agli oligopoli, con la nascita delle “Superstar Firms”, cioè quelle imprese che hanno raggiunto una tale grandezza e un tale predominio nel mercato da poter essere considerata monopolistiche/oligopolistiche. È un fatto che oggi il mercato sia dominato da un numero esiguo di imprese, su cui spesso si appoggiano anche le imprese più piccole. Basti pensare al caso della multa inflitta ad Amazon dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per aver di fatto costretto le imprese che vogliono ottenere visibilità sul marketplace, cioè sulla piattaforma, a usufruire di certi servizi di logistica collegati ad Amazon, andando così a sbaragliare la concorrenza. Non solo: in un lavoro del 2020 l’economista David Autor e i suoi collaboratori hanno notato come la concentrazione di Superstar Firm, grazie al ruolo di predominanza nel mercato, è correlata con l’abbassamento della quota salari, cioè il peso che i salari hanno sul PIL, andando quindi a diminuire il benessere dei lavoratori.
La tendenza all’oligopolio in un mercato dominato dalle piattaforme ha, tra le varie concause, la filosofia sottostante alle attività regolatorie. Come ha scritto l’economista Nicola Lacetera, professore all’Università di Toronto, le nomine di Biden alla Federal Trade Commission, una commissione volta a tutelare i consumatori e prevenire comportamenti anticoncorrenziali da parte delle aziende, sembrano andare in una direzione diversa rispetto al passato. La filosofia dominante, infatti, è stata pesantemente influenzata dalle teorie della Scuola di Chicago, una corrente economica prettamente liberista che vedeva nel benessere del consumatore il bene ultimo. Poiché, sfruttando l’economia di scala, le piattaforme potevano offrire beni e servizi a un costo contenuto, questo non portava a particolari criticità nella loro visione. Non solo: anche fusioni e acquisizioni di altre aziende (pensiamo a Meta, che oltre a Facebook possiede al suo interno anche Whatsapp e Instagram) non creavano particolari problemi: i social sono addirittura gratuiti, quindi che problema c’è per il consumatore?
Questo, scrive sempre Lacetera, si discosta dalla filosofia regolatoria che ha pervaso la prima metà del ‘900: la concentrazione del potere economico in poche mani, al tempo, era considerato come un rischio per l’intera comunità che non garantiva una corretta concorrenza all’interno del mercato. Infatti, una tale concentrazione di potere economico utilizzava la sua forza per influire anche dal punto di vista economico, andando di fatto a influenzare i politici che avrebbero dovuto, in linea di principio, normare quelle stesse attività.
Se questo era vero nel ‘900, le moderne piattaforme rappresentano un problema ancora più complesso. Vero, i social network sono gratuiti per gli utenti e Amazon garantisce loro prezzi bassi, ma non è lo stesso per i produttori, come l’esempio citato prima. Piattaforme come i social network invece, poiché di fatto garantiscono lo scambio di informazioni, possono lanciare o promuovere determinati tipi di contenuto che vanno a influenzare il contesto politico- anche se su questo punto c’è un forte dibattito- o privilegiando determinati prodotti da vendere. Inoltre, detengono dati sensibili degli utenti che possono essere fondamentali per comprendere le dinamiche dell’elettorato, come dimostra lo scandalo di Cambridge Analitica.
Le scelte dell’amministrazione Biden sembrano però segnare un cambio di rotta: la nomina di Lina Kahn alla Federal Trade Commission è un segnale importante. Proprio Kahn in passato ha definito scorrette e sleali le mosse di Amazon e delle altre piattaforme.
Anche l’Europa in questo specifico contesto sembra essere al passo, soprattutto con il lavoro svolto dalla Commissaria europea per la concorrenza Margrethe Vestager, anche se sull’efficacia dei procedimenti contro le big tech vi sono dubbi. Per questo recentemente l’Europa ha approvato una legge per regolare le big tech, garantendo maggiori multe o addirittura la loro frammentazione, come aveva già proposto la candidata democratica Elizabeth Warren nel 2020.
Una delle possibili cause dietro questa tendenza all’oligopolio deriva proprio dall’utilizzo dei dati. Le grandi piattaforme, che dispongono di dataset massicci, possono comprendere meglio i meccanismi di mercato e pubblicitari, ottenendo così un maggior utilizzo o più acquisti da parte degli utenti, ma di fatto andando a formare una barriera all’entrata che non permette a nuove aziende, che non hanno a disposizione questi dati, di risultare competitive. Non tutti gli studiosi sono però d’accordo su questa interpretazione dei dati come traino della tendenza all’oligopolio: alcuni sostengono che il vantaggio competitivo non abbia questi effetti, mentre per altri servizi che possiedono informazioni più dettagliate abbiano effettivamente un vantaggio. Su questo punto, come sostiene anche l’economista premio Nobel Jean Tirole, si è fatto ancora troppo poco per avere un’idea chiara della situazione.
Ma, come fa notare di nuovo l’economista Daron Acemoglu, le politiche antitrust da sole non basteranno per risolvere i problemi dell’innovazione. Le imprese, con una tale influenza sul mercato, non solo spingeranno la loro visione, ma sfrutteranno anche il sistema di porte girevoli sia a livello politico sia a livello universitario. Dobbiamo perciò chiederci: che tipo di innovazione vogliamo? E qua subentra il ruolo prominente dello Stato nell’indirizzare l’innovazione. Anche se, in questo caso, è più semplice a dirsi che a farsi. Le organizzazioni statali, che un tempo detenevano il dominio sullo sviluppo delle tecnologie, sono state via via surclassate dalle grandi imprese private, come dimostra ad esempio il settore delle tecnologie nella ricerca medica. Su questo tipo di domande, la ricerca appare indietro rispetto allo stato delle cose.
Che fine faranno lavoratori e lavoratrici?
Quale potrebbe essere la soluzione per evitare un’emorragia di posti di lavoro? Come agire sulla formazione di studenti e studentesse delle prossime generazioni?
Il primo strumento di cui si discute, per porre un rimedio a questa emorragia, è l’Universal Basic Income (UBI, reddito di base): un trasferimento monetario, indipendente dal reddito, a ogni membro della popolazione di un determinato stato. Questo trasferimento è slegato da qualunque tipo di condizionalità- ad esempio formazione o lavoro. Lo Stato, così come oggi offre servizi quale la sanità e l’istruzione, dovrebbe pertanto offrire un reddito alle persone per soddisfare i loro bisogni primari.
Ovviamente, la preoccupazione principale è che il reddito di base scoraggi le persone dal trovare un impiego, in quanto hanno già una fonte di reddito. Ma gli esperimenti condotti hanno finora dimostrato spesso il contrario. Nei Paesi Bassi si è notato come, a differenza degli usuali strumenti di sostegno al reddito, l’UBI permette alle persone di trovare lavori più stabili e soddisfacenti, non andando quindi a ridurre l’offerta di lavoro. In un altro esperimento, svolto in Kenya, i risultati sono stati stupefacenti: le persone hanno cominciato ad aprire imprese e quindi ad assumere altre persone. Questo ha avuto un impatto anche sul bilancio statale: i lavoratori dell’agricoltura in Kenya sono esentati dalle tasse, quindi il fatto di avere lavori al di fuori dell’agricoltura ha portato a un aumento del gettito.
Questo è infatti uno dei problemi sottolineati nella discussione sul reddito di base: come viene finanziato? Poiché andrebbe anche alle fasce più abbienti, il sistema fiscale necessita di un netto cambio che faccia in modo che i benefici tratti dal reddito di base siano poi compensati da un aumento della tassazione. Ma quanto dovrebbe aumentare per avere dei risultati? Secondo uno studio del think tank Autonomy, per implementare uno schema di UBI modesto nel contesto del Regno Unito, non vi sarebbero grandi sconvolgimenti nel sistema di tassazione, poiché aumenterebbe solo il prelievo per le fasce più abbienti della popolazione.
C’è poi un aspetto importante da considerare, come sottolinea Scott Santens, attivista e studioso del reddito di base. Poiché questa nuova ondata di innovazione è trainata dall’utilizzo di programmi che si nutrono dei dati degli utenti senza che questi ne abbiano alcun guadagno oltre a una miglior esperienza, il reddito di base, finanziato con un aumento delle imposte sulle imprese sarebbe una ricompensa dovuta a chi decide di fornire i suoi dati. Inoltre andrebbe anche a impattare sull’organizzazione della vita delle donne. Com’è noto, buona parte delle nostre economie si fonda sul lavoro non retribuito e non riconosciuto delle donne: pensiamo a tutti i compiti che, per stereotipi di genere, vengono relegati alle donne come la cura dei figli, della casa e in alcuni casi degli anziani.
Allo stesso tempo è però necessaria prudenza. Nel corso degli anni infatti il reddito di base è stato visto non solo come un potenziale strumento di contrasto alla povertà e alla disoccupazione dovuta ad automazione e AI, ma ha assunto caratteristiche di strumento essenziale per superare il capitalismo. Un esempio di questa tendenza è offerto da Inventare il futuro. Per un mondo senza lavoro di Nick Srnicek e Alex Williams. Convinti che un ritorno della socialdemocrazia classica sia impossibile dopo il periodo del neoliberismo, gli autori sposano una tesi accelerazionista: è necessario automatizzare il più possibile, garantendo un reddito di base a quei lavori che saranno automatizzati. Allo stesso tempo è necessario alzare il costo del lavoro che non è automatizzabile per garantire investimenti in produttività che garantiranno così una riduzione dell’orario dei lavori rimasti.
Il sogno di un progressismo automatizzato rischia però di portarci verso un feudalesimo digitale. Senza infatti intervenire sulla proprietà delle piattaforme e delle imprese, un panorama del genere garantirebbe semplicemente alle aziende un mondo di consumatori senza dover tuttavia offrire una remunerazione, andando di fatto a creare una società di ultra ricchi da una parte e di sovvenzionati dall’altra. In tal caso, basterebbe un cambio, anche radicale, del sistema di tassazione o bisognerebbe invece ridiscutere delle condizioni materiali, quindi della proprietà privata dei mezzi di produzione?
Veniamo ora all’aspetto dell’educazione, in particolare di chi deve scrivere o comunque supervisionare gli algoritmi che verranno utilizzati in futuro. Come abbiamo detto in precedenza, lo statistical learning si è rivelato un’arma incredibilmente potente per fare previsioni. Ma è necessario avanzare con prudenza. Per fare un esempio, può essere utile approfondire gli algoritmi di nuova generazione come le reti neurali (quelli cioè afferenti al cosiddetto deep learning) rischiano di portarci su una strada impervia.
Negli anni ‘70, come racconta l’informatico Pedro Domingos nel suo libro L’algoritmo definitivo, questo tipo di algoritmi subì un duro colpo a causa di un lavoro di Marvin Minsky, considerato il padre dell’AI. In un lavoro congiunto con Seymour Papert, Minsky demolì i primi tentativi di rete neurale poiché non erano in grado di reggere la condizione “aut”. Per superare queste difficoltà la ricerca si è indirizzata verso le Multilayer Neural Networks (Reti Neurali a Multistrato). Queste si sono rivelate fondamentali in vari campi, a partire dal riconoscimento di immagini. Ma, come spesso accade nel campo dello statistical learning, a una maggior accuratezza coincide una certa opacità del procedimento: non sappiamo bene cosa stia facendo la rete neurale a multistrato. Se questo non è particolarmente problematico nelle applicazioni alle scienze dure, quando si entra nel campo delle scienze sociali le cose si fanno più complesse. Avere ben chiaro quello che sta facendo un algoritmo ci permette di comprendere quando potrebbero esserci problemi.
Un problema particolarmente importante sorge proprio nelle scienze sociali e nelle loro applicazioni poi politiche. Come sostenuto da Sendhil Mullainathan e Jann Spiess, due econometrici, se lo statistical learning è ottimo nel fare previsioni, è necessario fare più attenzione quando si tratta di avere delle stime causali. Che cosa significa? Facciamo un esempio molto conosciuto: supponiamo di voler stimare se l’ospedale renda più sani o più malati. Il rischio è che semplicemente si prendano i dati delle persone che sono state in ospedale e quelle che invece non ci sono state. Così facendo il risultato è che l’ospedale rende malati. Perché? Banalmente, non si è considerato quello che si chiama “bias selettivo”: chi è di salute più cagionevole va spesso all’ospedale, mentre chi è sano, di fatto, all’ospedale ci va molto poco. Per ottenere stime causali (un fenomeno X causa un fenomeno Y) nelle scienze dure si è soliti fare esperimenti. Ma questi non sono possibili nel campo delle scienze sociali, tranne in rari casi.
Al fine di comprendere questi temi è necessario quindi non solo una preparazione statistica, ma anche una di natura più “filosofica” sui nessi di causalità, come chi lavora nel campo della valutazione di politiche pubbliche sa da tempo. Ma oggi le tecniche di statistical learning sono fuoriuscite dall’accademia, dove questi temi si dovrebbero sapere (anche se non è proprio così). In mano alle imprese, o anche a studiosi che non hanno una solida formazione, quanto visto potrebbe portare a risultati potenzialmente falsati che però influenzerebbero la vita di molti.
In generale inoltre è necessario, come già successo con le biotecnologie, rivolgere l’attenzione anche agli aspetti etici riguardanti l’AI: proprio su questo punto c’è una netta sottovalutazione degli Stati, che spendono troppo poco per valutare gli effetti negativi di questo tipo di tecnologie. Allo stesso tempo è necessaria la disseminazione di questo tipo di conoscenze. Spesso il pubblico non è a conoscenza di che cosa si celi dietro algoritmi che sono pervasivi nelle nostre vite. Una maggior comprensione di questi metodi permetterebbe un dibattito più aperto e sostanziale all’interno della discussione pubblica, permettendo anche alla politica di poter avanzare proposte comprensibili dall’elettorato in tal senso.
Sull’intelligenza artificiale serve cautela
Quanto visto finora suggerisce un approccio ben preciso. È necessario abbandonare l’idea che la regolamentazione sia un ostacolo allo sviluppo delle nuove tecnologie: il progresso tecnologico è sempre inserito in un contesto istituzionale, formato sia dalle politiche sia dalle esigenze dei cittadini. Questa sfida è tutt’altro che semplice, visto che in alcuni casi il rallentamento del tasso di adozione di robot e altre forme di automazione, fatto per salvaguardare la forza lavoro, potrebbe tradursi in un calo del PIL/pro capite e in un minor reddito disponibile proprio per le fasce meno specializzate della forza lavoro. Molto rimane da fare sul fronte della ricerca: spesso quello che avviene nel mondo della tecnologia richiede tempo per essere approfondito e studiato a fondo per comprenderne le implicazioni e le eventuali politiche da attuare per attenuare i problemi.
Allo stesso tempo, preso atto che vi sarà in ogni caso una riduzione drastica di posti di lavoro, e che in generale il lavoro andrà incontro a mutamenti considerevoli, non si può non pensare a politiche indirizzate al sostegno dei lavoratori e alla formazione delle nuove generazioni di studenti. Non è infatti inverosimile che l’AI diventerà ancora più pervasiva anche in settori inaspettati, come la letteratura. Senza un ripensamento profondo del nostro sistema di istruzione e una disseminazione della conoscenza, il rischio è che il dibattito pubblico ignori questi temi fino a quando non saranno inevitabili con conseguenze pesanti sulla società.
Immagine in anteprima: Foto di Pavel Danilyuk via pexels.com