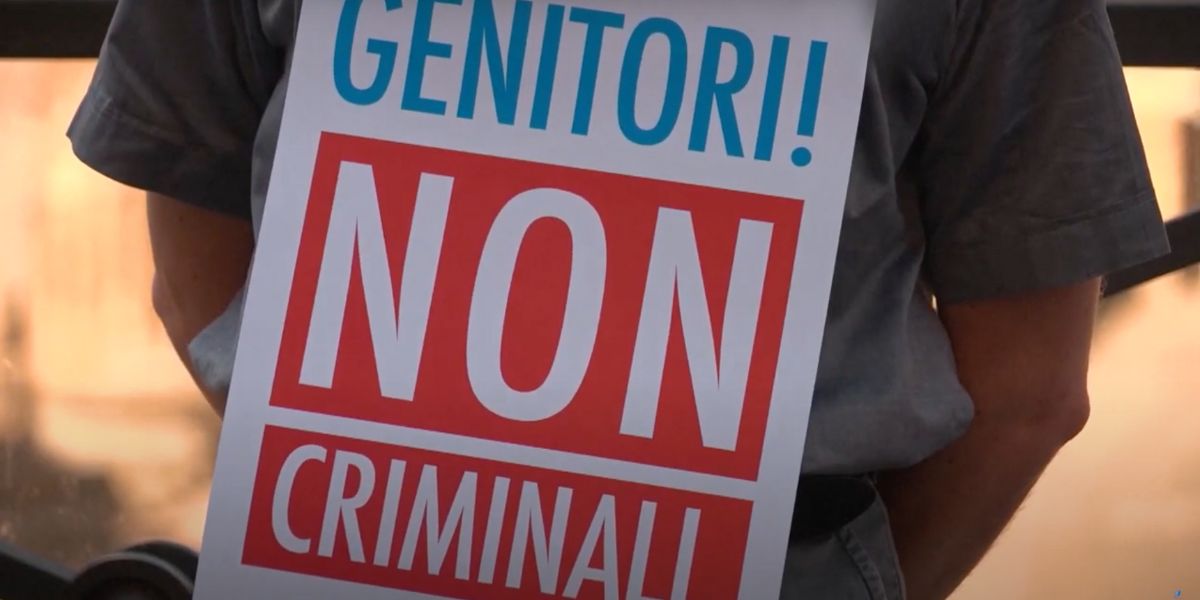La rivoluzione fiscale promessa dal governo Meloni manterrà solo le disuguaglianze
7 min letturaAlmeno dai tempi della “rivoluzione liberale” berlusconiana, sulle tasse - e sul loro taglio - la destra italiana ha costruito un’intera narrazione, dall’agitare lo spettro della patrimoniale all’accusa, rivolta alla sinistra, di mettere le mani nel portafoglio degli elettori. Non a caso il governo Meloni, il primo governo apertamente di destra da dieci anni a questa parte, ha puntato molto sulla retorica anti-tasse, già a partire dalla campagna elettorale. Ma le promesse elettorali sono una cosa, realizzarle un’altra: come tutti i governi italiani, quello guidato da Meloni si ritrova a fare i conti con risorse scarse e un debito enorme, che riducono i margini di manovra. Come già successo con la manovra di bilancio, anche la riforma fiscale appare meno preoccupante rispetto alle promesse, soprattutto quelle di Lega e Forza Italia sulla flat tax, ma comunque presenta varie perplessità, sia per quel che riguarda le coperture sia per quel che riguarda l’effetto sulle disuguaglianze.
La rivoluzione fiscale promessa da Meloni
Vediamo in che cosa consiste la riforma fiscale del governo Meloni, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e che dovrebbe, secondo i suoi sostenitori, riscrivere l’intero sistema tributario italiano. Lo scopo dichiarato è ridurre la pressione fiscale nel nostro paese e razionalizzare il sistema, oggi in preda a una vera sclerosi di spese fiscali.
Il provvedimento principale è sicuramente la riforma dell’IRPEF, con il passaggio dalle quattro aliquote volute dal governo Draghi a tre. Non è ancora chiaro su quali aliquote vorrà intervenire il governo Meloni, pertanto non è possibile stabilire a chi andranno i benefici del taglio dell’imposta.
Per trovare le risorse il governo Meloni vuole mettere mano alle spese fiscali, definite nel corso degli anni una giungla. Si tratta di quegli importi che non verranno riscossi perlopiù per via di un abbattimento del quantitativo su cui è calcolata l’imposta detta base imponibile, o per via di una riduzione dell’imposta stessa. Ovvero quelle che si chiamano deduzioni e detrazioni, rispettivamente. Il taglio di queste garantirebbe, secondo gli esponenti del governo, un primo tesoretto per finanziare il taglio dell’IRPEF.
Il governo ha inoltre proposto un alleggerimento dell’IRES, ovvero l’imposta sul reddito delle società. Questo va nella direzione proposta da Fratelli d’Italia del principio “più assumi meno paghi”, garantendo quindi un taglio a chi impiega utili in investimenti e assunzioni a tempo indeterminato. Nella Delega fiscale non manca poi l’intenzione di un netto ridimensionamento dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, un punto su cui l’intero arco parlamento si è sempre detto disposto a intervenire. Proprio in virtù della dimensione locale dell’imposta, quest’ultimo punto dovrà passare attraverso la mediazione con gli enti locali.
Il problema dell’IRPEF di Meloni (e non solo)
Come abbiamo detto il punto più importante della riforma annunciata dalla delega di Meloni è il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF, dove già il governo Draghi aveva provveduto a passare da 5 a 4. Il fine scritto nero su bianco, pur non vincolante e irrealizzabile, è l’introduzione di un’imposta piatta nel nostro paese, la famosa flat tax.
Almeno due perplessità non possono che essere sollevate. La prima riguarda ovviamente le coperture. La riforma fiscale del governo Draghi era in un contesto più favorevole al governo, mentre Meloni si ritrova a fare i conti con finanze tutt’altro che rosee.
Il piano di Meloni e del suo governo per trovare le coperture è articolato. In primo luogo c’è un evergreen della politica italiana: il contrasto all’evasione fiscale, tanto che nella delega c’è anche un approccio più collaborativo e meno repressivo con le aziende. Purtroppo se già in altre occasione il recupero dell’evasione fiscale sembrava più un ottimo escamotage che non altro, nel caso del governo Meloni la situazione presenta ulteriori perplessità: fin dai primi giorni i provvedimenti del governo sembrano incentivare una maggior evasione fiscale, basti pensare all’innalzamento del limite all’uso del contante e alla soglia per il regime forfettario per lavoratori autonomi.
Nel corso della campagna elettorale Fratelli d’Italia aveva dichiarato che attraverso una riduzione dell'imposta si sarebbe incentivato il lavoro rispetto ai sussidi, aumentando così il gettito IRPEF.
L’idea è abbastanza semplice: riducendo il prelievo fiscale, gli individui sarebbero più incentivati a lavorare e ad aumentare il reddito. Una previsione intuitiva, ma che nella realtà è leggermente più complessa. La posizione più intellettualmente onesta su questo punto è che l’evidenza empirica è dibattuta, non potendo pervenire a una singola risposta.
Come fa notare Charles Manski, professore di economia alla Northwestern University, non abbiamo certezze sull’effetto che la tassazione sul reddito ha sull’offerta di lavoro. C’è da tenere in considerazione l’eterogeneità dei contribuenti: per fare un esempio, come rispondono i lavoratori più ricchi o più poveri?
Non conoscendo ancora i dettagli tecnici della riforma Meloni dell’IRPEF e come andrà a cambiare, non è possibile oggi stabilire se ci saranno effetti benefici o meno, anche se è probabile che data l’entità della riforma saranno comunque scarsamente significativi per risollevare la situazione economica italiana.
C’è però un aspetto che, già da tempo, gli esperti sottolineano: quello riguardante il secondo scaglione. Mentre i redditi compresi tra i 15 mila e i 28 mila hanno un’aliquota marginale- ovvero quanto viene tassato l’incremento di un solo euro- del 25%, tra i 28 e i 50 mila l’aliquota passa al 35%. Questa netta differenza potrebbe- il condizionale, per quanto detto prima, è d’obbligo- disincentivare l’aumento di reddito di questa fascia. Se c’è un provvedimento che va a peggiorare questa situazione è proprio la riduzione del numero di aliquote.
Infine, come abbiamo detto, c’è la questione spese fiscali. Il problema è un altro leitmotiv della politica italiana: ogni partito si dichiara favorevole a una semplificazione della giungla, appunto, delle spese fiscali. Tuttavia il numero totale delle spese fiscali è andato aumentando nel corso degli anni: come sottolineato dal rapporto del MEF si è passati da 444 nel 2016 fino a 626 nel 2022, quindi una crescita del 40% nel giro di sette anni.
C’è un altro dato interessante, circa le dimensioni del fenomeno e le comparazioni con l’estero. Nonostante il numero di spese fiscali sia tra i più alti rispetto agli altri paesi, l’importo medio in Italia per contribuente è piuttosto contenuto, dimostrando un carattere non sistematico e frammentato. Questo è un sintomo di come il sistema fiscale sia in realtà in preda di interessi di gruppi di potere e a favoreggiamenti politici. A livello di mancato gettito, le spese fiscali vengono stimate a 128,6 miliardi per il 2022 e 125,6 miliardi per il 2023.
Ovviamente alcune di queste spese non sono eliminabili: un’opzione, come sottolineano su La Voce gli economisti Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi, è costituita dalla cancellazione parziale delle detrazioni incentivanti. Queste, infatti, hanno una maggior incidenza sulle fasce più abbienti della popolazione.
Anche in questo caso, il governo Meloni non è dissimile dai suoi predecessori: le parole circa l’intervenire sulle spese fiscali ci sono, come sempre, ma sarà la volta buona? E l’intervento migliorerà davvero il sistema?
Il secondo problema è sulla natura stessa dell’IRPEF. Quest’imposta, che costituiva la spina dorsale della riforma tributaria voluta dal governo Rumor negli anni ‘70, doveva andare a coprire- nelle intenzioni- tutti i redditi. Da quel momento in poi- in realtà già nella riforma Rumor c’erano redditi non assoggettati all’IRPEF-, si è andati via via modificando il sistema, rendendola di fatto un’imposta straordinaria su redditi da lavoro dipendente e pensionati. Il problema è che le altre forme di tassazione dei redditi sono spesso piatte, non progressive, andando quindi a peggiorare la situazione sul fronte disuguaglianze che, secondo le stime dell’OECD, già nel 2013 pesavano per svariati punti sulla crescita italiana.
Dalla delega fiscale non sembra che il governo Meloni sia intenzionato a intervenire su questo fronte. D’altronde, se l’orizzonte è la flat tax, non ci si può certo aspettare una riforma che tenga in considerazione l’equità del sistema fiscale.
C’è infine un aspetto critico riguardo la proposta di certi beni, quelli di primo consumo, a IVA zero. Questo è un aspetto delicato. Perché da una parte l’IVA è un’imposta regressiva: poiché le persone meno abbienti destinano, in rapporto al reddito totale, una maggior quota di denaro ai consumi, ovviamente sono loro a essere più colpite. Ma una riduzione dell’IVA potrebbe non sortire gli effetti sperati. I beni di prima necessità sono beni anelastici: com’è noto, la domanda di un bene si riduce all’aumentare del prezzo.
Il problema è: di quanto? La risposta risiede nell’elasticità del bene. Se l’aumento del prezzo riduce considerevolmente la domanda, il bene è elastico, altrimenti è anelastico. Ovviamente i beni di prima necessità sono considerati anelastici: l’aumento di prezzo di pane, acqua, latte non si ripercuote più di tanto sulla domanda. E anzi: la teoria della tassazione ottimale stabilisce che sia più efficiente tassare i beni relativamente anelastici. Certamente, dal punto di vista dell’equità, questa non è una soluzione accettabile. Ma già oggi l’IVA su questi prodotti è relativamente bassa. Poiché la domanda non risponde ad aumenti di prezzo, un taglio dell’IVA su questi diminuirebbe il gettito dello Stato ma non è detto che questo si ripercuota anche sui prezzi al consumo. Di fatto, lo Stato ci perderebbe dei soldi e i consumatori non avrebbero particolari benefici.
La soluzione non passa dal taglio delle tasse
La rivoluzione sulle tasse (una sorta di revival reaganiano) che Meloni vorrebbe intestarsi non avrà effetti salvifici sulle dinamiche del paese. Innanzitutto perché i benefici andranno prevalentemente al ceto medio: già oggi le tasse per le fasce meno abbienti sono piuttosto basse. Ma soprattutto perché, tanto a destra quanto a sinistra, la questione tasse appare più un cavallo di battaglia elettorale: la destra vorrebbe sprigionare le forze di mercato abbassando le tasse, la sinistra attraverso la redistribuzione.
Entrambe queste posizioni non colgono la natura del problema italiano - e non solo. La battaglia non è tanto sulla tassazione, ma su quello che si può fare con le tasse. Un sistema fiscale, quindi, che premia il lavoro, ma allo stesso tempo colpisca la rendita e finanzi servizi pubblici di qualità come istruzione e sanità. Proprio su quest’ultima, che costa il 21% dell’IRPEF secondo l’Agenzia delle Entrate, bisognerebbe concentrarsi, vista la situazione drammatica degli ospedali e del personale ospedaliero.
Forse a Meloni e al suo governo conviene scommettere sugli effetti elettorali di questa riforma, più che sulla capacità di migliorare il nostro paese.
Immagine in anteprima via Il Foglio