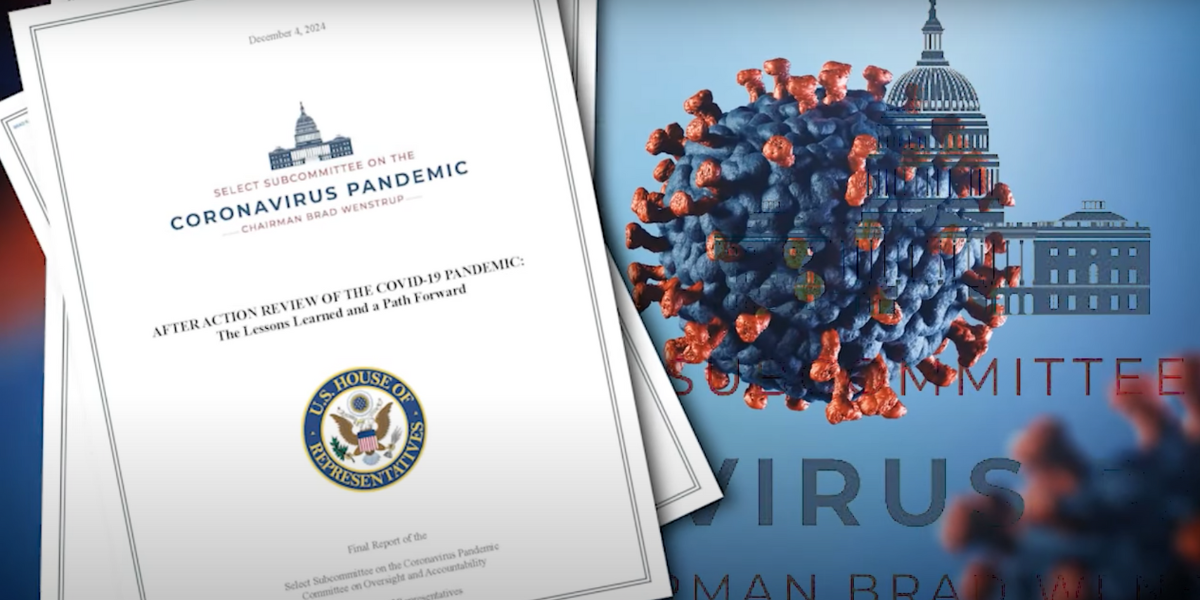Il giornalista che combatte via radio la disinformazione su COVID-19 nel più grande campo profughi del mondo in Kenya
7 min letturaDadaab è una città del Kenya della contea di Garissa, situata al confine con la Somalia. Con i suoi cinque campi di accoglienza (Dagahaley, Hagadera, Ifo, Ifo II e Kambioos) è il più grande insediamento di rifugiati del mondo.
Istituito come sito provvisorio quando giunsero in 90.000 per scappare dalla guerra civile in Somalia nel 1991 e dopo un secondo grande afflusso verificatosi nel 2011 di circa 130.000 persone in fuga dalla siccità e dalla carestia della Somalia meridionale, il campo di Dadaab - che nel tempo è arrivato a ospitare fino a 600.000 profughi - accoglie 217.511 rifugiati e richiedenti asilo ufficialmente registrati (dati marzo 2020).
Tra i suoi residenti ci sono oggi i figli e i nipoti di chi cercò protezione ormai quasi trent'anni fa.
Come in tutti i campi profughi che hanno una densità abitativa molto alta e nei quali si vive in condizioni precarie - tra cui Cox’s Bazar in Bangladesh e Moria in Grecia - anche a Dadaab un'eventuale diffusione del COVID-19 sarebbe devastante.
Worrying. I have seen the crowded crowded conditions in the the Dadaab refugee camps & how health services were under pressure. @UNHCR_Kenya, @UN Agencies supporting the government to mitigate risks & prevent further #COVID19 spread.https://t.co/1YJ0oC2QDt via @refugees
— Melissa Fleming ?゚ヌᄈ (@MelissaFleming) May 21, 2020
Per questo motivo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 11.00, Abdullahi Mire conduce un programma radiofonico su radio Gargar in diretta da un container un tempo utilizzato dalle Nazioni Unite per distribuire forniture ai tre campi profughi situati nel nord-est del Kenya.
32 anni, organizzatore di comunità, attivista e scrittore, Mire è stato soprannominato dalla comunità di Dadaab “Corona Guy” (l'uomo del coronavirus) per il suo impegno nel combattere la disinformazione sulla pandemia fornendo via radio aggiornamenti e intervistando esperti per smontare i falsi miti sul nuovo coronavirus.
A raccontare la storia di Abdullahi Mire su Coda è Ismail Einashe che lo ha intervistato telefonicamente.
Informing his community about #COVID19 meant leaving a life in Nairobi to return to refugee camps in Dadaab: Journalist @miire06 explains in our #InformationSavesLives series: https://t.co/hc7CJPGc81 pic.twitter.com/2oOoCwlyIu
— Internews (@Internews) April 27, 2020
Nato a Qoryooley, una città a sud della Somalia, Mire aveva solo tre anni quando è arrivato a Dadaab con la famiglia, in fuga dalla guerra civile.
Fondatore di Dadaab Book Drive, un'iniziativa di volontariato che raccoglie libri da donare a bambine e bambini in età scolare e giovani che vivono nei campi profughi, si è diplomato in giornalismo e pubbliche relazioni. Successivamente ha iniziato a lavorare nel mondo dell'informazione per media e ONG. Negli ultimi cinque anni ha scritto, tra gli altri, per Washington Post, Al Jazeera, Guardian e fino a marzo scorso viveva a Nairobi dove lavorava e studiava per conseguire la laurea in Comunicazione di massa.
To Inform
Educate
Entertain refugee/host communities in #Dadaab this difficult time of #Covid19 i’ll be volunteering to work on a series of radio programs about #coronavirus
The only means to reach to the communities is thro ? Gargar supported by @UNHCR_Kenya @Internews now pic.twitter.com/v6LGuza3e4
— Abdullahi Mire?¬タヘ? (@miire06) April 2, 2020
«Non appena la notizia del coronavirus è arrivata a Nairobi, ho deciso di fare le valigie e tornare al campo profughi di Dadaab per aiutare la mia comunità», ha detto a Internews, un'organizzazione no profit che promuove e sostiene i media locali in tutto il mondo. «La mia comunità mi ha istruito, mi ha fornito opportunità e supporto. Credo che sia mio dovere aiutarla in tutti i modi possibili», ha aggiunto.
I and Radio Gargar presenter Mohamed Abdullahi planning new ways to inform the communities at #Dadaab about #COVID19 #informationSavesLives pic.twitter.com/sOW4wO7n4D
— Abdullahi Mire?¬タヘ? (@miire06) May 20, 2020
Al 15 giugno il Kenya ha registrato 3.594 casi di COVID-19, 103 decessi e 1.253 ricoveri.
Lontana dal resto del paese l'area di Dadaab sembrava essere stata risparmiata. Fino al 18 maggio scorso, quando il ministero della Sanità del Kenya ha confermato i primi due casi di nuovo coronavirus a Ifo e a Dagahaley, nonostante alla fine di aprile il governo kenyota avesse bloccato i movimenti da e verso il campo profughi nell'ambito di una serie di misure preventive adottate.
Kenyan government puts Kakuma & Dadaab refugee camps on lockdown effective Wednesday, April 29 to curb the spread of COVID-19.
Photo: Robin Njogu#tukonews #Dadaab #cessation #COVID19 pic.twitter.com/ZMQkVNa6tf
— Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) April 28, 2020
Two positive cases of #COVIDー19 reported in #Dadaab, a refugee settlement hosting thousands of refugees and asylum seekers in N.E #Kenya. The two cases are in #Ifo and #Dhagahley camps. ?゚リᄋ?゚ヌᆰ pic.twitter.com/ix8P9plgpT
— Abdulaziz Billow Ali (@AbdulBillowAli) May 18, 2020
All'interno di Dadaab sono tre i centri di isolamento allestiti che ospitano 800 posti letto e dotati di un unico ventilatore polmonare.
Ciononostante, secondo Mire, la maggior parte della comunità non sembra preoccupata per il virus.
«La gente dice: “Siamo neri, il nostro sole è caldo”, convinta che entrambi i fattori offrano una qualche forma di protezione contro le infezioni», ha spiegato.
Sia quando va in onda che sui suoi account social, Mire rassicura i suoi ascoltatori, raccomanda continuamente di lavarsi le mani e offre un flusso costante di informazioni su come proteggersi dal virus.
Ma per i residenti del campo seguire le più semplici indicazioni per salvaguardarsi dal COVID-19 è una sfida enorme. «Dadaab è un posto dove si fa la fila per qualsiasi cosa», racconta Mire. «Il distanziamento sociale non è possibile dal momento in cui centinaia di persone condividono un unico rubinetto per l'acqua».
Il dottor John Kiogora, coordinatore sanitario senior dell'International Rescue Committee ha spiegato che, a causa della scarsa igiene e del sovraffollamento, gli insediamenti di rifugiati sono particolarmente esposti a focolai di malattie infettive su larga scala.
«Le famiglie di rifugiati a Dadaab vivono insieme in tende e ripari di fortuna e sono confinate in piccoli spazi senza accesso ad acqua, servizi igienici e igiene adeguati, rendendo le condizioni perfette per la diffusione della malattia», ha dichiarato.
A confermare le parole di Kiogora la testimonianza di Muhuba Hassan Hilow, rifugiata e madre single 52enne, che vive con otto figli nel campo di Dagahaley. Per lei, osservare le buone pratiche su igiene e distanziamento sociale è un lusso.
«Abbiamo pochissima acqua, non c'è sapone per lavarci le mani e solo quel tanto che basta per pulire i vestiti», ha raccontato. «Questa è una malattia che Dio ci ha portato - tutto quello che posso fare è pregare».
Mire spera che i numeri non subiscano impennate e si adopera giorno dopo giorno per trasmettere alla comunità di Dadaab informazioni potenzialmente salvavita. A questo scopo ha dato una mano a tradurre in somalo informazioni sul COVID-19 fornite dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riportate in volantini e poster che sono stati distribuiti in tutto il campo.
Lo scorso aprile Mire ha ricevuto un contributo economico da Internews per continuare a svolgere il suo lavoro e sfatare falsi miti. Con quei soldi vuole aumentare la durata della trasmissione radiofonica che conduce passando da 20 minuti a un'ora al giorno e proverà a realizzare programmi di intrattenimento per bambini per aiutare a combattere la paura e l'isolamento.
Ma per la maggior parte del tempo Mire è occupato a confutare ipotesi scientificamente false come quella secondo cui i somali sono immuni dal virus o l'altra per cui la protezione dalle infezioni viene garantita se si recitano ogni giorno cinque preghiere islamiche.
«Ad esempio - racconta il freelance - si credeva diffusamente che i somali in quanto devoti musulmani non fossero esposti al COVID-19. Ho replicato a questa disinformazione parlando della morte di Axmed Ismaaciil Xuseen, un apprezzato musicista somalo. Come membro della comunità, e grazie alla mia profonda conoscenza della sua cultura, sono in grado di affrontare la disinformazione in un modo che non è pensabile per le agenzie che attualmente condividono guide sul distanziamento sociale e altre strategie di prevenzione».
Anche a Dadaab, come in altri paesi, hanno preso piede teorie e complotti sulla diffusione della pandemia. Mentre alcuni residenti non prendono sul serio la malattia, altri ne sono terrorizzati e ritengono che sia nata in occidente fabbricata dalle agenzie di aiuto internazionali con l'obiettivo di raccogliere soldi.
Come spiega Hassan Mohamed Yusuf, un uomo 64 enne che vive nel campo di Hagadera di Dadaab, fuggito da Mogadiscio 16 anni fa, ogni volta che qualcuno arriva "da fuori", il terrore si propaga.
«Tutti hanno molta paura. Le persone scappano letteralmente gridando: "Questo ragazzo è uno straniero" oppure "È stato recentemente in America"».
Ad aprile un sondaggio condotto da Save the Children nella vicina Somalia che ha coinvolto 3.600 persone ha mostrato che il 42% degli intervistati ritiene che il COVID-19 sia una "campagna governativa". Circa tre quarti dei partecipanti hanno dichiarato di aver sentito parlare del virus ma di non conoscerlo abbastanza, mentre il 27% ritiene che la pandemia abbia creato uno stigma nei confronti di specifici gruppi minoritari nella propria comunità. Di questi, il 32% pensa che il virus abbia stigmatizzato tutti gli stranieri.
Gli stranieri, così come accaduto nella Repubblica Centrafricana ad aprile dove operatori umanitari e forze di pace sono stati attaccati da folle inferocite, sono visti sempre più come vettori del virus.
La preoccupazione di Mire è che questa paura dello straniero venga proiettata sulla sua comunità. Secondo la sua opinione il governo keniota "non si fida completamente dei rifugiati" per cui teme che i membri di questa popolazione vulnerabile possano diventare capri espiatori in quanto presunti portatori della malattia.
Più volte in passato il governo keniota ha minacciato di chiudere definitivamente il campo di Dadaab - ultimamente a marzo 2019 - ritirando successivamente la proposta. Questa volta, però, Mire, insieme a molti altri, teme che i politici possano cogliere l'opportunità fornita dal COVID-19 per raggiungere questo obiettivo.
Da quando l'OMS ha dichiarato il nuovo coronavirus pandemia "nessuno ci ha parlato molto del virus", ha detto Yusuf. «Tutto è stato chiuso e gli operatori umanitari sono spariti».
«Sono molto spaventato perché ho il diabete e ho sentito che le persone come me saranno le più colpite», ha aggiunto. «Non abbiamo risorse e neanche assistenza sanitaria. Ci sopprimerà».
L'uomo, tuttavia, segue scrupolosamente le raccomandazioni radiofoniche di Mire. Nonostante i saluti affettuosi siano una parte importante della cultura somala, dopo aver ascoltato i consigli su radio Gargar, non stringe più la mano alle persone quando le incontra.
«Sapevo che le mie competenze come giornalista sarebbero state più utili nel campo, aiutando la mia comunità, rispetto a Nairobi come freelance», ha detto Mire. «Ci sono pochissime persone a Dadaab con le capacità e l'esperienza giornalistica che ho avuto la fortuna di acquisire. Così ho scelto di utilizzarle dando una mano qui».
foto in anteprima via Dadaab Book Drive