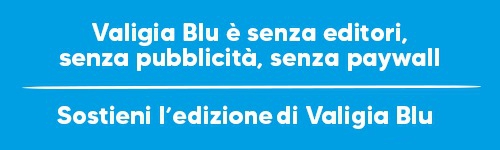Il piano dell’Europa per rilanciare l’economia: basterà per colmare il divario con USA e Cina?
13 min letturaA partire almeno dalla crisi del 2008, l'Europa ha perso terreno nei confronti degli Stati Uniti d’America e la crisi indotta dalla pandemia ha peggiorato la situazione. Ma all’aspetto economico oggi si lega sempre di più un mutato contesto geopolitico. La rielezione di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti indebolisce i rapporti con lo storico partner d’oltreoceano, con il Presidente degli Stati Uniti che minaccia una politica di dazi sempre più aggressiva nei confronti dell’Europa. Dall’altra parte si è assistito all’ascesa della Cina, sia a livello economico sia a livello politico. Il rapporto tra queste due potenze sembra portare alla mente una situazione da guerra fredda, come dimostra la corsa all’intelligenza artificiale. Stretta tra queste due potenze, c’è un’Europa più debole, dilaniata da partiti di destra radicale e dagli interessi, spesso divergenti, dei singoli paesi.
Anche la politica ha ormai preso coscienza della situazione critica in cui versa l’Europa. Non è un caso se la precedente Commissione Von Der Leyen aveva incaricato due ex Presidenti del Consiglio, Enrico Letta e Mario Draghi, di redigere due rapporti sul mercato unico e sulla competitività rispettivamente. Questi rapporti servivano per fare una diagnosi dell’economia europea e delle possibili soluzioni. Basandosi proprio su questi due documenti, nei giorni scorsi la Commissione Europea ha rilasciato la Bussola per la competitività dell'UE, un testo strategico che delinea le azioni prioritarie per rilanciare l’economia europea nei prossimi cinque anni.
Il documento si concentra su tre pilastri principali che guideranno l’azione della Commissione nei prossimi anni e che, secondo questa, sono imperativi per una trasformazione dell’economia europea in grado di rafforzare la sua competitività.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Tornare a innovare: come l’Europa può tornare a essere grande
Il primo pilastro riguarda il gap sull’innovazione che l’Europa ha accumulato nei confronti di Stati Uniti e Cina. Il punto di partenza è un fatto noto: nonostante l’Europa abbia una percentuale di brevetti che può competere con Cina e Stati Uniti, solo un terzo di quelli registrati dalle università riescono a fare il salto e arrivare sul mercato. C’è quindi un ostacolo tra la fase di ricerca e quella di commercializzazione che blocca l’economia europea.
Eppure è proprio l’innovazione che traina la crescita economica. Il report di Draghi, sulla scia della ricerca economica, individua la crescita della produttività (un indicatore che misura il grado di efficienza di un’economia) come risultato di due forze. Da una parte quella distruzione creatrice portata dalle nuove imprese innovative che sostituiscono una parte delle aziende precedenti, i cui prodotti sono ormai diventati obsoleti. Dall’altra l’imitazione di aziende più grandi e mature che, incorporando queste innovazioni, possono diventare più efficienti. Se questa dinamica è inceppata, ci si ritrova in una situazione di scarsa innovazione e bassa spesa per il settore Ricerca e Innovazione. Ovvero la situazione in cui si trovano le imprese europee.
All’interno del documento, la Commissione individua vari provvedimenti che intende adottare e strategie per risolvere questo problema. In primo luogo, una strategia per le start-up e il loro sviluppo che partirà dal migliorare le connessioni tra università/centri di ricerca e le aziende.
Un aspetto su cui la Commissione è intenzionata a intervenire riguarda l'eccesso di frammentarietà nella regolamentazione. In Europa le aziende si ritrovano 27 diversi regimi legali con cui rapportarsi. Per questo la Commissione è intenzionata a proporre un “28esimo regime legale” che semplificherà le regole e ridurrà i costi per quelle che falliscono.
Ma queste aziende che dovranno emergere nei piani della Commissione avranno soprattutto bisogno di fondi per poter prosperare. Nonostante l’Europa non abbia problemi sullo stock di capitale, l’ambiente in cui si trovano ad operare investitori e aziende non premia il rischio. Il fine della Commissione è incentivare il capitale di rischio (venture capital), che è più debole rispetto agli Stati Uniti. Secondo i dati della Banca Europea degli Investimenti la quota di capitale di rischio raccolta in Europa è al di sotto del 10% di quella globale, mentre per gli Stati Uniti arriva al 52%.
Allo stesso tempo, una parte dei fondi verranno erogati dal pubblico. Nelle intenzioni della Commissione c’è infatti un aumento dei fondi in Ricerca e Sviluppo e un maggior coordinamento per quel che riguarda i progetti ad elevato impatto. Per raggiungere il primo obiettivo sarà presentato un European Research Act, che stabilirà come target la spesa per Ricerca e Sviluppo al 3% del PIL. Ma oltre all’aspetto pecuniario, c’è quello del coordinamento e della valutazione dei progetti. Rifacendosi al report di Draghi, il documento della Commissione cita come esempio l’Agenzia Federale Americana DARPA, che si occupa della ricerca nel campo della difesa. Si tratta di un caso di studio fondamentale, citato varie volte ad esempio dall’economista Mariana Mazzucato. Il sistema delle Agenzie americane rappresenta un modello vincente per i cosiddetti progetti a missione. Il vero rischio, tuttavia, è l’implementazione: valutare questi progetti presenta non pochi ostacoli, a partire dalla loro natura rischiosa e dall'eventualità di ingerenze politiche.
Oltre a interventi diretti, la Commissione intende favorire la diffusione dell’innovazione su larga scala. Oggi infatti solo una piccola parte delle imprese europee si serve di tecnologie digitali, con solo il 13% che utilizza l’intelligenza artificiale. Una maggior diffusione di queste tecnologie in settori come quello manifatturiero, automotive, robotica e farmaceutico è necessaria per renderli più competitivi sul mercato globale. Ma oltre al privato, anche il settore pubblico e in particolare la pubblica amministrazione richiede una maggior penetrazione di tecnologie avanzate – il documento cita ancora una volta l’intelligenza artificiale.
Affinché ciò avvenga, è necessario investire su infrastrutture digitali all’avanguardia. Come ha evidenziato il report sugli obiettivi della Digital decade, il vecchio continente è indietro. Per correggere questa dinamica, la Commissione intende agire con un Digital networks act.
La decarbonizzazione: tra ambizione e competitività
Il secondo pilastro è la decarbonizzazione. Stando ancora al report di Draghi, quando le politiche di decarbonizzazione sono integrate con quelle industriali possono rappresentare un volano per la crescita dell’Europa. In particolare, in un contesto come quello odierno, con gli Stati Uniti di Trump in pieno negazionismo climatico, l’Europa potrebbe raggiungere un vantaggio competitivo. Per questo la Commissione è intenzionata a intervenire con un Clean Industrial Act che inserisca nel processo di produzione delle pratiche di innovazione verde e nuovi modelli di business circolari. Per raggiungere un’economia votata a una produzione pulita e a modelli circolari, è necessario intervenire sia sul lato della domanda sia su quello dell’offerta. Per quanto riguarda la domanda, si interverrà sugli appalti pubblici e sulle informazioni fornite ai consumatori.
Ma sono le politiche sul lato dell’offerta a richiedere il vero e proprio cambio di prospettiva. Per farlo, suggerisce la Commissione, è necessario che i sistemi fiscali dei vari membri dell’Unione forniscano maggiori incentivi per gli investimenti per la decarbonizzazione. Particolare attenzione meritano quei settori definiti “hard to abate”. Questi settori contribuiscono di più alle emissioni, ma allo stesso tempo sono vitali per la struttura economica europea. Tra questi si possono citare quelli sull’acciaio, sul metallo e chimici.
Se queste sono misure sul lungo periodo, l’enfasi è posta anche sul prezzo che stanno pagando oggi le aziende europee per la volatilità dei costi dell’energia, che sono sensibilmente più elevati rispetto agli altri paesi. Ciò rappresenta un ostacolo enorme per la competitività delle aziende europee rispetto alle controparti. Per questo la Commissione proporrà un Affordable energy action plan, i cui dettagli non sono ancora noti ma che dovrebbe essere presentato verso la fine del mese.
Un capitolo a parte è l’industria automobilistica. Si tratta di un campo di battaglia politico che ha a lungo interessato il dibattito europeo, con differenti interessi da parte della Germania e della Francia, soprattutto per quel che riguarda i rapporti con la Cina. Il mantra della Commissione è permettere qualche flessibilità alle regole per mantenere la competitività del settore, senza tuttavia ridurre l’impegno per la transizione ecologica. In particolare, la Commissione ha posto l’accento sul tema della neutralità tecnologica per quel che riguarda la direzione dell’innovazione. Ma, soprattutto, si è detta più aperta sul tema degli e-fuel, i carburanti sintetici prodotti senza l’utilizzo del petrolio.
La sicurezza economica (e non solo) in un mondo che cambia
Il terzo e ultimo pilastro è la sicurezza, intesa in senso ampio. In un contesto geopolitico differente rispetto all’armonia degli anni Novanta e Zero, l’Europa deve ripensare alla sua autonomia. Nell’incertezza e nell’instabilità odierna, infatti, le imprese non sono disposte a investire, considerando le elevate perdite derivanti da problemi alla catena di approvvigionamento o da competizione sleale.
Per questo la sicurezza e la resilienza del sistema economico devono diventare parte della strategia europea per aumentare la propria competitività. Ovviamente su questo aspetto c’è un sottile equilibrio che è necessario mantenere. Se è vero che le incertezze minano la competitività europea, allo stesso tempo i rapporti commerciali stretti dall’Europa rappresentano un'importante fetta di mercato.
Un aspetto di particolare importanza riguarda la diversificazione dei fornitori, soprattutto per beni cruciali per l’economia europea come materiali critici e semi-conduttori, ma anche i principi attivi di certi medicinali. In un network globale, infatti, per aumentare la resilienza agli shock è necessario un certo grado di ridondanza, cioè avere più opzioni da percorrere, come sottolinea la ricerca sia sui network di trasporto sia sulla diffusione di epidemie. Altrettanto importante è investire per rendere efficiente l’utilizzo di questi beni, vista la carenza.
Sull’aspetto invece della competizione sleale, l’Europa ritiene che sia il settore pubblico a dover svolgere un ruolo cruciale. Tra le proposte c’è quella di una preferenza per produttori/erogatori europei nel campo degli appalti pubblici in settori strategici, un campo rappresenta il 14% del PIL europeo.
Per quel che riguarda la sicurezza militare, la Commissione Europea ha annunciato un white paper sulla difesa comune, sottolineando le difficoltà riscontrate nel mancato coordinamento dei membri europei. Altri due capitoli citati, anche se non particolarmente approfonditi, riguardano la sicurezza informatica e la resilienza davanti agli eventi estremi.
Gli abilitatori orizzontali: dalla burocrazia al lavoro
Oltre ai tre pilastri che abbiamo visto, la Commissione ha evidenziato cinque ambiti su cui intende intervenire al fine di sostenere la competitività in tutti i settori.
Il primo riguarda la regolamentazione. La stringente regolamentazione europea è vista come un ostacolo all’innovazione, secondo alcuni osservatori. Anche la Banca Europea degli Investimenti ha sottolineato come la regolamentazione in Europa sia un fardello per gli investimenti a lungo termine di due terzi delle imprese. Nel documento la Commissione riconosce questo problema, promettendo una semplificazione drastica e senza precedenti: a partire dal prossimo mese proporrà una serie di pacchetti per raggiungere questo obiettivo. Il primo andrà in particolare a diminuire i costi amministrativi per le piccole e medie imprese, introducendo inoltre una categoria ulteriore tra le Piccole e Medie Imprese (SMEs) e le Grandi, che beneficerà di questa sforbiciata alla regolamentazione nelle intenzioni della Commissione.
Il secondo riguarda invece il mercato unico. Il report di Draghi, così come quello di Letta, avevano individuato proprio nella frammentazione del mercato europeo uno dei motivi della bassa crescita delle imprese. Queste infatti si ritrovano a dover affrontare, in realtà, vari tipi di mercato in base al paese, inibendo così la crescita e non potendo puntare su un’economia di scala.
Il terzo abilitatore, strettamente collegato, riguarda il mercato dei capitali. Nel documento la Commissione propone di riformare la Savings and Investments Union, strumento mirato a creare un vero mercato unico per il finanziamento all'interno dell'UE, eliminando le barriere nazionali interne. Questo dovrebbe fornire proprio quel capitale rischioso di cui necessitano le aziende innovative per poter crescere.
Il quarto abilitatore riguarda invece le politiche sociali e il lavoro. Nel documento la Commissione evidenzia la buona performance del mercato del lavoro europeo in questa congiuntura economica, sottolineando però le difficoltà delle piccole e medie imprese a reperire lavoratori con determinate capacità (il cosiddetto skill mismatch). La Commissione intende agire sulla diffusione delle conoscenze tra la popolazione residente, con piani appositi per l’istruzione STEM e il lifelong learning. Un altro ambito di intervento sono quei talenti fuori dal mercato del lavoro. Ci sono infatti delle barriere per quel che riguarda la partecipazione al lavoro da parte di donne e giovani, così come per le persone con disabilità. Ma anche una maggior attrattiva dell’Europa per talenti all’estero. Allo stesso tempo, si pone l’accento sulle trasformazione del mercato del lavoro, invitando i paesi membri a modernizzare il proprio sistema di protezione sociale.
L’ultimo ambito, infine, è il coordinamento tra politiche europee e dei singoli Stati.
Tra buone idee, aspetti problematici e l'incognita Trump
Per commentare il documento della Commissione non si può prescindere dalla sua natura programmatica. Al suo interno non sono rintracciabili i dettagli delle policy che verranno proposte per arginare il problema. Perciò non si può discutere dell’applicazione, ma soltanto delle idee contenute.
Da questo punto di vista molti aspetti sollevati dalla Commissione sono condivisibili. In particolare, il primo pilastro su un’innovazione che arranca in Europa e che ha bisogno di un sostegno in un ecosistema tra pubblico e privato rappresenta una corretta diagnosi del problema che affligge il vecchio continente.
Ovviamente, nelle politiche sull’innovazione, a livello più granulare, sarà fondamentale come verranno gestiti- e abbandonati- i singoli progetti. Il modello è quello americano delle agenzie e dei progetti a missione, come abbiamo detto. Ma il problema di un nuovo capitalismo di Stato non è economico, quanto politico: pensiamo a un progetto che non ha prospettive, ma che resterà in piedi solamente grazie alla collusione tra la politica e il potere economico. Bisognerà quindi attendere i dettagli della strategia messa in atto dalla Commissione, assieme a come reagirà il settore privato, per poter fare una valutazione più completa.
Strettamente collegato c’è il secondo pilastro, quello sulla transizione ecologica. La ricerca scientifica ha evidenziato come le politiche che intervengono sulla quantità rispetto ai prezzi possano essere la strategia vincente per la transizione ecologica. Sembra quindi positivo che la Commissione spinga l’acceleratore su questo. Ma a preoccupare è come verrà raggiunto quel fragile equilibrio tra la competitività del sistema e gli obiettivi climatici. Nel documento si chiarisce che la Commissione non intende fare marcia indietro sugli ambiziosi piani per la transizione: sarà quindi necessario monitorare se gli interventi saranno un’armonizzazione tra questi due obiettivi o se, davanti alle pressioni del mondo dell’industria, la Commissione Europea arretrerà sul fronte della lotta alla crisi climatica. Le prime indiscrezioni rivelate dal Der Spiegel indicano come l’Europa stia considerando di lasciare sul mercato le auto ibride plug-in anche dopo il 2035, sotto le pressioni dell’industria di settore.
Come già nel caso del report di Draghi, uno dei capitoli più deboli del documento della Commissione riguarda quello dei lavoratori. Ciò che distingue ancora oggi l’Europa dagli altri paesi del mondo è proprio la sua rete di protezione e condizioni di lavoro migliori. La retorica secondo cui queste caratteristiche sarebbero state un ostacolo alla crescita è stata ormai smentita. Eppure, oltre alle solite frasi di circostanza, il documento della Commissione presenta anche un aspetto problematico: quello legato al "28esimo regime". Secondo la European Trade Union Confederation (ETUC) permetterebbe alle aziende di porsi al di fuori della normativa del paese riguardo le condizioni del lavoro a discapito proprio dei lavoratori. Questo potrebbe poi avere degli effetti più ampi, portando a un indebolimento delle tutele su larga scala per poter competere.
Un ulteriore fronte di criticità riguarda la normativa sull’Intelligenza Artificiale. La Commissione vede nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel settore privato e nella pubblica amministrazione un volano per la competitività del sistema. L’IA può svolgere questo ruolo, abbattendo i tempi e i costi, tuttavia bisogna mettere in conto anche le ricadute occupazionali. Uno dei filoni di ricerca sull’AI riguarda proprio l’atteggiamento delle aziende nei confronti delle innovazioni che spesso vengono adottate senza tener in considerazione il loro impatto complessivo. Il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu le ha catalogate come “tecnologie così-così”. È quindi necessario procedere con cautela su questo fronte perché i benefici sulla produzione dell’AI potrebbero non rivelarsi così salvifici come si pensa.
Bisogna poi mettere in conto gli usi impropri di queste tecnologie a scapito di consumatori e lavoratori. Già oggi strumenti di AI sono utilizzati per la sorveglianza dei lavoratori, spesso per costringere a condizioni di lavoro logoranti. Sarà quindi di fondamentale importanza comprendere in che direzione andrà la normativa che l’Europa vuole indebolire.
Gli aspetti problematici però non sono solo all’interno del documento, ma anche in quel nuovo mondo in cui si trova a navigare l’Europa. In particolare, c’è da chiedersi se l’approccio delineato dalla Commissione sia compatibile con il nuovo corso intrapreso dagli Stati Uniti con l’Amministrazione Trump. La guerra commerciale minacciata da Trump potrebbe richiedere proposte molto più aggressive rispetto a quelle attuali, in quanto le relazioni su cui fa leva la commissione potrebbero svanire. Questo ci riporta, ancora una volta, alla questione della domanda interna. Se le esportazioni nei confronti degli Stati Uniti dovessero via via calare a causa della guerra commerciale, una parte di questi beni verranno dirottati negli altri paesi, ma allo stesso tempo sarà necessario rinforzare la domanda aggregata europea per essere più resilienti.
In conclusione, il documento della Commissione contiene sicuramente una diagnosi e delle soluzioni che, almeno sulla carta, possono garantire la sopravvivenza dell’Europa in un mondo più competitivo e meno conciliante rispetto al passato. È corretta anche l’enfasi sul rilanciare l’innovazione nel vecchio continente, come già sottolineato dal Report Draghi. Ma all’interno del documento si trovano anche passaggi più preoccupanti, che andrebbero a beneficio soltanto delle aziende lasciando indietro lavoratori e cittadini. Per questo motivo, se gli sforzi sono condivisibili, allo stesso tempo sarà urgente il lavoro di esperti e giornalisti nel monitorare i prossimi passi della Commissione.
(Immagine anteprima via Flickr)