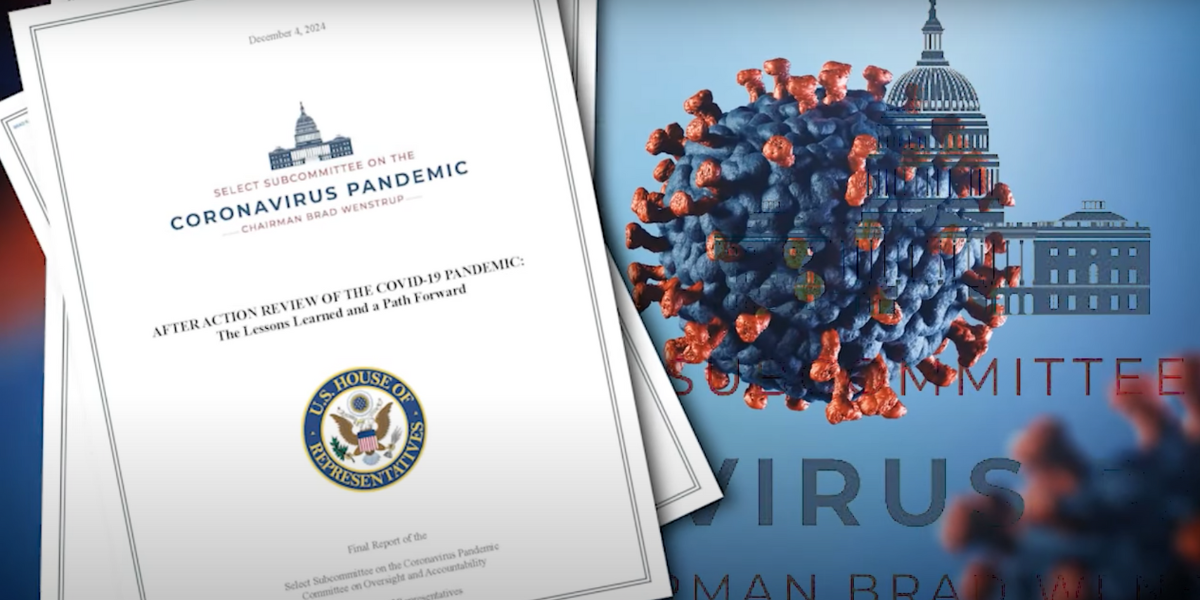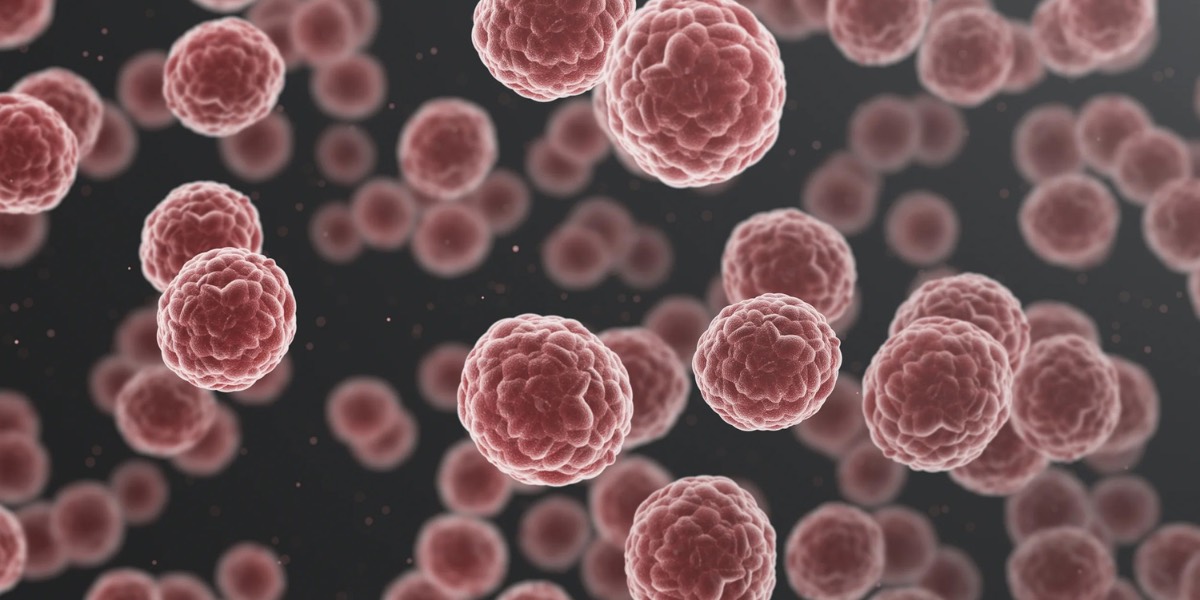COVID-19 ed emergenza nelle carceri: “Come abbiamo paura noi fuori, hanno ancora più paura loro dentro”
11 min letturaTra il 7 e il 9 marzo, mentre l’epidemia di COVID-19 si diffondeva sempre di più in Italia e il governo si preparava al lockdown generale del paese, in più di venti carceri sono scoppiate sommosse e proteste, in alcune strutture particolarmente violente. Il bilancio è stato di 14 detenuti morti – secondo le autorità ufficialmente tutti per overdose, ma alle associazioni sono arrivate segnalazioni di violenze che saranno approfondite – e decine di feriti, tra cui alcuni anche tra gli agenti della polizia penitenziaria. A scatenare le tensioni, in larga parte, sono state la paura per il contagio a causa degli spazi ristretti e promiscui e la rabbia per le misure prese dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria per contenere il virus, tra cui la sospensione dei colloqui fisici con i familiari, dei permessi premio e del regime di semilibertà. «Un senso di esasperazione dovuta a molte cose: all’isolamento, alla poca informazione e al terrore della distanza dai propri cari», aveva spiegato poco dopo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell’associazione Antigone. «Come abbiamo paura noi fuori, hanno ancora più paura loro dentro».
Già diversi giorni prima organizzazioni per i diritti umani ed esperti denunciavano la necessità per il governo di occuparsi dei rischi dell’emergenza sanitaria nelle carceri, tutelando il contatto con l’esterno attraverso un incremento di telefonate e video chiamate (cosa che poi è stata concessa) e riducendo la pressione sugli istituti penitenziari, dove il problema del persistente sovraffollamento rende difficile distanziamento sociale ed eventuale isolamento di eventuali contagi.
Raccomandazioni che, insieme alla necessità di fornire una corretta e puntuale informazione ai detenuti, ricalcano quelle dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Alcune norme per alleggerire le presenze negli istituti di pena sono contenute nel decreto “Cura Italia” del 17 marzo. Misure ritenute però troppo timide e insufficienti per lo scopo che si erano prefissate da associazioni, giuristi e dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Le preoccupazioni e le paure dei detenuti
Le associazioni e gli operatori raccontano che la tensione all’interno degli istituti di pena resta alta. «A causa delle misure di distanziamento sociale, noi volontari siamo fuori dal carcere, non entriamo. Ma sono in contatto con cooperative che hanno ancora accesso, ricevo testi e lettere e posso dire che ci sono tensioni e difficoltà, perché i detenuti hanno paura», spiega a Valigia Blu Ornella Favero, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti, rivista dal Due Palazzi di Padova. Chi si trova in carcere ha timore di essere contagiato, e anche di non essere tutelato o informato a sufficienza su quanto sta accadendo. «Essendo il carcere un’istituzione totale – prosegue Favero - c’è diffidenza sulle notizie ufficiali sul numero dei contagi, e ogni giorno si teme che la situazione sia molto diversa, peggiore da quella che viene prospettata».
La questione della trasparenza emerge anche dalle decine di lettere che dall’8 marzo l’associazione Antigone riceve da parte di familiari di detenuti preoccupati per i loro cari. «Si chiedono chi sta davvero male, cosa succede. Ci sono mogli che scrivono, ad esempio, di aver sentito dal proprio marito detenuto che il vicino di cella è stato portato via con la febbre altissima ma che nessuno ha dato loro informazioni. È chiaro che monta la preoccupazione, è comprensibile», afferma Michele Miravalle, coordinatore nazionale dell'osservatorio sulle carceri per Antigone.
I numeri dei contagi in carcere per il momento sono contenuti: tra i reclusi ci sono poco più di 50 positivi, mentre sono oltre cento i poliziotti penitenziari. Cifre fornite dal Garante ma comunque relative, perché risentono del numero di tamponi effettuato, esattamente come accade nel mondo fuori dalle celle.
«Questa situazione di incertezza dei numeri – aggiunge Miravalle – provoca smarrimento soprattutto all’interno delle carceri dove si sa che ci sono positivi. I detenuti trasmettono la preoccupazione all’esterno tra l’altro non in incontri diretti, più rassicuranti, ma per forza di cose attraverso telefonate o video chiamate».
Una seconda questione riguarda gli strumenti di protezione individuale, come guanti in lattice, mascherine. «E questo è un problema che riguarda sia i detenuti che gli agenti, perché tolte un po’ di tende per il pre-triage messe davanti alle carceri ci sono situazioni in cui c’è una totale mancanza di tutto: sto parlando di tazzine da caffè con dentro igienizzante consegnate a ogni cella per sanificare l’ambiente. Ovviamente è una situazione a macchia di leopardo, ma non si sta tutelando la salute delle persone detenute e di quelle che lavorano in carcere».
Nei giorni scorsi diversi sindacati di polizia si sono lamentati della carenza di dispositivi di protezione individuale adeguati. Secondo Miravalle, da questo punto di vista «molte carenze sono frutto anche di questo intreccio di competenze tra amministrazione penitenziaria, Protezione civile, Regioni. Il risultato è che poi le principali forniture di Dpi sono frutto di donazioni individuali o di fondazioni, enti benefici. Sul piano organizzativo c’è poco o nulla».
Le misure non sono sufficienti
Alla fine di febbraio, il numero dei reclusi nelle carceri italiane era di 61.230, a fonte di 50.931 posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 120% non omogeneo in tutto il paese, con punte del 140% in regioni come la Lombardia. Una situazione in cui qualsiasi distanziamento sociale risulta impensabile.
«Sovraffollamento significa non avere spazio vitale, significa per esempio condividere in 3-4 persone 10 mq e un unico bagno in comune, dormire su un letto al terzo piano di un letto a castello, oppure condividere una doccia in 50, 100 persone. E comunque essere considerati numeri e non persone perché è difficile che gli operatori, pochi, riescano ad intercettare i bisogni, la disperazione delle persone recluse. Per questo bisogna fare subito», ha detto in una diretta Facebook il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.
Prisons and #COVID19: “Authorities should strive to resort to alternatives to deprivation of liberty, in particular in situations of overcrowding,” says @coe Secretary General Marija Pejčinović Burić.
Latest country-by-country overcrowding data https://t.co/n3TaWrWktZ #SPACE2019 pic.twitter.com/b9dJgh3fPC
— Council of Europe (@coe) April 7, 2020
Il decreto “Cura Italia” prevede la detenzione domiciliare per chi debba scontare una pena o un residuo di pena fino a 18 mesi. Se però il residuo di pena è superiore a 6 mesi è previsto il braccialetto elettronico. Come spiega un approfondimento dell’associazione Antigone, con questo articolo, il 123, non si è fatto altro che derogare “in senso cautamente estensivo” i limiti della legge 199 del 2010, la cosiddetta “Svuota carceri”, che prevedeva la regola del 18 mesi non consentendo però a tutti l’accesso a questa misura alternativa. La nuova norma rimuove alcune di quelle preclusioni e ne aggiunge altre fino al 30 giugno 2020.
L’articolo 124, invece, riguarda permessi premio per i detenuti in semilibertà, che possono essere concessi senza limiti fino al 30 giugno 2020. “Lo scopo è fare in modo che chi di giorno esce dal carcere in semilibertà per lavorare non ci debba tornare la sera, con i rischi di contagio che la cosa comporta, e possa invece, restare la sera a casa fino al 30 giugno”, scrive Antigone.
Le misure sono state criticate e ritenute inefficaci da garanti dei detenuti, organizzazioni, esperti. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha detto che a beneficiare del provvedimento potrebbero essere circa 6mila detenuti. Un numero già di per sé insufficiente secondo le organizzazioni per un reale decongestionamento.
In ogni caso, la platea è molto ristretta anche da altri fattori. La misura alternativa può essere data solo se si ha un domicilio idoneo. Secondo Miravalle, guardando la popolazione carceraria attuale, «sopratutto nelle grandi carceri metropolitane del nord che sono più in sofferenza adesso – Milano, Torino, Bologna – molte persone un posto dove andare non ce l’hanno: sono senza fissa dimora, vivevano per strada, hanno famiglie che non li possono ospitare e così via. Quindi se già quella misura si rivolge ai pochi che possono accedere, a quei pochi devi addirittura togliere questo gruppo consistente di persone che chiedono al giudice di mandarli a casa ma una casa non ce l’hanno». L’associazione sta facendo pressione sui comuni perché possano dare un domicilio a queste persone e superare questa «misura fortemente discriminatoria».
In secondo luogo, c’è la questione braccialetti: secondo il provvedimento attuativo del decreto, i dispositivi sono 5mila, dei quali 920 già disponibili. Come sottolineato dal Consiglio Superiore della Magistratura, la misura ne esce “fortemente depotenziata dalla indisponibilità degli strumenti di controllo elettronici, la cui carenza, non da oggi, costituisce una delle maggiori criticità del nostro sistema”. Il provvedimento prevede l’installazione di massimo 300 apparecchi a settimana. Con questi numeri, secondo Gonnella, «gli ultimi detenuti usciranno dal carcere infatti tra oltre tre mesi, quando ci auguriamo la fase acuta legata al diffondersi del COVID-19 sarà già ampiamente alle spalle».
La parte del Cura Italia dedicata al carcere «paradossalmente tradisce un po’ il motivo per cui è stata scritta: affrontare l’emergenza sanitaria. Invece si continua a perseguire una linea securitaria, giustizialista, e non si pone al centro la salute dei detenuti e delle persone che in carcere lavorano», commenta Miravalle. «Molte persone, magari malate o anziane chiederanno l’accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, questa gli viene negata, e monteranno rabbia e preoccupazione». Secondo i dati raccolti da Antigone, il 67% dei detenuti ha almeno una patologia sanitaria. Di questi l′11,5% era affetto da malattie infettive e parassitarie, l′11,4% da malattie del sistema cardio-circolatorio, il 5,4% da malattie dell’apparato respiratorio. Inoltre, il 62% dei reclusi ha 40 anni o più e al 31 dicembre 2019 5.221 persone avevano più di 60 anni.
Il 2 aprile si è registrato il primo detenuto morto per COVID-19: un uomo di 77anni, recluso nel carcere della Dozza di Bologna e ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Sant’Orsola dopo essere risultato positivo. Un avvenimento che ha confermato i timori di molti, tra cui anche molti agenti penitenziari. Un altro detenuto è morto ieri: era ristretto nel carcere di Voghera, da circa una settimana era stato portato in un ospedale di Milano.
In una lettera agli Stati membri, la commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, ha scritto che “ridurre la popolazione carceraria in tutta Europa è indispensabile per garantire effettiva messa in atto delle regolamentazioni sanitarie, per diminuire le crescenti pressioni sul personale penitenziario e sul sistema carcerario nel suo insieme”. Per questo motivo, Mijatovic ha chiesto a tutti i paesi “di utilizzare tutte le misure alternative alla detenzione in tutti i casi possibili e senza discriminazioni”, specialmente dove sussistono situazioni di sovraffollamento.
https://twitter.com/CommissionerHR/status/1247083713525174273?s=20
Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti ha fatto sapere che al 9 aprile il numero di persone nelle carceri italiane era sceso di alcune migliaia, arrivando a 55.939. Troppo poco e troppo lentamente per i tempi dell’emergenza COVID-19. Nonostante il calo, il tasso resta superiore al 100% che gli organi di monitoraggio dei sistemi penitenziari internazionali raccomandano che di non raggiungere. “Ne consegue – si legge in un comunicato del Garante - che nonostante qualche passo fatto da non svalutare, occorre intervenire in maniera significativa tenendo presente entrambe le dimensioni che l’intervento deve avere: la dimensione della consistenza numerica perché l’affollamento non abbia a superare il 98% della disponibilità; la dimensione della rapidità perché gli interventi di decongestione producano effetti con un ritmo comparabile con quello inquietante e accelerato di ogni diffusione epidemica”.
Il Procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi ha esortato tutti i procuratori della Corte d’Appello a ridurre a ridurre la pressione sulle carceri in questo momento di emergenza sanitaria: “Mai come in questo periodo va ricordato che nel nostro sistema il carcere costituisce l’extrema ratio. Occorre dunque incentivare la decisione di misure alternative idonee ad alleggerire la pressione dalle presenze non necessarie in carcere: ciò limitatamente ai delitti che fuoriescono dal perimetro predittivo di pericolosità e con l’ulteriore eccezione legata ai reati di ‘codice rosso’”.
Secondo il Garante e le associazioni ci sono ancora almeno 10mila persone – tra cui malati e persone a rischio – che dovrebbero essere mandate a casa per poter raggiungere una situazione di reale tutela della salute, e per questo hanno chiesto misure più incisive. Oltre 15mila detenuti hanno un residuo di pena inferiore a due anni e, afferma il Garante, “per il nostro ordinamento avrebbero potuto accedere già da tempo a misure alternative. Parallelamente, 17.468 persone sono anch’esse in carcere senza alcuna sentenza definitiva (di questi 8.854 sono ancora in attesa del primo grado di giudizio)”. E ci sono anche ancora madri detenute insieme ai figli minori. Sono numeri, scrive il Garante, “che diamo per indicare non che tutti quanti potrebbero in ipotesi non essere più dietro alle sbarre, ma che i settori su cui intervenire, discrezionalmente ma consistentemente, sono ampi. E che i nuovi passi normativi da assumere hanno ampio spazio per poter essere significativi”.
Il rischio di un carcere sempre più isolato
Un’ultima questione riguarda la vita dei detenuti, che in tempi di distanziamento sociale rischia di essere più isolata che mai. Secondo Ornella Favero, è positivo e importante che i detenuti possano vedere – anche se solo in video – i loro cari: «Era quello che si doveva fare prima di quello che è successo [le rivolte del 7 marzo ndr]. Come si è fatto a non pensare che se si dice ai detenuti che non vedono i loro familiari e non si sa per quanto tempo non scoppia il putiferio? È inevitabile. Probabilmente qualcosa sarebbe andato diversamente».
Anche per Miravalle di Antigone l’ingresso della tecnologia «è sicuramente un passo avanti. L’abbiamo chiesto per anni, non capivamo perché dovesse rimanere un tabù. In dieci giorni la questione si è risolta e si è anche dimostrato che far entrare Skype in carcere non porta chissà che problemi di sicurezza. Siamo fiduciosi che sarà difficile tornare indietro su questo».
Oltre alle video chiamate, per la prima volta sono state anche autorizzate le lezioni online per gli studenti universitari. «Una rivoluzione per il carcere, pensa che prima chi era iscritto e pagava le tasse non poteva comunque accedere alle tante risorse messe online dagli atenei».
Hanno più difficoltà a partire la didattica a distanza per i detenuti che seguono corsi scolastici – oggi bloccati nelle carceri perché l’ingresso agli insegnanti è interdetto. Pochi giorni fa il Garante dei detenuti ha scritto una lettera al Ministero dell’Istruzione sottolineando come solo in pochissimi istituti fossero partire le lezioni in video conferenza. In quasi metà delle carceri gli studenti avevano ricevuto solo materiale cartaceo, mentre un’altra gran parte non “era riuscita ad assicurare nemmeno questa minima possibilità”.
Favero conferma che in diversi istituti non è ancora iniziata la didattica online. «Il carcere ha il sacro terrore della tecnologia. Io spero solo che con questo disastro capiscano che le tecnologie come sono entrate non debbano più uscire, devono restare parte integrante. Anche perché le persone che non sanno nulla, sono state tenute fuori da Internet e da tutti questi strumenti, quando escono dal carcere sono dei ‘senzatetto digitali’, dei disadattati nel mondo di oggi. Per cui spero almeno che questa cosa dell’introduzione delle tecnologie resti come momento determinante della vita in carcere».
Così come gli insegnanti, anche molti altri operatori e volontari non possono più entrare in carcere per motivi sanitari. E gran parte delle attività, anche quelle lavorative, sono ferme. Favero sottolinea come in questo momento «non sia rimasto quasi niente in piedi. Ci sono poche attività lavorative che continuano con le cooperative, ma sono eccezioni. Avevamo chiesto come volontariato una sorta di unità di crisi sulle carceri su questi aspetti, dobbiamo essere coinvolti. L’abbiamo fatta una volta al carcere di Padova, altrove non si è fatto. Le carceri senza il volontariato, senza la scuola, senza le attività sono il deserto». Dopo la chiusura generale, un detenuto tossicodipendente che partecipa alla redazione della rivista Ristretti Orizzonti qualche giorno fa le ha mandato un messaggio: “Qui tutto si è fermato, nemmeno gli agenti sanno come si svolgeranno le giornate d’ora in poi, quindi sale dentro di me un senso di angoscia, ansia, depressione, tristezza e smarrimento perché siamo in balia di eventi su cui non abbiamo il minimo controllo e questo peggiora tutto”.
L’aumento dell’isolamento e della chiusura del carcere è un elemento che desta preoccupazione nelle associazioni. «Le attività sono sospese, nessuno entra in carcere al di fuori di polizia penitenziaria, in alcune strutture nemmeno gli educatori. E nelle sezioni in questo momento si è fatto un enorme passo indietro su quella che era la sorveglianza dinamica, le celle aperte», spiega Miravalle, che ritiene che oggi il 95% delle sezioni carcerarie sia tornata a essere chiusa: «22 ore in cella, senza fare nulla, 2 ore d’aria». La situazione è ovviamente frutto dell’emergenza sanitaria, ma di un carcere più chiuso anche in futuro è presente. «Anche noi come osservatorio di Antigone non possiamo fare visite in questo momento, come tutti gli esterni siamo bloccati. Per adesso la società civile non può entrare. Torneremo a farlo, ma non sappiamo quando e se ci saranno restrizioni. Bisognerà pensare anche a questo, al dopo. Oggi però l’urgenza è evitare che le carceri si trasformino in bombe sanitarie, perché il rischio c’è ed è enorme».
Foto in anteprima via Ansa