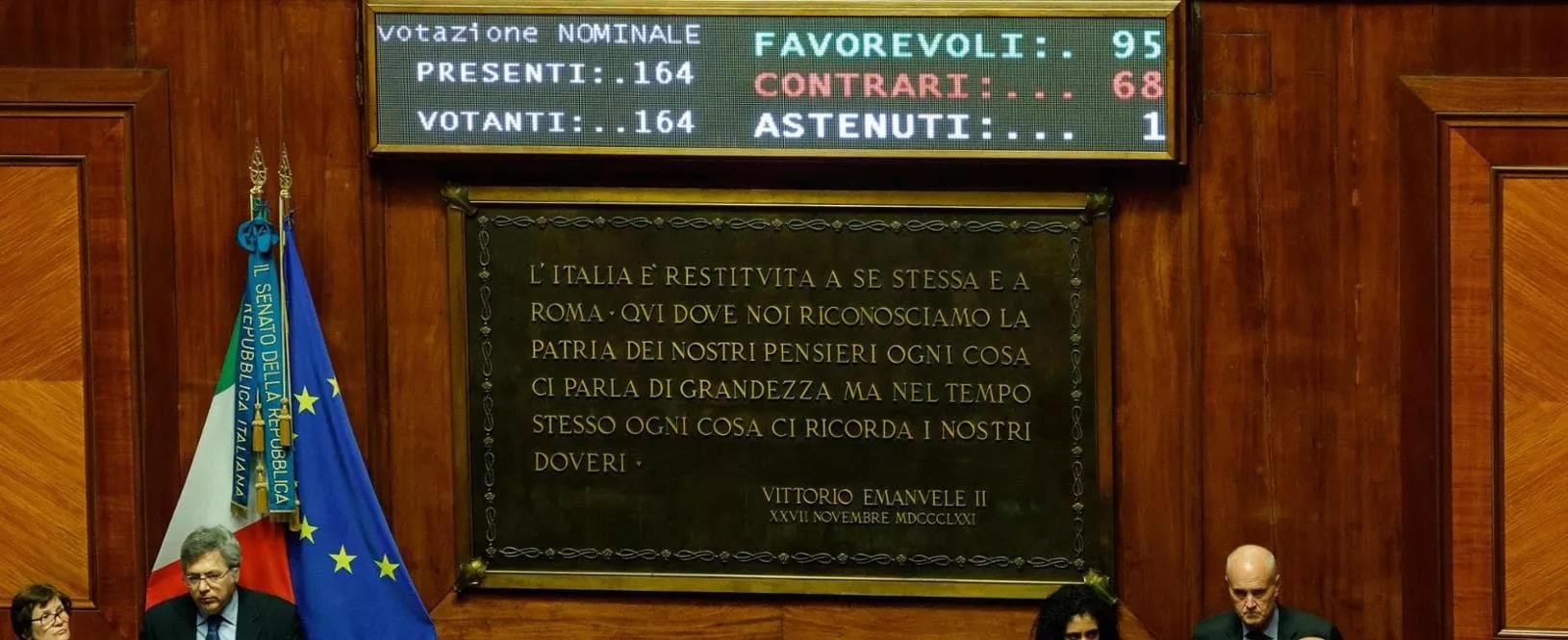In Italia le donne sono davvero libere di abortire? È tempo di rivedere la legge e questa volta andare fino in fondo
11 min letturaDa 43 anni, dalla legalizzazione dell’interruzione volontaria della gravidanza, va avanti e viene alimentato un dibattito che non si è mai chiuso, si è evoluto solo in parte, non abbastanza. I movimenti Pro-Choice denunciano carenze e difficoltà nell’accesso ai servizi di interruzioni di gravidanza e gravi mancanze nell’applicazione della legge 194/78. Alcune questioni problematiche vengono portate all’attenzione dell’opinione pubblica più di altre, da anni: l’obiezione di coscienza come causa delle carenze strutturali di personale medico oppure i tempi troppo lunghi e farraginosi di accesso ai servizi.
A che punto siamo oggi? Quali sono le possibilità, le modalità e gli spazi di autonomia per interrompere una gravidanza? E, soprattutto, la definizione di interruzione volontaria della gravidanza dentro le maglie della legge 194, quali prospettive di esercizio del diritto di libera scelta offre alle donne?
Le interruzioni volontarie di gravidanza in Italia, il progetto di ricerca “Mai dati” e la campagna “Libera di abortire”
In Italia, come è noto il diritto della donna ad abortire è tutelato dalla legge 194 del 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”.
Con periodicità annuale il Ministero della Salute è tenuto a presentare al Parlamento la Relazione sull’attuazione della legge al fine di restituire un quadro della situazione italiana relativa all’interruzione della gravidanza. L’ultima relazione, presentata il 30 luglio 2021 e pubblicata sul sito del Ministero il 16 settembre, riporta i dati definitivi relativi all’anno 2019 e quelli provvisori relativi all’anno 2020.
La lettura della Relazione fornisce informazioni e suscita alcune domande.
- La relazione conferma la tendenza alla riduzione del numero di interruzioni di gravidanza rispetto agli anni precedenti; l’Italia è infatti tra i paesi con più bassi tassi di abortività in Europa. Nel 2019 sono state notificate 73207 interruzioni volontarie della gravidanza.
- Per quanto riguarda l’obiezione di coscienza viene riportata una lieve riduzione della percentuale dei ginecologi obiettori, che nel 2019 erano il 67% del totale, a fronte del 69% nel 2018. Tuttavia, si evidenzia una enorme difformità tra le varie regioni.
- Da un punto di vista delle metodologie, per quanto riguarda le interruzioni di gravidanza entro i primi 90 giorni, la relazione conferma la preponderanza dell’utilizzo del metodo chirurgico (l’intervento viene eseguito tramite isterosuzione, eseguito in anestesia locale o generale, dopo aver dilatato il collo dell’utero, il contenuto viene aspirato con una cannula oppure tramite raschiamento) rispetto a quello farmacologico. L’aborto farmacologico è permesso entro la nona settimana di gestazione (ossia 63 giorni) e si effettua attraverso la somministrazione, a distanza di 48 ore, di due farmaci. La prima somministrazione è di mifepristone (noto come RU486), la seconda somministrazione di misoprostolo (Cytotec). Nel 2019 il metodo farmacologico è stato adottato nel 24,9% del totale delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG). Questo dato conferma l’Italia tra i paesi con minor utilizzo di questa tecnica. Nel 2019, nel Regno Unito, il 73% degli aborti era di tipo farmacologico. In Francia, il 70%. Su tutto il territorio nazionale, le strutture mediche in cui è possibile accedere a questa procedura sono una minoranza, con grandi differenze tra le regioni del Sud e quelle del Centro-Nord. Le ragioni di questa arretratezza sono storiche, l'aborto farmacologico è stato legalizzato in Italia solo nel 2009, con grande ritardo rispetto ad altri paesi europei (in Francia era già in utilizzo nel 1988 e nel Regno Unito nel 1990) e con linee guida ministeriali che hanno definito protocolli clinici diversi e più restrittivi rispetto a quelli indicati nelle linee guida internazionali. Si poteva accedere all’aborto farmacologico fino alla settima settimana di gestazione ed esclusivamente in regime ospedaliero obbligando le donne ad un ricovero di 3 giorni. A seguito della fase emergenziale legata alla pandemia Covid-19, ad agosto del 2020 le linee ministeriali sono state modificate. Oggi, è permesso accedere a questa tecnica fino alle 9 settimane e in regime ambulatoriale senza alcun obbligo di ricovero. La recente modifica delle linee guida non è però ancora stata recepita dalla maggior parte delle regioni, tranne che nel caso del Lazio e della Toscana. Il dibattito alimentato durante il lockdown del 2020 ha riguardato soprattutto la possibilità di facilitare l’accesso all’aborto farmacologico. L’emergenza sanitaria ha contribuito ad ampliare le disuguaglianze tra le varie aree del paese, tanto che “In alcuni casi è stata indicata dalle Regioni l’autonoma decisione di alcune strutture di riduzione del numero di interventi settimanali (in 4 Regioni), di sospensione delle procedure di interruzione volontaria di gravidanza farmacologica (4 Regioni) e di quella chirurgica (2 Regioni)” (Relazione del Ministero, p. 15).
- Rispetto alla clandestinità abortiva, le stime del Ministero, perché di stime si tratta, parlano di un numero compreso tra i 10mila e i 13mila e di un fenomeno stabile nel tempo.
In questo panorama, alcune iniziative sono attive su fronti diversi con l’obiettivo di porre l’attenzione sulle criticità del sistema italiano e facilitare un reale accesso all’interruzione della gravidanza, tra queste la campagna “Libera di abortire” e il più recente progetto di ricerca “Mai dati”.
In occasione dell’ultimo convegno dell’Associazione Luca Coscioni, Chiara Lalli e Sonia Montegiove hanno presentato il progetto di ricerca “Mai Dati” di cui sono responsabili. Il progetto riguarda proprio l’analisi dei dati che vengono forniti dal Ministero e pone in discussione il valore che questi dati possono avere.
L’attenzione dell’analisi si focalizza sul tema dell’obiezione di coscienza. L’urgenza è quella di raccogliere informazioni valide e, attraverso la richiesta di accesso ai dati delle singole strutture ospedaliere, chiede di conoscere il numero esatto del personale disponibile a fornire il servizio medico dell’interruzione della gravidanza. Si chiedono dati aperti, intelligibili, accessibili che permettano di restituire una fotografia meno sfocata di quella che viene fuori dalla relazione ministeriale. I dati forniti dalla relazione ministeriale sono dati aggregati, nazionali e regionali e non ci dicono in quali strutture è possibile trovare personale che effettua le interruzioni della gravidanza.
“Solo se sono aperti i dati hanno davvero un significato e permettono alle donne di scegliere in quale ospedale andare, sapendo prima qual è la percentuale di obiettori nella struttura scelta. Non tutte possono scegliere perché vivono in una città dove c’è un solo ospedale oppure in una regione dove c’è un unico non obiettore. Un servizio medico non dovrebbe essere applicato in modo tanto diverso e non omogeneo”, hanno dichiarato le autrici dell’indagine in occasione della presentazione dei primi dati raccolti.
L’obiettivo finale del progetto è costruire conoscenza, una mappa consultabile tramite app, utile alle donne per indirizzare le proprie scelte su come, dove e quando abortire. Procedere a una mappatura dei servizi italiani in relazione alla percentuale di personale obiettore di coscienza è stato anche l’obiettivo di altri progetti e di altre campagne. Esistono oggi delle mappe che possono essere consultate online, va ricordato infatti il lavoro svolto in questa direzione dall’associazione Laiga 194 e da Obiezione Respinta.
La conoscenza diventa uno strumento di tutela per le donne dagli abusi perpetrati dal personale medico e sanitario e da tutte le figure professionali che dovrebbero fornire assistenza e troppo spesso forniscono giudizi morali e disservizi tecnici. La direzione verso cui si muovono l’Associazione Luca Coscioni e Amica (Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto) è la proposta di intervenire nella modifica della legge attuale, almeno in alcuni suoi articoli.
Inoltre, il 2 dicembre, anche le associazioni promotrici della campagna datiBeneComune – nata nel novembre 2020 per chiedere al Governo italiano di pubblicare in maniera aperta i dati sulla gestione della pandemia di COVID-19 e fare dei dati e le informazioni raccolti dalla Pubblica Amministrazione un bene comune – hanno avanzato la richiesta al Ministero della Salute di accedere a dati aperti, machine readable e riusabili sull’interruzione volontaria della gravidanza e sull’obiezione di coscienza.
“Libera di abortire” è stata lanciata a Roma il 22 maggio 2021. Come si legge sul sito, si tratta di “una campagna di tutte e di tutti: vogliamo garantire concretamente a ogni persona il libero accesso all’aborto, tramite azioni di informazione pubblica e un appello al Ministero della Salute”.
La campagna è promossa da Radicali italiani e da IVG Ho abortito e sto benissimo, Non è un veleno, UAAR, Giovani Democratici Abruzzo, Giovani Democratici Milano, Creative Fighters, Hello Tomorrow Agency, Training Academy for Changemakers, Ass. Si può fare.
Si articola su tre fronti diversi: l’affissione di manifesti, la firma di un appello al Ministro della Salute, l’accesso ad un vademecum di informazioni.
A fine maggio 2021 sono stati affissi i manifesti in diverse città italiane. Sono i volti di attiviste che presentano le testimonianze di donne che hanno abortito e subito violenze fisiche e/o psicologiche nel percorso di assistenza. Questi manifesti danno visibilità alle esperienze e ai pensieri delle donne, restituiscono quindi dignità al racconto di un’esperienza che troppo spesso in Italia è ancora relegato all’ambito della sfera privata.
Leggi anche >> Parlare di aborto senza colpa e vergogna
Attraverso l’appello indirizzato al ministro della salute Roberto Speranza si chiede di: favorire l'assunzione di nuovi medici non obiettori; incentivare o disincentivare le Regioni in funzione dell’efficienza del servizio di IVG; favorire il ricorso alla telemedicina; fornire informazioni complete sull’aborto; rendere obbligatori sia percorsi di formazione e aggiornamento del personale sanitario sia progetti continuativi di informazione su sessualità e affettività nelle scuole. L’appello va nella direzione di chiedere dei cambiamenti alle istituzioni, una presa in carico politica che porti alla definizione di un reale accesso ad un servizio medico.
Il Vademecum che può essere scaricato in formato pdf dal sito contiene due tipi di informazioni, “cosa puoi fare se decidi di abortire” e “cosa non è lecito subire”, sottolinea la necessità di accesso a informazioni che siano corrette, da un punto di vista giuridico e medico.
L’appello ha raggiunto 33mila firme e i promotori della campagna hanno chiesto un incontro ufficiale al Ministro Speranza. In assenza di una risposta del Ministro, è stato organizzato un presidio il 3 dicembre 2021.
Ma in Italia si è davvero libere di abortire?
L’obiettivo della campagna, come si legge sul sito, è garantire il libero accesso all’aborto ma forse prima dovremmo chiederci se è davvero possibile garantire questo diritto oggi in Italia? Senza sminuire il valore di una campagna necessaria, rimane comunque il dubbio di quali siano gli spazi legittimi per garantire questo tipo di libertà. Che cosa vuol dire essere libere di abortire oggi in Italia e ha senso continuare a rivendicare uno spazio di libertà che in verità in nessun passaggio della legge è riconosciuto? Che cosa dice la legge?
L’articolo 1 della Legge 194 recita:
“Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite”
Lo Stato quindi garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e non all’interruzione volontaria della gravidanza. Lo Stato tutela la vita della donna ma anche la vita umana dal suo inizio, dando per scontato che questo inizio sia nell’utero. La tutela della donna è tutela del suo corpo in quanto corpo gestante, l’utero è ciò che importa tutelare. Il grande compromesso su cui si basa questa legge è esplicitato: deve essere sempre garantito l’equilibrio tra i diritti della donna, dell’embrione e del feto, come se questi fossero soggetti di diritto separati e contrapposti.
Ci devono essere delle motivazioni valide per abortire in Italia, sono definite e chiarite dalla legge stessa. L’articolo 4 recita:
“Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”
C’è sempre qualcuno autorizzato a chiedere ad una donna il motivo del suo aborto. Il medico non solo certifica l’esistenza della gravidanza ma autorizza l’intervento ed è proprio nel passaggio dell’autorizzazione e della richiesta della motivazione che cade la libertà e l’autodeterminazione della donna. Se sei incinta non puoi fare come ti pare, non puoi dire desidero abortire e basta. Se queste sono le premesse, le donne che decidono di interrompere una gravidanza sono davvero libere? Si tratta di un diritto riconosciuto o piuttosto di una concessione? Una extrema ratio, appunto.
La Legge 194 non riconosce in nessuna sua parte la libertà di abortire, riconosce il diritto della donna a interrompere una gravidanza per motivi di salute. È tutelato il diritto alla salute, non il diritto all’autodeterminazione. E anche volendo tutelare il diritto alla salute ci si trova di fronte a un cortocircuito se si pensa alla prospettiva del rischio minore, evidenziata da una cospicua letteratura medico-scientifica, secondo cui la gravidanza è più rischiosa per la salute della donna rispetto all’aborto. E quindi, se si tenesse in considerazione solo ed esclusivamente il diritto alla salute, si dovrebbe anche ammettere che interrompere una gravidanza sarebbe sempre meno rischioso per una donna che portarla avanti.
La legge 194 definisce tempi e modi per accedere all’interruzione della gravidanza e dà forma a un modello di assistenza sanitaria che dopo 43 anni dalla sua entrata in vigore presenta ancora carenze e criticità. Nonostante queste criticità la difesa del diritto all’aborto si configura sempre come la difesa della legge 194. Bisogna fare distinzione tra l’esistenza di una legge e la sua applicazione, in Italia entrambe sembrano essere problematiche. La 194/78 sancisce il diritto all’aborto e in un contesto in cui questo diritto sembra essere continuamente messo in discussione il dibattito si è ancorato nel tempo a una strenua difesa della legge. La 194 non si tocca perché toccarla potrebbe essere un’incognita e provocare una restrizione delle possibilità. La battaglia è quindi difensiva e si continua a stare sempre sulla retroguardia.
Sarebbe il caso di iniziare a chiedersi come mai e anche perché si continua a voler focalizzare l’attenzione sulle stesse questioni anche quando la società è cambiata, il sapere e le pratiche mediche sono avanzate e diverse, il mondo della comunicazione e le modalità di accesso alle informazioni sono stati rivoluzionati.
Sappiamo che l’applicazione della legge non viene rispettata, sappiamo che accedere all’aborto è difficoltoso se non impossibile in alcune regioni e città più che in altre, sappiamo che i dati che ci vengono forniti ci dicono qualcosa ma non ci dicono tutto e non sono molto utili.
Forse i tempi sono maturi per modificare i termini stessi del dibattito attorno all’aborto e aprirlo. La legge 194, approvata nel 1978, quando le donne morivano per aborti clandestini, è stata una grande conquista ma oggi che cosa è diventata? Una legge che non parla di scelta autonoma della donna ma di diritto alla salute, che mette in competizione il diritto di salute della donna e quello dell’embrione/feto, che garanzie di autodeterminazione e di libertà restituisce alle donne? In Italia c’è una legge ma non c’è il riconoscimento del diritto all’aborto. Non sarebbe giusto, a questo punto, intervenire sulla legge stessa e modificare i presupposti su cui si fonda la legalizzazione dell’aborto in Italia?
«La legge 194/1978 presenta numerosi ostacoli per l’accesso all’aborto per le donne e persone incinte in Italia, ostacoli che giustificano oggi un cambio di rotta nelle strategie del movimento femminista e pro-choice italiano rispetto alla lotta per l’aborto libero. È finito il tempo di accontentarci di un compromesso raggiunto più di 40 anni fa sulla nostra pelle», osserva a Valigia Blu Elena Caruso, dottoranda alla Kent Law School e co-fondatrice di Pro-choice Rete italiana contraccezione aborto. «Mi chiedo: ma abbiamo bisogno di una legge ad hoc per l’aborto? È un trattamento sanitario come altri. Non mi risulta che abbiamo una legge ad hoc per l’appendicite, eppure l’aborto col metodo farmacologico soprattutto nelle prime dieci settimane è ormai un trattamento semplicissimo e molto “safe” per la salute delle donne e persone incinte che vogliono interrompere una gravidanza».
Oggi in Italia ci sono ancora molti nodi da sciogliere attorno alla pratica dell’interruzione della gravidanza, primo fra tutti quello di individuare quali sono i termini del dibattito più corretti per garantire il diritto delle donne di scegliere in maniera autonoma rispetto alla propria vita sessuale e riproduttiva. L’aborto dovrebbe essere spostato dall’ambito morale, etico, religioso al piano dell’assistenza medica e del diritto delle donne, si tratta di un servizio medico e forse i tempi sono maturi perché sia garantito come tale senza possibilità di obiezioni da parte di terzi. Questi cambiamenti dovrebbero passare per necessarie e urgenti modifiche della legge. Il primo passo potrebbe essere partire dalla modifica del nome stesso della legge, non per la tutela della maternità ma dell’autodeterminazione della donna.
Immagine in anteprima via pagina Facebook Movimento Molto Più di 194