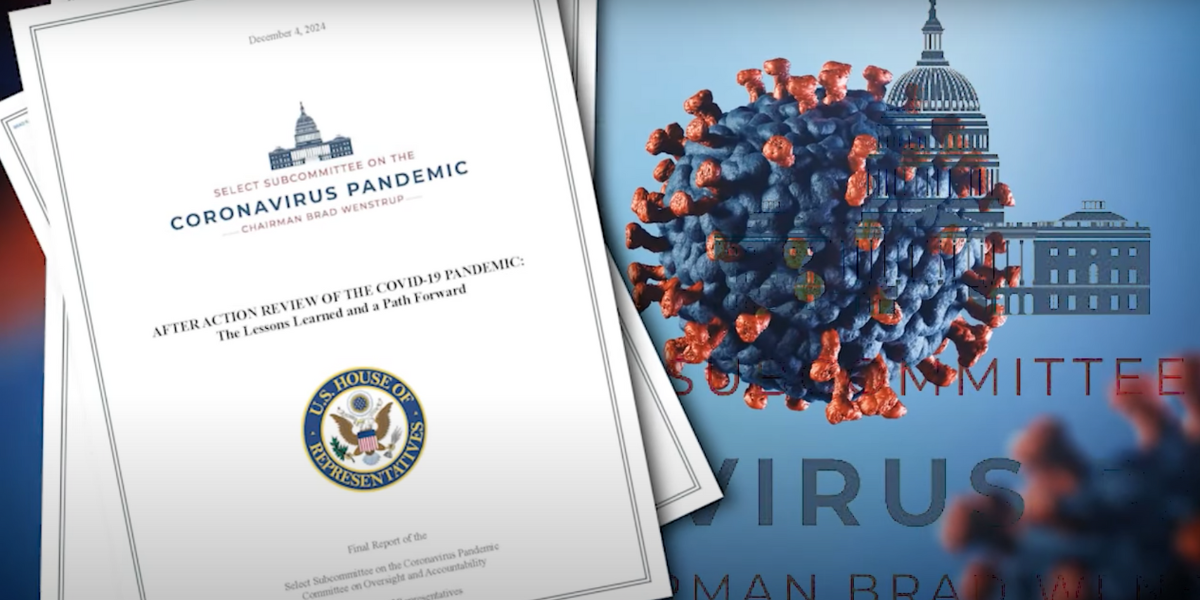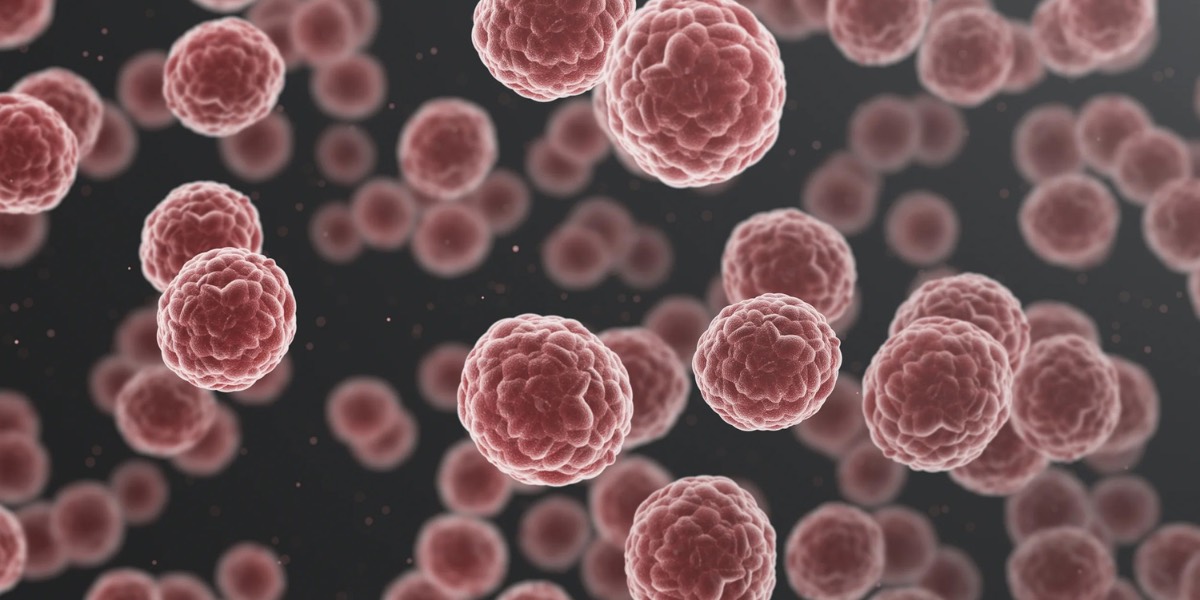L’impatto psicologico della pandemia sulle persone che si sono ammalate di COVID-19, i loro familiari, gli operatori sanitari e sulla popolazione
12 min letturaUno degli effetti di questo lungo periodo di emergenza è l’entrata nel lessico quotidiano di termini che hanno a che fare con la salute psicologica, l’espressione delle emozioni, i disturbi mentali. La preoccupazione per l’impatto psicologico della pandemia e delle emergenze da essa scaturite (sanitaria, economica, educativa, sociale) ha portato nella prima ondata a dare vita a iniziative talvolta estemporanee di comunicazione, di ricerca o di intervento che non si sono ripetute con la stessa assiduità nella seconda ondata.
Leggi anche >> Coronavirus: gli aspetti psicologici dell’epidemia e cosa fare
Non è neppure mancato il linguaggio consueto fatto di allarmi e stigma che, se da un lato strumentalizzava il disagio psicologico allo scopo di raccogliere attenzioni pubbliche o politiche, dall’altro continuava a contrastarne la legittimità, rendendo sempre più invisibile chi già da prima della pandemia affronta condizioni neuropsicologiche o psichiatriche. Questo meccanismo ha messo anche nell’ombra il lavoro eccezionale dei – troppo pochi - servizi di psicologia del nostro sistema sanitario nazionale che hanno saputo adattarsi ai nuovi bisogni di cura.
«Sia nella prima che nella seconda ondata abbiamo attivato percorsi orientati ai pazienti COVID-19, ai familiari e agli operatori», ha raccontato a Valigia Blu Elena Vegni, Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano e direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.
«Compito essenziale degli psicologi in ospedale è anche curare chi cura», ha aggiunto Giulia Lamiani, ricercatrice in Psicologia Clinica del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano e consulente dell’Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano. Entrambe le strutture dell’ASST sono diventate ospedali COVID-19.
Vegni e Lamiani hanno anche partecipato al gruppo di lavoro multidisciplinare che ha definito le indicazioni e le checklist per assicurare una modalità strutturata di comunicazione tra operatori sanitari e familiari dei pazienti in isolamento, seguendo il principio “che il tempo dedicato alla comunicazione deve essere inteso come un momento di cura”.
Con loro abbiamo ripercorso l’esperienza clinica e di ricerca per fare anche il punto sull’impatto psicologico della pandemia di SARS-CoV-2 sulle persone che si sono ammalate di COVID-19, sui loro familiari, sugli operatori sanitari e sulla popolazione generale.
«Nella prima ondata, la scelta degli interventi da attuare, ad esempio l’introduzione dei dispositivi digitali nei reparti, era derivata da una percezione clinica e aveva coinvolto i pazienti in ospedale, i loro familiari e gli operatori sanitari (medici, infermieri, OSS). Tra le due ondate sono stati condotti i controlli medici e psicologici per i pazienti dimessi e sono state aperte le altre attività ambulatoriali che erano sospese da marzo. La seconda ondata è stata più intensa perché sono stati riattivati i percorsi per i pazienti COVID-19, per i familiari e per gli operatori oltre al mantenimento delle attività per i pazienti con altre condizioni. Questa seconda ondata è stata più complessa in termini logistici, basti pensare ai cambi di vestizione per recarsi dai pazienti COVID-19 a quelli non COVID-19 (cardiologici, oncologici, ecc.)», riassume la professoressa Vegni . «Ma gli interventi ora si basano sull’esperienza di lavoro».
I pazienti COVID-19 e le sequele psicologiche
In una recente revisione delle manifestazioni psichiatriche e neuropsichiatriche associate alle gravi infezioni da coronavirus che ha preso in considerazione la SARS esordita nel 2002, la MERS del 2012 e l’attuale COVID-19, Jonathan Rogers e collaboratori concludono che “se l'infezione da SARS-CoV-2 segue un decorso simile a quello da SARS-CoV o da MERS-CoV, la maggior parte dei pazienti dovrebbe guarire senza soffrire di malattie mentali. SARS-CoV-2 causa delirium in una percentuale significativa di pazienti nella fase acuta”. Secondo gli autori, tuttavia, i medici devono essere consapevoli del rischio che a lungo termine le persone che si sono ammalate di COVID-19 possano manifestare depressione, ansia, affaticamento, disturbo post-traumatico da stress e sindromi neuropsichiatriche più rare.
In una lettera alla rivista Psychological Medicine, il gruppo di lavoro sulla neurologia e la neuropsichiatria della COVID-19 che aggiorna, attraverso il blog dedicato, tutte le nuove pubblicazioni sul tema, chiarisce che, al momento, è difficile accertare una relazione causale tra la gravità della COVID-19 e lo sviluppo del disturbo post-traumatico. In questa fase è necessario identificare i potenziali fattori di rischio, per individuare i pazienti più vulnerabili e intervenire tempestivamente. Secondo James Badenoch e gli altri autori della lettera, finora, sono stati ipotizzati diversi meccanismi per spiegare come insorga il disturbo post-traumatico nei pazienti con COVID-19: “I fattori biologici e ambientali possono svolgere un ruolo, anche nei casi di COVID-19 lieve o moderata”. Inoltre, diversi studi stanno dimostrando “che il disturbo post-traumatico da stress può essere una complicazione del delirium” che ha un’alta prevalenza nei pazienti COVID-19, non solo in quelli ricoverati in terapia intensiva. Sarà, quindi, da studiare se “il delirium è associato a una maggiore probabilità di trauma psicologico a lungo termine nel contesto specifico della COVID-19”.
La professoressa Vegni conferma che «i pazienti che escono dall’esperienza medica Covid continuano i controlli psicologici, e talvolta anche in seguito ad un ricovero non complicato, non solo dopo aver affrontato le condizioni più gravi, presentano una sintomatologia di tipo post-traumatico». Nella prima ondata le modalità stesse del ricovero e il distacco dai familiari «sono stati avvertiti come irrealtà», che ha riguardato anche «l’elaborazione di lutti complicati: persone ricoverate alle quali moriva un congiunto ammalato».
«Noi c’eravamo» ricorda Vegni, con le persone che guarivano e con le tante che non ce l’hanno fatta: «Le persone non sono morte da sole, potevano contare sullo sguardo di un soggetto vicariante». Nella seconda ondata, continua, «c’è stata una sorta di normalizzazione: come se fosse dato per scontato che chi muore di COVID-19 muore drammaticamente senza i propri familiari. Si incontra di più la rabbia, la rassegnazione anticipatoria».
Sia nella prima che nella seconda ondata è apparso chiaro quanto l’attività in presenza, nelle camere di degenza, diventasse «mandatoria o addirittura psicologicamente irrinunciabile perché il paziente si confronta con la paura di morire e il totale isolamento. C’è bisogno di una presenza, anche se questa modalità di interazione è complicata e faticosa perché si è bardati. Il paziente altrimenti rimane da solo per tutto il giorno e per tanti giorni, in alcuni casi con il casco in testa, e questo è destruente». Anche il passaggio di documenti all’interno della stanza di degenza per autorizzare una procedura medica avviene con tutte le cautele e le distanze, a rendere ancora più incombente la sensazione di pericolo.
I familiari e il lutto
Quello che la pandemia ha rivelato è l’assenza, al di fuori dei reparti di cure palliative e degli hospice, di percorsi definiti di assistenza al lutto nelle strutture ospedaliere.
L’esperienza della malattia e della morte è stata complicata e intensificata quando ha riguardato una persona cara infettata da SARS-CoV-2. L’impossibilità di vedere il proprio familiare negli ultimi giorni di vita, le barriere poste dagli schermi o dalle misure di protezione e l’interruzione dei rituali dopo la morte hanno reso ancora più complicato l’adattamento al lutto. A tutto questo si deve aggiungere la concomitanza di più lutti all’interno di una famiglia, seguita dalle difficoltà finanziarie incombenti in alcune situazioni.
Agli ospedali dell’ASST «sia nella prima che nella seconda ondata è stato attivato un servizio di supporto psicologico alle famiglie che subivano un lutto, con la prima chiamata entro le 48 ore successive», spiega la professoressa Vegni e il supporto ai familiari in lutto è continuato fino a quando necessario, «per completare il percorso di cura del paziente che muore in ospedale, una cura che include l’evento-morte».
Con i familiari, aggiunge Vegni, «l’obiettivo clinico è di verificarne i bisogni: nei casi necessari si continuano le telefonate e in alcuni casi si è fatto da ponte per ritrovare gli operatori sanitari che avevano visto gli ultimi istanti di vita del proprio congiunto».
Sue Morris e collaboratrici, prendendo come riferimento l’esperienza delle cure palliative, hanno raccomandato alcune strategie psicologiche da implementare negli ospedali per sensibilizzare al lutto e per preparare le famiglie alla morte dei loro cari, sostenendole nei mesi successivi. Si tratta di strumenti educativi, di comunicazione e di supporto cognitivo-comportamentale.
Gli operatori e il disagio morale
Gli staff ospedalieri sono tra le categorie più a rischio di sviluppare gli effetti diretti e indiretti della pandemia. Sono, difatti, i più esposti ai rischi di contagio del virus SARS-COv-2 e alle conseguenze dello stress del loro lavoro sulla salute mentale.
«Nella prima ondata i dati sugli operatori hanno rivelato sentimenti di paura, solitudine (molti avevano deciso di andare a vivere lontano dalle famiglie), impotenza. Il compattarsi tra operatori ha dato però motivazione al gruppo», spiega Lamiani. «Nella seconda ondata, l’impotenza che prima era sostenuta da un’attivazione, adesso, per i limiti ancora evidenti, è diventata un’impotenza appresa con apatia e un esaurimento emotivo tipico del burnout». A complicare questo stato psicologico è l’essere passati da essere oggetto di gratitudine ed idealizzazione nella prima ondata, a essere diventati oggetto della rabbia che serpeggia nella popolazione.
Per Vegni, «nella prima ondata vi era la consapevolezza del ritorno alla normalità dell’investimento relazionale nell’atto di cura; nella seconda ondata le richieste dei pazienti sono diventate pressanti», facendo prorompere la riflessione «sugli aspetti esistenziali e sulla complessità dell’atto di cura che include l’aspetto relazionale».
In particolare, le ricercatrici dell’ASST Santi Paolo e Carlo e dell’Università di Milano hanno studiato il disagio morale negli operatori sanitari.
«Il disagio morale», spiega Lamiani, «è quel disagio sperimentato quando non si può agire secondo i propri standard professionali. Molti operatori si sono trovati a disagio nel non poter erogare cure nel modo in cui erano abituati a farlo. Questo ha significato fare i conti con il limite e con il passaggio da un ruolo di guarigione a un ruolo di accompagnamento, con un conseguente cambiamento nel significato del proprio agire». Si tratta di «un vissuto specifico che ha a che fare con i propri valori e con la propria identità professionale».
Lamiani riporta anche i risultati del "Progetto benessere", che è partito preso l’ASST a luglio, per valutare l’incidenza di ansia, depressione e stress post-traumatico negli operatori sanitari e amministrativi, attraverso appositi questionari. La partecipazione allo studio era su base volontaria e quindi probabilmente hanno partecipato solo gli operatori che sentivano l’esigenza. «Hanno risposto in più di 300 e questo dimostra che il questionario ha incontrato un bisogno». In tal modo, è stata messa in atto una «psicologia più proattiva, con la possibilità di una presa in carico individuale degli operatori che in base ai questionari segnalavano un disagio».
Secondo una metanalisi in continuo aggiornamento, il carico aggiuntivo sulla salute psicologica di chi lavora direttamente con i pazienti infetti durante le emergenze sanitarie epidemiche e pandemiche (includendo COVID-19, Ebola, influenza H1N1, SARS e MERS) è associato a un lieve incremento della prevalenza dell’ansia in fascia clinica e della depressione in fascia clinica, mentre non si registra ai dati attuali un aumento della prevalenza del disturbo post-traumatico da stress. Per gli autori della metanalisi, non è chiaro quale sarà l’impatto di questi incrementi sulla salute mentale degli operatori “ma è chiaro che esistono notevoli barriere che impediscono l'uso dei servizi di salute mentale da parte del personale sanitario”. Pertanto, “la disponibilità di servizi di salute mentale dovrebbe essere una priorità dato che i tassi di disagio psicologico sono già molto alti”.
Un aspetto critico è che gli operatori sanitari che vivono condizioni di disagio tendono a non richiedere spontaneamente né a cercare i servizi necessari ma a utilizzarli quando questi sono messi a disposizione dal proprio ospedale. Nelle due strutture dell’ASST di Milano, contando sulla ventennale esperienza dell’Unità Operativa di Psicologia, fin dalla prima ondata sono stati organizzati diversi tipi di interventi per gli operatori. In primo luogo, nei reparti era ed è garantita la presenza di psicologi.
«Abbiamo istituito una stanza di decompressione che nella prima ondata è stata adibita in modo da creare un setting accogliente con materiale informativo sulla prevenzione psicologica, sul burnout e lo stress, e su come dare cattive notizie», racconta la professoressa Vegni. «Un luogo sicuro dove poter staccare, con la possibilità di ascoltare musica, di essere guidati da una psicologa nel rilassamento e poter raccogliere le emozioni emergenti». Nella prima ondata la stanza aveva registrato circa 300 accessi ma nella seconda ondata «c’è stata una cronicizzazione dell’emergenza, che probabilmente ha portato a un minore uso della stanza di decompressione».
Come descritto da Leone e colleghi, tra gli altri interventi, “gli psicologi clinici delle ASST hanno istituito uno spazio di supporto individuale e hanno offerto agli operatori la possibilità di accedere agli incontri di decompressione e debriefing” anche attraverso le micro-equipe alle quali partecipavano medici, infermieri e OSS.
«Emotivamente è un’esperienza dura», afferma Lamiani. «Prima della pandemia abbiamo sempre lavorato con gli operatori ma questo, non rappresentava la parte principale del nostro lavoro. Ora invece è una parte cospicua. Quest’anno lo sforzo richiesto agli operatori è notevole. Ora i livelli di fatica sono alti, i costi elevati. La cura degli operatori deve essere tenuta a mente perché devono essere messi in condizioni di prestare al meglio le cure».
Durate l’estate, tra la prima e la seconda ondata, è stato anche organizzato un gruppo di miglioramento interdisciplinare per rivedere quello che aveva funzionato e quello che non aveva funzionato nella prima ondata, similmente a quanto avviene nella revisione degli eventi avversi. Al gruppo hanno preso parte diversi professionisti, per riflettere su quello che è stato fatto, per integrare e per apprendere dall’esperienza vissuta.
La popolazione generale e l’adattamento
I numerosi studi sull’impatto psicologico dell’epidemia nella popolazione generale risentono di alcune debolezze metodologiche quali la rappresentatività dei campioni studiati, gli strumenti utilizzati e il periodo di tempo in cui sono state condotte le ricerche. Nel complesso, i ricercatori richiamano alla cautela nelle modalità con cui si diffondono le notizie sul disagio psicologico e ad evitare toni sensazionalistici.
Come mostrano Ann John, Louis Appleby e altri, in un editoriale di novembre sul British Medical Journal, in base a diversi studi, non si registrano variazioni – né un aumento né un calo - dei tassi di suicidio nei primi mesi della pandemia, almeno nei paesi ad alto reddito. “Il quadro è molto meno chiaro nei paesi a basso reddito, dove possono mancare le reti di supporto disponibili in contesti con maggiori risorse”. In questo momento devono trovare spazio le misure di prevenzione. Secondo gli autori, “identificare i fattori di rischio noti che potrebbero essere esacerbati dalla pandemia è fondamentale. Questi includono depressione, disturbo post-traumatico da stress, disperazione, sentimenti di intrappolamento e sovraccarico, abuso di sostanze, solitudine, violenza domestica, abbandono o abuso di minori, disoccupazione e altre insicurezze finanziarie”. A questo scopo “devono essere messi a disposizione servizi adeguati per le persone in crisi e per coloro che hanno problemi di salute mentale emergenti o pre-esistenti”.
Leggi anche >> Emergenza coronavirus: l’isolamento in casa e il rischio della violenza domestica
L’andamento dei livelli di ansia e di depressione durante la prima ondata è stato analizzato attraverso uno studio longitudinale inglese su oltre 30.000 partecipanti. I risultati di questo studio suggeriscono che i livelli più alti di depressione e ansia sono stati sperimentati nelle prime fasi del confinamento per poi diminuire piuttosto rapidamente nelle settimane successive, probabilmente per un effetto di adattamento. Tuttavia, essere donne o giovani, avere un grado di istruzione basso, un reddito basso o condizioni psichiatriche preesistenti, vivere da soli o con bambini si sono dimostrati fattori di rischio per livelli più elevati di ansia e sintomi depressivi sperimentati all'inizio del lockdown e queste disuguaglianze sebbene ridotte permanevano nelle settimane successive.
Riassumendo i risultati di questo studio, tendiamo a mostrare un rapido adattamento alle nuove esigenze psicologiche poste dai cambiamenti di vita anche durante una pandemia e i mesi di confinamento per ridurne i contagi. Le disuguaglianze nella rapidità e nell’efficacia di questo adattamento però si mantengono ed è per questo che è necessario supportare i gruppi vulnerabili che possono avere un impatto più severo e prolungato sulla salute mentale.
All’Università degli Studi di Milano, Lamiani sta conducendo una ricerca qualitativa sui processi di adattamento/disadattamento nella popolazione generale dopo la prima ondata della pandemia. Riposizionarsi a ondata finita rappresenta il processo cruciale per promuovere l'adattamento. Riposizionarsi vuol dire «entrare in contatto con i vissuti spiacevoli scatenati dalla pandemia e dal lockdown, come i vissuti di paura, di perdita (reale o simbolica), di incertezza, di solitudine, di disconnessione, di esaurimento e cercare di dare loro un senso e una forma per poter stare nel presente». Ovviamente il riposizionamento richiede risorse psicologiche individuali ma è anche influenzato da fattori contestuali.
I dati suggeriscono, spiega Lamiani, che «il processo di riposizionamento, può facilitare l’adattamento e la crescita: riuscire a stare in questa situazione, con tutti i residui emotivi della prima ondata, trovando un proprio posto o cambiando priorità. L’alternativa è il disadattamento, caratterizzato da blocchi nella sfera individuale, relazionale o nella propria progettualità».
In questo difficile anno si è scritto e parlato di più di aspetti e problemi psicologici legati alla pandemia. In molti casi le situazioni di fragilità che erano rimaste sommerse sono affiorate e questa situazione ha permesso di chiedere aiuto, di non sentire lo stigma della richiesta di aiuto. Si è diffusa la percezione che la sofferenza psicologica sia umana e degna di attenzione e cure, analogamente alla sofferenza fisica.
Questo patrimonio potrebbe andare disperso e, una volta tornati a quella che sarà una rinnovata normalità, potremmo tornare a dare poco spazio all’espressione delle emozioni e del disagio psicologico, all’ascolto delle richieste di aiuto. O, peggio, queste richieste potrebbero rimanere inascoltate perché i servizi specialistici sono insufficienti o non accessibili a tutti. La sofferenza psicologica tornerà invisibile? L’attenzione attuale alla salute psicologica servirà a moltiplicare i servizi nel sistema sanitario nazionale?
Immagine anteprima di Engin Akyurt via Pixabay