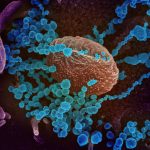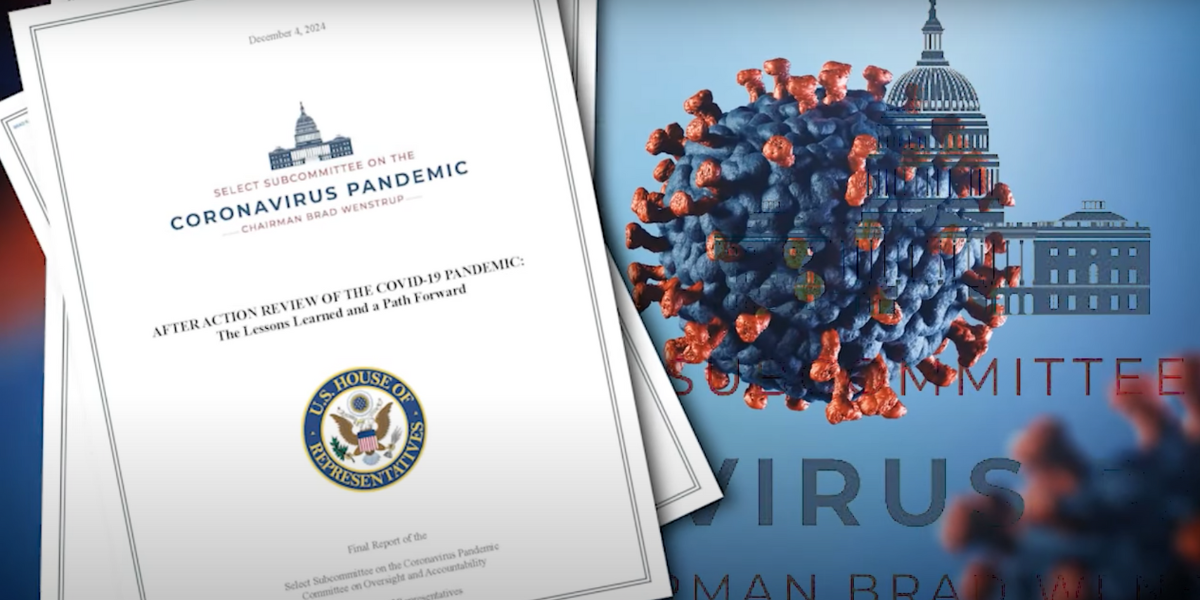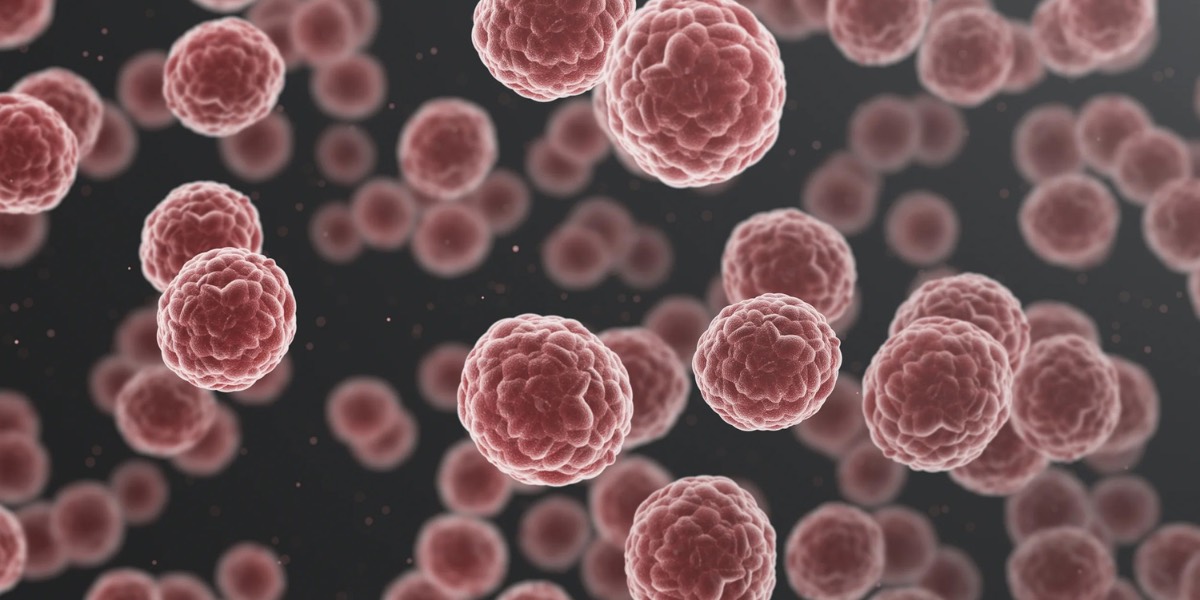Costi, difficoltà di somministrazione, efficacia limitata: perché gli anticorpi monoclonali non sono la panacea contro l’epidemia da COVID-19
9 min letturaIl 6 febbraio il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che autorizza “la distribuzione in via straordinaria” degli anticorpi monoclonali in Italia: “Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare la COVID-19”, ha commentato Speranza in un post su Facebook. La gestione è stata affidata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri.
L’annuncio del ministro ha fatto seguito al parere favorevole dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l’uso d’emergenza degli anticorpi monoclonali, prodotti dalle aziende farmaceutiche statunitensi Regeneron ed Eli Lilly, su pazienti in una fase precoce della malattia che sono a rischio di gravi peggioramenti. Le due terapie avevano ottenuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza negli Stati Uniti dall’agenzia americana del farmaco (FDA) lo scorso novembre.
La decisione dell’AIFA è arrivata dopo le pressioni da parte di alcuni specialisti, tra cui anche il virologo Giorgio Palù, a capo del consiglio di amministrazione dell’AIFA, che spingevano per l’utilizzo dei farmaci anche nel nostro paese. In un’intervista al Fatto Quotidiano, Palù aveva annunciato – subito dopo l’autorizzazione dell’AIFA – la dotazione di un fondo tra i 400 e i 500 milioni di euro per acquistare gli anticorpi monoclonali “il prima possibile, prima che fossero opzionati dagli altri paesi” in modo tale da assistere immediatamente "le persone ultrasessantenni e quelle fragili sia a casa che nelle strutture ambulatoriali".
Inizialmente, il direttore del comitato tecnico scientifico (CTS) dell’AIFA, Nicola Magrini, aveva espresso riserve sull’autorizzazione per l’impegno di spesa molto alto richiesto dalla sperimentazione e perché i risultati dei test svolti finora sull’efficacia degli anticorpi monoclonali sono ancora contraddittori e fanno riferimento a dati troppo esigui.
Ogni fiala di bamlanivimab è costata 1.250 dollari al governo statunitense, una spesa ritenuta eccessiva di fronte al rischio di trovarsi poi magari in una situazione simile all'idrossiclorochina, farmaco (molto meno costoso degli anticorpi monoclonali) a lungo sperimentato contro la COVID-19 sulla spinta di opinione pubblica e politica e poi rivelatosi inefficace, commenta Andrea Capocci su Il Manifesto.
Magrini aveva detto di voler attendere il parere dell’agenzia europea del farmaco (EMA) che non si è ancora espressa al riguardo. “Sugli anticorpi monoclonali abbiamo ancora pochi dati”, ha affermato Armando Genazzani, membro del comitato di valutazione dei farmaci dell’Ema. Il direttore del CTS dell’AIFA è stato anche accusato di non aver autorizzato questi trattamenti quando alcuni mesi fa gli erano stati offerti gratuitamente. Ipotesi poi smentita dallo stesso Magrini in una nota del 22 dicembre scorso: Eli Lilly si sarebbe genericamente detta disponibile a cooperare con le autorità italiane per utilizzare il farmaco in Italia senza mai offrire partite gratuite del prodotto e, anzi, il 20 novembre avrebbe presentato all’AIFA un’offerta per l’acquisto del farmaco da parte del Servizio Sanitario Nazionale, e proposto una procedura di approvazione in deroga alle regolamentazioni vigenti che necessitano di un’approvazione da parte dell’EMA.
Alla fine, dopo tante pressioni, il CTS dell’AIFA ha disposto l’autorizzazione per l’uso di emergenza “a soggetti di età superiore ai 12 anni, non ospedalizzati e non in ossigeno terapia per COVID-19, con sintomi lievi o moderati insorti da non oltre 10 giorni, in presenza di almeno un fattore di rischio” come malattie renali croniche, diabete non controllato, immunodeficienze, e che pertanto potrebbero “sviluppare una forma grave di COVID-19”. “Pur considerando l’immaturità dei dati e la conseguente incertezza rispetto all’entità del beneficio offerto” – si legge nel documento di approvazione – “a maggioranza”, è stato ritenuto opportuno “offrire comunque un’opzione terapeutica in via straordinarie e in considerazione della situazione di emergenza”.
«È sbagliato generare aspettative irrealistiche», ha commentato Magrini in un’intervista a Il Manifesto. «Ci sono studi di piccole dimensioni, pubblicati di recente e studi ancora in corso che mostrano stime incoraggianti nei pazienti in fase precoce di malattia ma basate su pochi dati. È un ambito in rapida evoluzione che richiederà la definizione di nuovi cocktail più efficaci e più fattibili. A questo proposito, l’informazione data al pubblico deve essere basata sulle migliori evidenze. Va creato un clima di fiducia nella popolazione affinché si comprenda bene il valore delle varie terapie disponibili, il valore fondamentale del nostro servizio sanitario nazionale universalistico e il contesto europeo di questa pandemia, che è un fenomeno planetario».
Cosa sono gli anticorpi monoclonali
Gli anticorpi monoclonali sono proteine prodotte in laboratorio che imitano la capacità del sistema immunitario di combattere i virus. Finora, sono stati sviluppati per la terapia e la profilassi di altre infezioni virali come la sindrome da immunodeficienza acquisita, l’influenza, il virus respiratorio sinciziale (RSV), MERS-CoV, Ebola e Zika. Tra queste sperimentazioni, si sono dimostrati efficaci solo gli anticorpi monoclonali diretti contro l’RSV e Ebola.
Nel caso di SARS-CoV-2, gli anticorpi monoclonali intervengono su una parte specifica del virus, la proteina Spike (che si lega al recettore ACE2 ed entra nelle nostre cellule) e sarebbero in grado di ridurne la carica virale, i sintomi e il rischio di ospedalizzazione.
Come spiega in un post su Facebook il dott. Marzio Sisti, infettivologo e responsabile di Prevenzione, Sorveglianza e Trattamento Infezioni Ospedaliere della AUSL di Piacenza, gli anticorpi monoclonali sono preformati e, pertanto, durano relativamente poco nel sangue, in genere due o quattro settimane. Sono allo studio anticorpi che possano durare anche fino a 6 mesi ed essere utili nella prevenzione in alcuni gruppi di popolazione non vaccinabili.
Inoltre, per le particolari modalità di produzione, gli anticorpi monoclonali hanno costi molto elevati. Il costo medio di una dose oscilla tra i 1.600 e i 2.000 dollari per quanto non è ancora chiaro quale sia il dosaggio ottimale che consenta una reale efficacia della terapia. La somministrazione avviene attraverso infusioni endovenose della durata di qualche ora.
Negli ospedali americani sono state consegnate oltre 600.000 dosi, ma – riportava a fine dicembre il Washington Post – ne sono state utilizzate appena il 20%. A fine gennaio, la Germania ha acquistato 200.000 dosi di anticorpi monoclonali per una spesa di circa 487 milioni di dollari.
Gli anticorpi monoclonali possono essere “uno degli strumenti più potenti nella medicina moderna ma sono molto costosi e relativamente difficili da realizzare”, spiega al Guardian Lindsay Keir, autrice per Wellcome (una fondazione che sostiene la ricerca scientifica negli ambiti della salute mentale, del riscaldamento globale e delle malattie infettive) di uno studio sull’estensione dell’accesso a questa terapia anche per le persone dei paesi a basso e medio reddito. La strada è ancora molto lunga per fare sì che gli anticorpi monoclonali siano accessibili a tutti, “la speranza è che la ricerca per il loro utilizzo contro la COVID-19 possa fare in modo che si abbassino i costi e possano essere utilizzati non solo dai paesi più ricchi”, ha aggiunto Keir.
Cosa dicono gli studi
L’autorizzazione dell’agenzia del farmaco statunitense per l’uso di emergenza del bamlanivimab (chiamato anche LY-CoV555), prodotto dalla casa farmaceutica Eli Lilly, e del cocktail di due anticorpi – caririvimab (REGN10933) e imdevimab (REGN10987) – sviluppato da Regeneron e usato per curare l’ex presidente USA Donald Trump, si era fondata sui dati provenienti da due studi clinici di fase 2 controllati randomizzati che mostravano, dopo il trattamento, una riduzione dei ricoveri o degli accessi al pronto soccorso da parte di persone che avevano contratto la COVID-19.
A ottobre, il New England Journal of Medicine ha pubblicato i risultati parziali provenienti dallo studio BLAZE-1 (acronimo di “Blocking Viral Attachment and Cell Entry with SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies”), finanziato dalla casa farmaceutica Eli Lilly. Secondo i dati raccolti all’epoca su 452 pazienti ritenuti ad alto rischio di poter sviluppare una forma grave di COVID-19 e di essere ricoverati, cinque pazienti su 309 (1,6%) che hanno ricevuto l’anticorpo monoclonale LY-CoV555 hanno avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso o di un ricovero ospedaliero. Nel gruppo che aveva ricevuto il placebo sono stati riscontrati nove casi su 143, pari al 6,3%.
Il 21 gennaio è stato pubblicato un altro articolo con dati più aggiornati sullo studio BLAZE-1, questa volta sul Journal of the American Medical Association. Secondo i dati riportati, il bamlanivimab non ha prodotto alcun miglioramento significativo per la salute dei pazienti rispetto a chi ha ricevuto il placebo e ha dimostrato una riduzione della carica virale solo in combinazione con un altro anticorpo – etesevimab – all’undicesimo giorno da quando è stata contratta la malattia.
Per quanto riguarda il cocktail di anticorpi di Regeneron, uno studio pubblicato sempre il 21 gennaio sul New England Journal of Medicine ha mostrato che su 275 pazienti sintomatici la terapia ha ridotto la carica virale soprattutto nei pazienti la cui risposta immunitaria non era ancora iniziata o che avevano un’elevata carica virale. Il 6% dei pazienti del gruppo placebo e il 3% dei pazienti del gruppo che ha preso una dose combinata degli anticorpi monoclonali è stato assistito almeno una volta da un medico. Tra i pazienti sieronegativi, il 15% del gruppo placebo e il 6% di chi ha ricevuto la terapia ha chiesto assistenza. L’obiettivo dello studio era valutare la variazione media ponderata della carica basale dal primo al settimo giorno e la percentuale di pazienti che si sono rivolti a un medico per COVID-19 entro il ventinovesimo giorno.
Il National Institutes of Health (NIH) e la Società americana della malattie infettive (IDSA) hanno espresso riserve sull’utilizzo degli anticorpi monoclonali nonostante l’approvazione per l’uso di emergenza dell’agenzia americana del farmaco. “Al momento, non ci sono dati sufficienti per raccomandare o meno l'uso di bamlanivimab per il trattamento di pazienti ambulatoriali affetti da COVID-19 lieve e moderato. Bamlanivimab non va considerato lo standard di cura per il trattamento dei pazienti con COVID-19”, scriveva NIH. L’IDSA è andata oltre e ha sconsigliato l’utilizzo routinario di bamlanivimab: “È una ragionevole opzione terapeutica se, dopo un processo decisionale informato, il paziente tiene in forte considerazione dei benefici incerti e in scarsa considerazione degli effetti avversi incerti”.
Inoltre, secondo due pre-print di uno studio svolto in Sudafrica e uno in Cina, gli anticorpi monoclonali sembrano inefficaci contro le mutazioni del virus rilevate in Sudafrica e Brasile. GlaxoSmithKline ed Eli Lilly hanno annunciato la collaborazione per nuovi trial clinici. Altri studi sono attesi nelle prossime settimane.
L’Italia ha, dunque, colpevolmente ritardato per mesi l’utilizzo degli anticorpi monoclonali come sostenuto da alcuni più volte in queste settimane?
Stando agli studi pubblicati sembrerebbe proprio di no, spiega Andrea Capocci in un thread su Twitter. I dati mostrano che il bamlanivimab, l’anticorpo monoclonale prodotto da Eli Lilly e la cui sperimentazione sarebbe stata proposta in Italia dall’azienda stessa con diecimila dosi a ottobre, non è efficace e mostra benefici solo in combinazione con l’etesevimab che, però, come spiegava il prof. Guido Silvestri, uno dei principali sostenitori di questa terapia, sarebbe stato disponibile solo da inizio 2021.
5/Quindi se Aifa avesse seguito i suggerimenti e autorizzato in ottobre il bamlanivimab, avrebbe autorizzato un farmaco inutile e problematico. Ecco i problemi di somministrazione secondo Paul Sax di Harvard. pic.twitter.com/CkQtIXS962
— Andrea Capocci (@andcapocci) February 5, 2021
Quindi, conclude Capocci, bene ha fatto l’AIFA a non approvare a ottobre l’uso del bamlanivimab perché avrebbe autorizzato un farmaco che poi, alla luce dei “dati di cui siamo al corrente oggi”, si è rivelato “inutile e problematico” e “avrebbe mandato diecimila pazienti infetti (quante erano le dosi proposte da Eli Lilly) con sintomi lievi a fare tre ore di infusioni intravenose in piena seconda ondata in ospedali già sovraccarichi, mettendo a rischio loro, i sanitari e gli altri pazienti”. Il farmaco richiede, come già detto, una infusione di tre ore da effettuarsi in ospedale.
Riflessioni condivise anche dal medico e divulgatore scientifico Salvo Di Grazia sul suo blog. Considerato che gli “anticorpi monoclonali sono praticamente insomministrabili”, questa cura – spiega Di Grazia – finirebbe con l’ottenere un risultato esattamente opposto a quello che vorrebbe raggiungere: la saturazione dei posti liberi negli ospedali. “Se il principale problema della COVID-19 (credo sia un dato assodato) è proprio quello di saturare i reparti, come può essere ‘utile’ una cura che li satura ulteriormente?”.
Riassumendo, scrive Di Grazia, al momento i risultati degli studi sugli anticorpi monoclonali “sono incoraggianti ma molto lontani dal dirsi esaltanti o che dimostrino grande efficacia”, sono più una “possibilità di cura” che “la cura definitiva”:
“Diciamo che, ottimisticamente e se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, qualche piccolo effetto, in gruppi selezionati, forse c'è. Se invece fossimo pessimisti e giù d'umore potremmo dire che questi farmaci riducono un po' gli accessi delle persone in ospedale e i ricoveri per Covid e per farlo dobbiamo fare accedere le persone in ospedale, spendere una marea di soldi e organizzare un percorso specifico.”
“In conclusione – commenta Marzio Sisti su Facebook – possiamo dire che gli anticorpi monoclonali sono sicuramente una opzione terapeutica interessante, ma con molti punti interrogativi: per costi, difficoltà di somministrazione ed efficacia limitata alle fasi iniziali della malattia non sembrano avere un grande impatto sui numeri dell’epidemia”.
“I monoclonali – aggiunge su Twitter il neurobiologo Giorgio Gilestro, professore associato all’Imperial College di Londra – intesi come categoria farmaceutica, potrebbero essere una futura soluzione per tutti coloro che non hanno la fortuna di potersi vaccinare. Ma sono terapie per ora marginali e non è il caso di illudere ulteriormente il pubblico. I vaccini al momento sono la luce in fondo al tunnel”.
Per questo, conclude Gilestro, non sembrano esserci le condizioni per investire 500 milioni di euro come proposto da Palù: “Se impiegassimo quei soldi per costruire uno stabilimento che produca vaccini a mRNA ne guadagneremmo 1) in tecnologia, 2) in conoscenza, 3) in vaccini, 4) in vite salvate, 5) in ritorno economico, 6) in onestà intellettuale. I monoclonali lasciamoli per ora alla ricerca”.
Se impiegassimo quei soldi per costruire uno stabilimento che produca vaccini a mRNA ne guadagneremmo 1) in tecnologia, 2) in conoscenza, 3) in vaccini, 4) in vite salvate, 5) in ritorno economico, 6) in onestà intellettuale. I monoclonali lasciamoli per ora alla ricerca. 6/7
— Giorgio Gilestro (@giorgiogilestro) February 5, 2021
Immagine in anteprima: Niaid-Rml