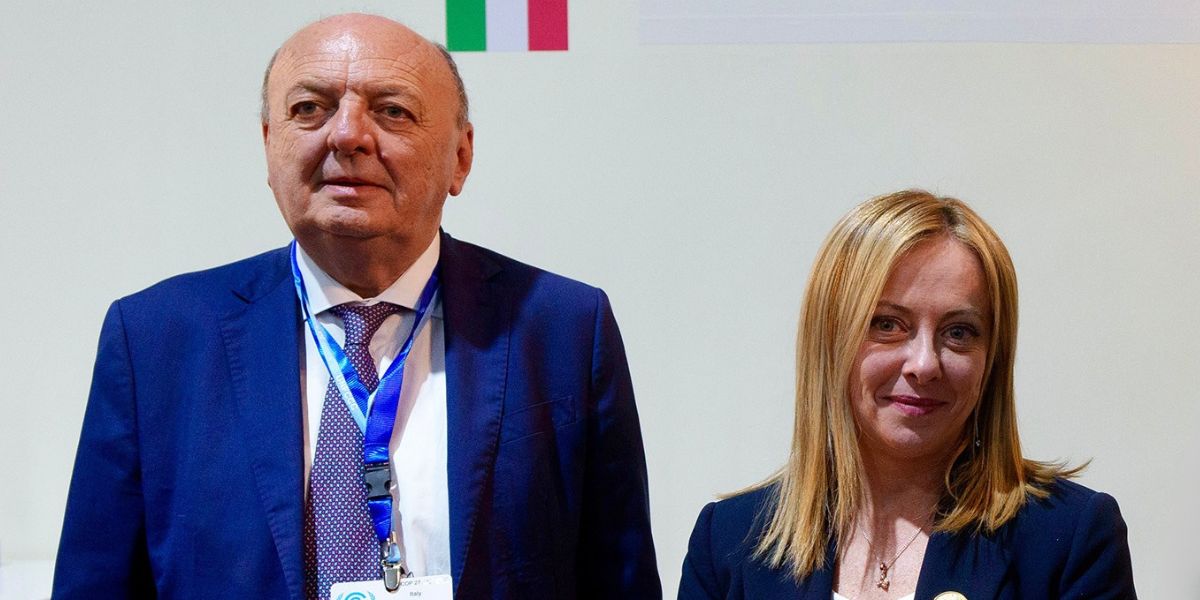Alluvione in Emilia-Romagna: le cause e gli interventi fatti finora, e cosa fare per mitigare il rischio e affrontare il cambiamento climatico
12 min letturaMancanza di interventi per adeguare il territorio a eventi meteorologici estremi, insufficienza di lavori di messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico, consumo di suolo addirittura aumentato. In seguito alla grave alluvione in Emilia-Romagna, è nato un acceso dibattito sugli interventi che avrebbero potuto evitare l’allagamento di decine di migliaia di case e la morte di 15 persone. Si è parlato soprattutto di mancata prevenzione, cioè di cosa non è stato fatto negli ultimi anni per mettere in sicurezza la popolazione. E anche di cattivo governo del territorio, ovvero di cosa è stato fatto male. Nel frattempo, martedì 23 maggio il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che stanzia circa due miliardi di euro per affrontare l’emergenza: il provvedimento contiene una serie di indicazioni per la popolazione delle zone colpite, tra cui la sospensione del pagamento di tasse, contribuiti e utenze energetiche dal 1° maggio al 31 agosto, la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, e un’indennità una tantum da 3mila euro per i lavoratori autonomi.
Ma come si è arrivati fin qui? Facciamo un passo indietro. Secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), ente di ricerca pubblico legato al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, l’Emilia-Romagna è tra le regioni italiane con la percentuale più alta d’Italia di territorio potenzialmente allagabile. Come mai? Storicamente l’Emilia-Romagna è terra di bonifiche: oltre ai tanti fiumi e torrenti che sono stati canalizzati, ci sono migliaia di chilometri di canali di scolo e irrigazione. Vicino ai quali si è anche costruito. Ecco perché le aree allagabili sono particolarmente estese. L’ultimo rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico aggiunge un’aggravante: la rete di corsi d’acqua si sviluppa su aree morfologicamente depresse, cioè situate a un livello più basso rispetto al suolo. Inoltre spesso i canali sono pensili, cioè il letto è sopraelevato rispetto al piano di campagna.
“Gli argini che hanno ceduto durante questa alluvione sono il risultato delle grandi bonifiche dei primi del Novecento, che avevano come obiettivo quello di recuperare più spazio possibile all’agricoltura”, spiega a Valigia Blu Andrea Colombo, responsabile della valutazione e gestione dei rischi idraulici dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, l’ente che si occupa di scrivere il Piano di gestione rischio alluvioni (Pgra) e il Piano per l’assetto idrogeologico (Pai). “Gli argini che sono stati costruiti nel secolo scorso oggi risultano troppo stretti, tanto che in caso di piene importanti, come quelle recentemente avvenute, l’acqua non ha abbastanza spazio per defluire e finisce per tracimare: essendo costruiti prevalentemente in terra, si erodono e collassano velocemente. Ecco perché sarebbe necessario arretrare gli argini laddove possibile: dobbiamo dare più spazio ai fiumi”. Lasciare più libertà ai fiumi di scorrere, comunque, non significa lasciarli liberi di esondare, ma risolvere alla radice il problema di un eccesso di canalizzazione delle acque che ormai non sta più in piedi. “In questi giorni si è molto discusso della ‘messa in sicurezza’ del territorio, ma non si tiene conto del fatto che, quando si parla di fenomeni naturali, una messa in sicurezza assoluta non è possibile”, afferma Colombo. “Meglio parlare allora di mitigazione del rischio: dobbiamo fare di tutto per abbassare il livello di rischio, ma essendo consapevoli che il rischio zero non esiste”.
C’è chi chiede di smettere di costruire opere artificiali e chi pensa che la soluzione siano le dighe, chi punta sulla rinaturalizzazione del fiume e chi invece propone di rinforzare gli argini. “Non esistono soluzioni semplici e immediate: va studiato un mix di interventi, che sia sostenibile sia da un punto di vista tecnico, che economico e sociale”, commenta Andrea Colombo. “Una corretta manutenzione degli argini e dell’alveo del fiume è un intervento necessario, ma non sufficiente. Dobbiamo quindi innanzitutto completare gli interventi già avviati, come le casse di espansione che sono in costruzione e che vanno ultimate. Poi, laddove possibile, sarà necessario arretrare le attuali arginature, anche creando un doppio sistema con golene chiuse, come già esistono in alcuni punti alla foce del Po, e realizzare tratti di argini non erodibili che se superati dalle acque non collassino. Bisognerebbe ammodernare le strutture di attraversamento, ossia i ponti: molti risultano inadeguati perché, essendo troppo bassi o troppo stretti, quando il livello del fiume cresce finiscono per ostruire il passaggio dell’acqua, aumentando la pressione a monte. Lo stesso avviene nei tratti tombinati, cioè le parti del fiume che sono state coperte, in particolare nelle città: laddove si può, si dovrebbe togliere la copertura, oppure ampliare la sezione di deflusso”.
Un altro tema particolarmente delicato è quello della delocalizzazioni delle abitazioni nelle aree più a rischio. “Bisogna avere il coraggio di delocalizzare più lontano dal fiume quegli edifici e insediamenti più critici e quelli che sono stati gravemente danneggiati dall’evento di piena”, afferma Colombo. “Si tratta di scelte complesse, che vanno spiegate, ma che non possiamo più rimandare”.
Il legame tra alluvione e consumo di suolo
Con queste premesse, il territorio emiliano-romagnolo dovrebbe essere poco cementificato. E invece no: l’Emilia-Romagna è la quarta regione più cementificata d’Italia (dopo Lombardia, Veneto e Campania) con l’8,9% di suolo impermeabilizzato contro il 7,1% nazionale. Lo dice l’ultimo rapporto sul consumo di suolo sempre dell’Ispra. Inoltre, è terza tra le regioni che hanno registrato un incremento maggiore di consumo di suolo rispetto al 2020: 658 ettari ricoperti in più, equivalenti al 10,4% del consumo di suolo nazionale. La provincia di Ravenna è la seconda provincia regionale per consumo di suolo nel 2020-2021 (più 114 ettari, pari al 17,3% del consumo regionale), con un consumo pro capite di 2,95 metri quadrati per abitante all’anno.
“Il motivo per cui la pioggia sta avendo conseguenze dannose e a volte letali è presto detto: cade su un suolo asfaltato, cementificato, impermeabilizzato, che non può assorbirne una sola goccia, dunque quest’acqua non solo non rigenera la vita, non solo non ricarica le falde, ma si accumula in superficie e corre via, a grande velocità, travolgendo quel che trova”, ha scritto anche il collettivo Wu Ming nel blog Giap. “Spesso esonda da corsi d’acqua i cui argini – e spesso anche i letti – sono stati cementificati, e le cui aste sono state «rettificate». Corsi d’acqua intorno ai quali, dissennatamente, si è costruito e ancora costruito”.
In Emilia-Romagna si consuma suolo perfino nelle aree protette (più 2,1 ettari), nelle aree a pericolosità di frana (più 11,8 ettari), nelle aree a elevata pericolosità idraulica (più 78,6 ettari). “Si costruisce ancora in zona pericolose, andando a esporre le popolazioni a un rischio”, ha spiegato Francesca Giordano, ricercatrice dell’Ispra, in un’intervista a Agi. “Ci sono edifici, forse condonati nel tempo, che si trovano a essere a ridosso degli argini dei fiumi. L'impermeabilizzazione del suolo rende il territorio meno in grado di assorbire l’acqua”.
L’impossibilità del terreno di assorbire acqua, comunque, non riguarda solo il suolo cementificato: Michele Munafò, responsabile del rapporto sul consumo di suolo dell’Ispra, ha dichiarato in un’intervista al Manifesto che anche nei campi “un’agricoltura intensiva, senza adeguate coperture vegetazionali, non fa che ridurre la capacità del suolo di far infiltrare acqua e trattenerla. Se a questo aggiungiamo una situazione che alterna siccità prolungata e grandi piogge, questo non fa che degradare il suolo”.
Le iniziative per la mitigazione del cambiamento climatico in Emilia-Romagna
Nel 2017 la regione Emilia-Romagna ha approvato la legge 24 sulla tutela e l’uso del territorio: per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, si è intervenuti sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, promuovendo il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato.
Secondo alcuni esperti, però, la legge non solo non era pensata per diminuire il consumo di suolo, ma anzi lo avrebbe facilitato. Nel volume collettaneo Consumo di luogo. Regresso neoliberista nel disegno di legge urbanistica dell’Emilia-Romagna, si legge: “Proclamando risparmio di suolo e qualificazione urbana, la legge va in senso opposto. Il limite del tre per cento posto all’espansione dei territori urbani, già in sé molto elevato, è aggiuntivo, non alternativo all’ulteriore occupazione di suolo che i piani urbanistici ammettono. E l’«addensamento» indiscriminato, concepito e ribadito come unico modo della rigenerazione urbana, non promette qualità, ma ecomostri”. Lo ribadisce anche Paolo Pileri, professore di Pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, che in un’analisi su Altreconomia scrive che la legge regionale 24/2017 “fa acqua da tutte le parti per quanto riguarda la tutela del suolo. E i nodi vengono al pettine”.
Nel 2018 la regione ha emanato la “Strategia per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici”. Il documento contiene, oltre a una valutazione approfondita del quadro delle emissioni regionali e degli scenari di cambiamento climatico futuri e in atto, un’analisi settoriale delle principali vulnerabilità e le azioni da intraprendere per ciascun settore fisico-ambientale ed economico. Tra queste c’era il potenziamento degli interventi per l’adattamento del territorio, il raddoppio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, il mantenimento e potenziamento del sistema di allertamento, il contrasto dell’erosione costiera, il rafforzamento del portale “Allerta meteo Emilia-Romagna”. Ma soprattutto, si invitavano “tutte le amministrazioni comunali a rinnovare i loro strumenti urbanistici, azzerando le previsioni di espansione e incentrando la nuova strategia su una rigenerazione urbana che incrementi nettamente la resilienza delle città e del territorio”.
Quali risultati sono stati ottenuti in questi anni? Secondo i dati forniti dalla piattaforma Rendis di Ispra, in Emilia-Romagna sono stati messi in cantiere 529 interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico dal 1999 al 2022 (il 4,7% delle opere totali a livello nazionale) di cui 368 risultano concluse (il 69,5%). L’importo totale dei soldi destinati alla prevenzione è stato di 561 milioni: di questi soltanto il 45% (258 milioni) è stato utilizzato per progetti che risultano ultimati.
Tra le opere più citate come decisive in caso di alluvioni ci sono le cosiddette “casse di espansione”, invasi costruiti per raccogliere l’acqua che fuoriesce dai fiumi durante le piene: secondo diversi esperti, però, in tutta la regione e soprattutto in Romagna non ne sono state costruite a sufficienza. E anche dove c’erano, con precipitazioni così intense sono state sostanzialmente inefficaci. Secondo un report della regione Emilia-Romagna che cita i dati dell’associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni (Anbi), in Emilia-Romagna ci sono 53 casse di espansione che possono raccogliere fino a 66 milioni di metri cubi di acqua. Le prime furono progettate negli anni Settanta, in seguito all’alluvione del 1973 a Reggio Emilia. Fino alla fine degli anni Novanta furono costruite prevalentemente nella pianura emiliana, una zona più a rischio di alluvioni, poi ne sono state realizzate alcune anche in Romagna.
Dall’inizio della legislatura di Stefano Bonaccini sono stati stanziati 190 milioni di euro per costruire 23 nuove opere idrauliche tra casse di espansione e bacini artificiali. Dopo la prima alluvione di inizio maggio, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei ha detto che al momento ne funzionano soltanto 12 sulle 23 nuove previste. Le altre sono in fase di progettazione o di realizzazione. Uno dei problemi è relativo ai costi, che per questo tipo di opere sono alti, anche per via degli espropri. “Le opere idrauliche sono finanziate o dalla Protezione civile o dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica”, ha spiegato la vicepresidente della Regione, Irene Priolo. “Quest’anno avremo dal ministero dell’Ambiente 13 milioni di euro contro i 22 ricevuti l’anno scorso. Finanziamenti irrisori, a fronte di una grande complessità anche per quanto riguarda il lungo iter autorizzativo”.
La strategia nazionale, da ItaliaSicura a ProteggItalia
Ma la prevenzione, oltre che sui territori, si deve fare nelle stanze del governo. Nel 2014 l’esecutivo guidato da Matteo Renzi creò ItaliaSicura, una “struttura di missione”, ossia un ente tecnico nato con un obiettivo specifico: prevenire i danni da dissesto idrogeologico con una serie di interventi da realizzare in una decina d’anni. Era formata da 16 tecnici provenienti da ministeri, dal dipartimento della Protezione Civile, da Invitalia (l’agenzia del governo che si occupa della crescita economica del paese) e da due esperti esterni: Erasmo D’Angelis e Mauro Grassi.
Parlando a Omnibus, su La7, D’Angelis ha detto che ItaliaSicura “ha realizzato il primo piano di opere e interventi regione per regione”: 10.361 opere, che potrebbero essere attuate ancora oggi, per un costo presunto intorno ai 30 miliardi di euro. L’idea era di stanziare ogni anno circa 3 o 4 miliardi di euro, ha spiegato D’Angelis, e farlo con una struttura che potesse lavorare anche con governi diversi per dare continuità agli interventi. Secondo il Sole 24 Ore, nei quattro anni in cui ItaliaSicura è stata attiva sono stati stanziati 8,2 miliardi di euro, messi insieme usando fondi non spesi da diversi ministeri: quei fondi però non vennero usati del tutto.
Secondo un’analisi della Corte dei Conti, tra il 2016 e il 2019 – ossia negli anni in cui ItaliaSicura era operativa – sono stati aperti (o riaperti) 1.445 cantieri, ma solo una parte è stata portata a termine: “Non sembra ancora essere compiutamente definita una vera e propria politica nazionale di contrasto al dissesto idrogeologico, di natura preventiva e non emergenziale, coerente anche con una politica urbanistica e paesaggistica, rispettosa dei vincoli ambientali, con interventi di breve, medio e lungo periodo”, scrive la Corte, che ha criticato anche il fatto che da un governo all’altro si cambiassero i processi decisionali per portare avanti gli interventi.
Nel 2019 il primo governo Conte ha chiuso ItaliaSicura, ritenendo che una struttura di missione rappresentasse un costo inutile. La gestione dei rischi di dissesto idrogeologico è stata riportata sotto al ministero dell’Ambiente, e ItaliaSicura è stata sostituita dal piano ProteggItalia, per cui è stato previsto uno stanziamento di 14,3 miliardi fino al 2030.
Sempre secondo la Corte dei Conti, però, nemmeno ProteggItalia è una soluzione efficace: “Permane la lentezza nell’adozione sia dei processi decisionali che di quelli attuativi, spesso condizionati da lunghi processi concertativi nazionali e locali”, si legge in un rapporto del 2021 sulla mitigazione del rischio idrogeologico. Il problema principale resta quindi la frammentazione dei processi decisionali, che coinvolgono ancora molti enti nazionali e locali.
Secondo il rapporto ReNDiS La difesa del suolo in vent’anni di monitoraggio ISPRA sugli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, lo stanziamento complessivo per la prevenzione nel periodo dal 1999 al 2019 ammonta a 6,6 miliardi di euro, per un totale di oltre 6mila progetti finanziati, a fronte di più di 26 miliardi di euro di richieste: una cifra che non soddisfa le necessità dei territori. Le maggiori risorse sono state assegnate alla Sicilia (789 milioni di euro), seguita dalla Lombardia (598 milioni), dalla Toscana (591 milioni), dalla Campania (486 milioni) e dall’Emilia-Romagna (454 milioni). Per quanto riguarda le tipologie di intervento, emerge una netta prevalenza di lavori finanziati per aree di frana, che rappresentano il 52% del totale.
Dopo la frana di Ischia, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha dichiarato che è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale, affidato a lui stesso, per ricostruire il quadro degli interventi anti-dissesto in corso. “Dal 2019 al 2027 sono stati messi a disposizione 21 miliardi per la tutela del territorio”, ha detto. Ma quali risultati abbia portato il gruppo di lavoro interministeriale non è chiaro. Di più: ancora oggi in Italia manca un vero e proprio Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (Pnacc), che è in sospeso dal giugno 2018, avendo attraversato, senza successo, ben quattro governi. Lo scorso dicembre il governo Meloni è riuscito a presentare ufficialmente una nuova versione del PNACC alla Conferenza delle Regioni, che si occuperà ora di effettuare la valutazione ambientale strategica. Al netto delle promesse, l’iter del PNACC è tornato esattamente allo stesso punto in cui si era bloccato la prima volta.
Il Pnrr: poche risorse per la gestione del rischio idrogeologico
Ora c’è la partita del Pnrr, che prevede lo stanziamento di 15 miliardi di euro per la “tutela del territorio e della risorsa idrica”, di cui 2,49 miliardi di euro vanno specificamente agli interventi “per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” (investimento 2.1). L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza 1,5 milioni di persone che attualmente vivono nelle aree a rischio idrogeologico, e di farlo entro marzo 2026. Ma le risorse potrebbero non essere sufficienti: “La scarsità delle risorse assegnate dal Pnrr in relazione alla stima complessiva della necessità di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sull’intero territorio nazionale implica la fondamentale importanza della corretta selezione dei progetti da finanziare”, si legge in una nuova analisi della Corte dei Conti di luglio 2022.
Di questi 2,49 miliardi di euro, 1,287 miliardi sono di competenza del Ministero della Transizione ecologica, destinati a rimborso spese per interventi già finanziati (e quindi non utilizzabili per nuovi interventi). I restanti 1,2 miliardi di euro sono assegnati al Dipartimento della Protezione civile: di questi, 800 milioni sono stati ripartiti tra le regioni. L’Emilia-Romagna ne ha ricevuti circa 61 milioni, con cui realizzerà 76 interventi che devono essere progettati, appaltati e contrattualizzati entro aprile 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025, per poi venire rendicontati entro il 30 giugno 2026. “Questi 61 milioni sono le uniche risorse da destinare a nuovi interventi, inoltre non esclusivamente ad interventi di difesa del suolo ma anche per il ripristino di infrastrutture danneggiate a seguito di eventi calamitosi e per la riduzione del rischio residuo sulla base di piani approvati dal Dipartimento della Protezione Civile”, ha fatto sapere la regione.
Accanto agli investimenti, il Pnrr prevede una riforma per semplificare e accelerare gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico, oltre che per rafforzare le strutture tecniche di supporto dei commissari straordinari, e le capacità operative delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province. “Ai fini del conseguimento dell’obiettivo finale, sarà decisiva la capacità di procedere tempestivamente all’affidamento e realizzazione dei lavori oggetto degli interventi previsti”, conclude la Corte dei Conti.
Immagine in anteprima: frame video LA7 via YouTube