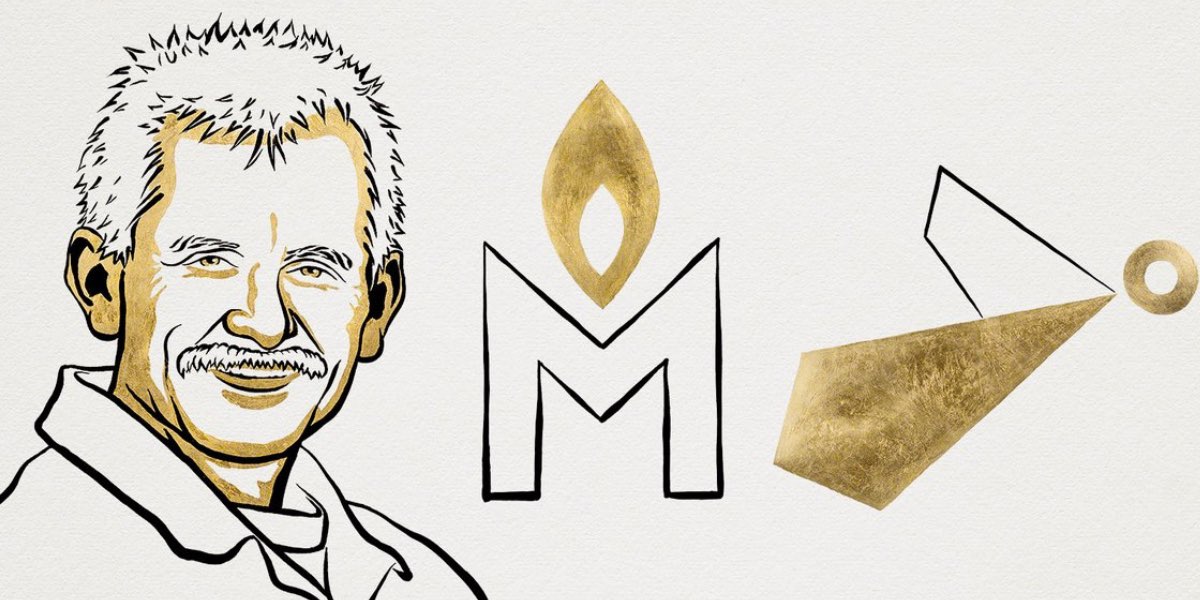Etiopia, dal premio Nobel per la pace alla guerra civile: la parabola del primo ministro Abiy Ahmed
7 min letturaEra l’ottobre 2019. Da Stoccolma arrivava la notizia del conferimento del premio Nobel per la pace al primo ministro di un paese complesso, confinante con un paese altrettanto complesso. Le cui relazioni erano sempre state difficili. Il primo ministro in questione era Abiy Ahmed Ali che solo un anno prima era salito al potere.
Le motivazioni del prestigioso riconoscimento stavano in quello storico accordo di pace che nel luglio 2018, dunque pochi mesi dopo avere assunto la guida dell’Etiopia, Abiy firmava con lo storico rivale, Isaias Afewerki, presidente dell’Eritrea dal 1993. Colui che aveva guidato il Fronte di liberazione del popolo eritreo che nel 1991 riuscì dopo un ventennio di lotta armata a conquistare l’indipendenza dall’Etiopia.
Il mondo allora esultò, ritenne possibile il superamento di contrasti etnici e azioni violente per rispondere a contrapposizioni interne e rivendicazioni politiche o territoriali e pose molta fiducia nell’operato di due uomini che si erano stretti la mano sorridendo e aprendo così la strada alla pace (o almeno era quello che si pensava).
Alla luce degli avvenimenti futuri, oggi non sono pochi ad affermare che quella stretta di mano dinanzi al mondo intero tra il neo primo ministro e il tirannico presidente dell’Eritrea e quella firma storica, non implicavano semplicemente un accordo di pace, o relazioni fraterne tra due paesi la cui storia è tanto intrecciata l’una all’altra ma piuttosto una sorta di alleanza politica in vista di un futuro (e previsto) confronto con il TPLF (Fronte popolare di liberazione del Tigrè).
Confronto che non tardò a manifestarsi. Nel novembre 2020, a un anno dal conferimento del prestigioso premio cominciava la crisi, e poi la guerra, con il Tigray. Il motivo ufficiale furono le elezioni svoltesi nel 2020 nella regione settentrionale del paese, il Tigray appunto, nonostante il primo ministro avesse deciso di posporle a causa della pandemia in corso. Una scusa, secondo le opposizioni, per mantenere la situazione in stallo e, ovviamente, il potere così com’era distribuito.
Quella riconciliazione tra gruppi etnici – nel paese ne sono stati censiti oltre 80 – tanto auspicata mostrò subito una sorta di impossibilità endemica. Quelle elezioni che avrebbero dovuto rappresentare la pietra fondante della nuova democrazia in Etiopia si rivelarono il punto d’avvio di un nuovo disastro.
Non dimentichiamo che nel 2019 Abiy, nel tentativo di reinventare la politica del paese, aveva smantellato il Fronte democratico rivoluzionario popolare etiope (EPRDF), probabilmente il partito più grande, potente e autocratico d’Africa. Al suo posto ne venne formato uno nuovo, guidato dal nuovo primo ministro, il Partito della Prosperità (PP). Partito che di fatto ha eliminato la struttura di coalizione etnica che costituiva l'EPRDF: il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, il Movimento Democratico Nazionale Amhara (poi Partito Democratico Amhara), l'Organizzazione Democratica del Popolo Oromo (poi Partito Democratico Oromo) e il Movimento Democratico Popolare dell'Etiopia Meridionale. Una mossa che non è piaciuta soprattutto al TPLF. Il grande partito di coalizione, l'EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) era stato fondato nel periodo della guerra civile etiope e aveva combattuto e rovesciato il regime dittatoriale del Derg, una giunta militare di stampo socialista. Inoltre aveva avuto il compito di rappresentare le diversità delle componenti del paese, un paese a sistema federale, voluto per gestire le varie etnie che lo compongono.
Se poi l’intenzione di Abiy era, attraverso il nuovo partito, superare divisioni politiche ed etniche, il risultato è stato quello di farle tornare alla luce. Nel novembre 2020 il governo etiope avviò le operazioni militari nella regione del Tigray contro il partito al governo della regione, il Fronte di liberazione popolare del Tigray, appunto. Azioni sostenute dalle forze armate eritree. Del resto tra Eritrea e Tigray la disputa è annosa e risale ai tempi del Derg, quando si combatteva insieme per poi, una volta liberatisi dell’oppressore, avviare dispute su mai risolte questioni di confine e di potere.
Il conflitto tra il governo centrale etiope e le forze del Tigray è durato due anni e si è concluso con l’accordo firmato in Sudafrica nel novembre 2022, con costi davvero alti (come sempre accade) per la popolazione civile. Milioni di persone hanno abbandonato le proprie case e molti ancora non vi hanno fatto ritorno e tanti sono fuggiti in Sudan dove è in corso ormai da oltre un anno un’altra disastrosa guerra e che ha già la sua crisi umanitaria da gestire. Tant’è che oggi è da lì che si scappa in un inverso ordine di disperazione, oltre 133.000 sudanesi si sono rifugiati in Etiopia per fuggire alla guerra nel loro paese.
Del conflitto nel Tigray non vanno dimenticati gli stupri e le violenze contro le donne continuati, si è denunciato, anche dopo la firma dell’accordo. E ancora, terreni agricoli distrutti, il 90% delle strutture sanitarie fuori uso, oltre 3 milioni di sfollati, relazioni umane compromesse. Mentre ai morti nel conflitto, si parla di 600.000 persone, si aggiungono quanti stanno morendo di fame. Sarebbero centinaia di persone solo negli ultimi mesi.
In questo contesto, ritorna in tutto il paese, l’incubo del 1984 quando una terribile carestia, seguita a un periodo di estrema siccità, portò il paese al collasso. Secondo l’OCHA (Ufficio degli affari umanitari delle Nazioni Unite) oltre 20 milioni di etiopi hanno bisogno di aiuto e la maggior parte di loro sono nel Tigray. Non ha risolto l’emergenza il ripristino degli aiuti umanitari da parte di USA e ONU dopo una sospensione di alcuni mesi a seguito della scoperta di furti di enormi quantità di cibo destinato alle popolazioni. Una guerra ora finita sì, sulla carta, ma che di fatto tiene ancora in ostaggio le persone e la loro vita.
All’inizio di questo mese il New Lines Institute, think tank con sede a Washington D.C., ha rilasciato un report la cui sintesi è: ci sono prove convincenti che le forze etiopi abbiano commesso atti di genocidio durante la guerra del Tigray. E anche dopo. E questi atti di genocidio hanno visto coinvolte tutte le forze in campo. Comprese le forze militari eritree.
Chi pagherà mai per le atrocità commesse e che sono state individuate come crimini di guerra e crimini contro l’umanità? Non mancano - evidenziate da Human Rights Watch – investigazioni, prove, evidenze di vario tipo. Quello che manca è un banco degli imputati. Una giuria e condanne, che forse non arriveranno mai.
Terminato, in un modo o nell’altro, il conflitto nel Tigray, è cominciato quello dell’Amhara, regione centro-settentrionale dell’Etiopia. Ennesima dimostrazione della frammentazione del paese. Le milizie Amhara avevano combattuto a fianco delle truppe federali nella guerra del Tigray del 2020-2022, ma quell’alleanza è crollata quando il governo federale e i leader del Tigray hanno raggiunto l’accordo che ha posto fine al conflitto. A quel punto il primo ministro Abiy Ahmed non è riuscito a tenere a freno le milizie Amhara che ormai portavano avanti le loro rivendicazioni. Il conflitto, secondo alcuni osservatori, potrebbe estendersi fino a una più ampia guerra civile. E provocare così un disastro umanitario su più vasta scala.
E se lo stato delle cose non fosse già sufficientemente critico, si aggiunge la questione sempre aperta con il gruppo ribelle Omoro Liberation Front (OMF). L’Oromia è la più grande e popolosa regione dell’Etiopia ed è da questa regione che proviene Abiy. Inoltre Amhara e Oromo sono i due gruppi etnici più grandi del paese e insieme costituiscono la spina dorsale della coalizione di governo.
Già qualche anno fa, appena scoppiata la guerra in Tigray, si sottolineava il rischio di una frammentazione politica del paese con differenti regioni incapaci o assai poco propense a cooperare e strette intorno ai loro confini etnici. Confini di natura geografica e sociale. Una sorta di balcanizzazione in quello che è lo Stato più esteso e con la più alta popolazione del Corno d’Africa. Sicuramente strategico per la stabilità di quella parte del continente. Una stabilità cruciale per i 300 milioni di persone che ci vivono, ma anche fondamentale per gli interessi dell’UE, anche perché oltre il 20% delle esportazioni e importazioni dell’UE passa al largo delle coste orientali del continente africano.
È stato forse anche nel segno della speranza che facesse da faro e nello stesso tempo cuscinetto nella regione, che il premio Nobel per la Pace fu assegnato ad Abiy Ahmed. E che lo stesso registrò l’appoggio di tanti leader mondiali: dagli USA all’Europa. Le opinioni sarebbero le stesse oggi?
Intanto l’asse delle relazioni si sposta verso il mondo arabo. Precisamente gli Emirati Arabi Uniti con cui lo scorso anno il governo di Addis Ababa ha firmato 17 accordi di cooperazione in vari settori. Per lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan un’altra opportunità di stringere legami - come sta facendo da tempo - con quella parte d’Africa; per Abiy un nuovo alleato. Alleato che tra l’altro aveva già dimostrato il suo sostegno fornendo armi proprio durante il conflitto nel Tigray. Mentre ad aprile scorso un altro pacchetto di aiuti è stato stabilito dagli USA e dai paesi europei per affrontare la crisi umanitaria e le conseguenze del cambiamento climatico nel paese.
Un’altra delle domande che oggi ci si pone sul primo ministro etiope è se c’era stata davvero la volontà di portare il paese fuori dalle logiche delle fazioni, delle rivendicazioni regionali, delle vecchie e nuove rivalità etiche. O magari c’era stata una sincera speranza che ciò avvenisse. O se proprio le complicazioni sono troppe e sarebbe stato difficile per chiunque affrontarle, sistemarle.
Certo è che oggi l’Abiymania sembra essere finita. Quel Nobel infiammò la fiducia nell’uomo della pace. Mentre pace proprio non c’è. Non c’è a causa di quei conflitti ancora in corso. Non c’è per i 3,5 milioni di sfollati. Non c’è a causa della fame e dell’insicurezza alimentare causata dalla peggiore siccità dal quel terribile biennio 1983-1985. Non c’è per quegli oltre 1 milione e mezzo di rifugiati e richiedenti asilo presenti nel paese e che provengono principalmente da Sud Sudan, Sudan, Eritrea e Somalia (l’Etiopia paradossalmente è uno dei paesi che ospita più rifugiati in Africa, oltre a generarne). Certo il quadro con questi numeri appare desolante e non dà la misura della dinamicità e molteplicità di aspetti del paese. Ma non possiamo fare a meno di sottolineare la difficoltà di risolvere conflitti che nascono proprio da una così multiforme realtà sociale. Che in questo caso, soprattutto, vale a dire etnica.
Immagine in anteprima via flickr.com