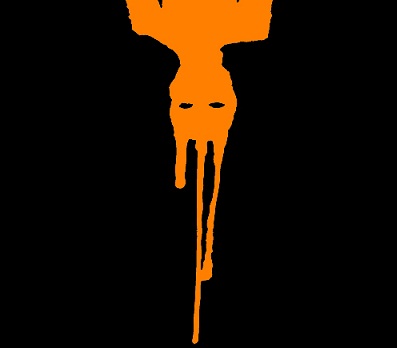Voi, onesti farabutti
5 min letturaVa di moda parlare di conflitto generazionale, di rottamatori, di generazioni perdute. L'estetica di questa moda - aggressiva, di superficie - unita alla pigrizia intellettuale e morale, è forse il motivo per cui se ne parla. Perché il mondo disegnato da certi frame è tanto chiassoso quanto evanescente, appena si mette il naso fuori di casa e si sbatte la testa contro la realtà; specie quando ci si fa male nell'urto. Perché l'operaio dell'Ilva non deve certo i propri drammi al padre, ma nel grande circo dell'informazione si volteggia di continuo, e non resta mai troppo spazio di manovra per fare 2+2, o per guardarsi intorno. O dentro.
Voi, onesti farabutti di Simone Ghelli è un salutare anticorpo contro questa moda, perché affronta sul terreno letterario il rapporto tra due generazioni: quella dell'autore, classe 1975, e quella del nonno, che ha conosciuto la Resistenza. In questo rapporto non c'è spazio per le retoriche che triturano e livellanno la complessità del reale:
e pensare che siamo arrivati al punto che: ad esempio, i giovani contro i vecchi; alla guerra tra poveri, insomma, che non guasta mai.
Abbiamo così due generazioni unite dalla sconfitta, avendo combattuto guerre diverse. Il nonno ha combattutto una guerra classica, seguendo ideali che la società dei consumi e il conformismo hanno però tradito. I segni di questa sconfitta e del relativo trauma sono esteriori, incarnati dalla ferita invalidante causata da un incidente sul lavoro, che vale all'ex partigiano il benservito dell'azienda:
la ditta per cui lavorava non gli diede neanche una lira; piuttosto gli fecero firmare certi fogli che a sentir loro c’era anche di che ringraziarli: fortuna che non l’avevano denunciato, l’ammonirono, perché poteva starci anche il sospetto di sabotaggio.
L'autore invece ha conosciuto una diversa frontiera, quella del «manicomio», in cui è stato costretto a svolgere il servizio civile. È una frontiera figlia di una società che nell'accelerazione del boom economico ha imparato a disfarsi di chi resta indietro, senza troppi clamori:
a quei tempi, quando il paese correva veloce, al manicomio ci si finiva per convenienza: della famiglia, della politica, della comune morale. A correre si perdevano i pezzi per strada; o piuttosto, si facevano sparire. Il resto lo fecero i bisogni, l’istinto alla sopravvivenza.
È una frontiera di sconfitti in partenza. I pazienti combattono una guerra portata a forza sul piano interiore, di chi subisce senza possibilità di far comprendere l'inutilità di quella violenza. L'incontro con l'autismo di Giovanni è il presagio, colto solo in seguito, di cosa succederà all'indole anarchica dell'autore, cui la vita da precario concederà al massimo di scegliere tra implosione ed esplosione:
l’avessi saputo allora, che nell’autismo di Giovanni era imprigionato il mio futuro, m’avrebbe spaventato di meno quella sua violenza repressa: come la volta che rubò la forchetta di metallo per trapassarci il dorso della mano di un altro paziente. «Ma perché lo fa?» chiesi ingenuamente. Oggi, posso solo immaginare che lo facesse per non scagliarsela contro; come viene a volte di fare a me: per vedere se ancora mi avanza del sangue, a forza di sopportare.
Il legame tra nonno e nipote è basato su un comune spirito combattivo che però al massimo riesce a farsi empatia, senza possibilità di tradursi in forme di lotta tese a modificare le gerarchie sociali. Questo spirito è presente in due nuclei che si sostengono e si alimentano a vicenda, come fossero i centri di gravità attorno cui ruota la scrittura di Ghelli.
Il primo centro di gravità è l'esercizio della memoria attraverso la lingua. L'uso dei toscanismi - Ghelli è livornese - in Voi, onesti farabutti è un'operazione di recupero dei luoghi d'origine, di resistenza delle proprie radici rispetto alla lingua della capitale, dove l'autore si è trasferito per lavoro:
Ti scrivo per difendere un luogo, per strapparlo con le unghie a una retorica fatta di menzogne. [...] Col tempo ho finito per giustificare tutto, persino la perdita della mia lingua; persino la cadenza romana, un po’ sguaiata, che mi s’è attaccata addosso…
Non è l'uso di termini o espressioni a essere caratteristico («succiare», «ti allega la bocca», «chiorba», «in quel budello di strada»); lo è piuttosto la ricerca di ritmi, figure retoriche o simboli prossimi al mondo popolare del nonno. Al netto di alcuni esuberi («che cacciucco di opinioni che c'hanno condito!») , lingua e stile costruiscono per accumulo e coesione uno spazio di senso vitalissimo:
il mio tempo funzionava come la fisarmonica che ancora garba tanto al nonno: l’allargavo dove mi faceva comodo, per farci entrare anche la mia, di storia.
Efficace e peculiare è il ritmo, con periodi paratattici dove punteggiatura e modi di dire scandiscono pause da racconto orale:
Allora gli calo un altro goccio e me ne verso anch’io, così si butta giù il boccone amaro in due, una corsa pazza fino al caffè: e dice a tutti che meno male che gli è rimasto almeno un nipote attaccato alle sue stesse idee, che gli sta appresso col rosso insomma; perché al colore gli altri non ci guardano più, con questa storia che son tutti uguali, e a destra e a sinistra.
Questa vitalità così espressa giustifica sulla pagina l'avversione al conformismo di massa degli «onesti farabutti». Ma è una resistenza esclusiva della letteratura, e il poterla vivere solo entro questi confini sposta Ghelli sull'altro centro di gravità del romanzo: l'elegia incandescente. Nella parte finale l'autore dà voce al senso di sconfitta e smarrimento, facendone un grido scagliato contro l'ineluttabilità divorante. Nel dolore per il nonno scomparso tocca corde profonde, rivela un pathos che non ti aspetteresti da un narratore focalizzato sui ricordi e sulla nostalgia (a tratti persino troppo introverso). Cavalca l'onda emotiva senza perdere la misura o lo stile, riscaldando entrambi:
Diglielo, nonno, che non son scappato mai: che la paura l’ho vista in faccia, che in quelle trincee i matti ci morivan come mosche, a forza di sedarli, di addormentarli. E a noi vorrebbero dare la stessa terapia, dagli aghi delle antenne, nonno; vorrebbero iniettarci il loro immaginario e distillarlo con la flebo: altro che vino, altro che aglio. [...] tutto ci sembrerà di troppo: troppa libertà, troppa democrazia; chiederemo soltanto un po’ di pace, d’esser governati come galline. Lo sai, nonno, che noi che resistiamo ci diranno folli, che neanche un busto in pietra ci faranno: che cadremo senza rumore, senza monumenti. Ci faremo coraggio versando un sorso di vino in terra, brindando coi nostri morti, che almeno sapessimo quanti. [...] Nessuna macchia, né fronde verdi, soltanto pioggia. E non saranno lacrime, nonno: soltanto pioggia, che ci mangerà la carne, nel silenzio di quelli andati altrove a cercar fortuna.
Che cosa resta, una volta terminato Voi, onesti farabutti? Resta il senso di sconfitta violenta che la Storia ha inflitto a priori a un'intera generazione. Il punto di vista adottato non dà conto delle ragioni; della sconfitta Ghelli riesce solo a mostrare - ed è un risultato sofferto, conquistato - effetti e sintomi. Ma nel farlo ritaglia uno spazio salvifico, lontano da quel circo dell'informazione in cui si preferisce chiamare «perduto» ciò che si è «distrutto»; in cui si gioca a trovare il colpevole per tenersi a distanza di sicurezza dalle macerie. Attraverso la scrittura Ghelli va invece in quelle macerie e recupera ciò che altrimenti sarebbe andato perso, tracciando una rotta catartica.